Jesús Moncada: Il testamento dei fiumi
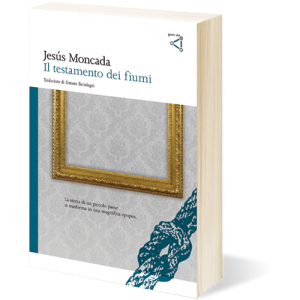
(Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, le prime pagine del romanzo di Jesús Moncada “Il testamento dei fiumi”, traduzione di Simone Bertelegni, gran vía, 2014)
Pilastri e pareti portanti si spezzarono in due bruscamente; un frastuono assordante in cui si mescolavano lo scricchiolio di travi e montanti, lo schianto di scale, soffitti, tramezzi e volte, vetri in frantumi, mattoni, tegole e piastrelle sbriciolate, rimbombò lungo baixada de la Ferradura mentre la casa crollava senza scampo. Subito una nuvola di polvere, la prima di quelle che avrebbero accompagnato la lunga agonia che aveva inizio allora, si sollevò sull’abitato e si sfilacciò a poco a poco nell’aria tersa del mattino primaverile.
Anni dopo, quando la sventura cominciata quel giorno del 1970 era un lontano ricordo, tempi ricoperti da ragnatele di nebbia, una cronaca anonima raccolse una gran quantità di sconvolgenti testimonianze sulla vicenda. La prima dal punto di vista cronologico – sebbene non la più emozionante – registrava l’arresto dell’orologio del campanile il giorno prima, durante una serata tempestosa che aveva dipinto il cielo della città di carminio violaceo, oro pallido e nere foschie; secondo il cronista, il guasto era una chiara premonizione di quanto sarebbe accaduto l’indomani, un annuncio dell’inesorabile fine dei vecchi tempi. L’angoscia diveniva raccapriccio per colpa della descrizione, dovuta a un’altra testimonianza, della notte cui aveva ceduto il posto l’incertezza del crepuscolo: la cronaca riferiva del silenzio denso nelle vie deserte, silenzio che voleva riflettere quello della gente tappata in casa, a pregare che non facesse giorno. Eppure, tra i ricordi di maggior impatto, c’era quello del rimbombo sinistro alle undici del mattino seguente in baixada de la Ferradura: secondo la cronaca, gli abitanti furono scossi sino alle ossa dall’inizio del disastro. Senza dubbio le testimonianze risultavano sconvolgenti. Ebbene, questa non era l’unica caratteristica che avevano in comune; ne condividevano un’altra, forse insignificante e tuttavia in grado di chiarire quanto accaduto in quel giorno nefasto: tutte, senza eccezione alcuna, erano anche assolutamente false.
* * *
Tanto per cominciare, Honorat del Rom, uno dei due farmacisti del paese, campato abbastanza da poter convivere con l’apparizione della cronaca, chiariva in alcuni commenti ironici sul documento che l’orologio municipale, installato sul campanile della chiesa, non si era guastato l’11 aprile del 1970. Quel ferrovecchio, carico d’anni e piuttosto ammaccato, si inceppava spesso e non sorprendeva affatto vederne le lancette immobili nel quadrante; ma quel giorno funzionava e, a voler cercare il pelo nell’uovo, gli si poteva rinfacciare soltanto di essere sette o otto minuti avanti rispetto all’ora ufficiale. Ciò, a detta del farmacista, smentiva completamente la supposta premonizione degli avvenimenti dell’indomani attribuita all’orologio e permetteva di accantonare qualsiasi altra speculazione sull’argomento.
Nemmeno la storia della serata tempestosa combaciava coi fatti. Nessuno metteva in dubbio che, qualora si fosse prodotta così come narrava la cronaca, sarebbe risultato uno scenario particolarmente adatto al preludio del dramma. Sfortuna volle che fosse un crepuscolo insipido, nient’affatto paragonabile alla media di quelli che il paese godeva di solito, per tacere dei più spettacolari, che il farmacista non si prendeva neanche la briga di citare; quello in questione fu parzialmente guastato dal vento del mare, il libeccio, lungo la valle dell’Ebro: i suoi rossori avevano insanguinato senza nerbo i moli presso cui marcivano a poco a poco le vecchie imbarcazioni del paese, prima di scivolare controcorrente e scomparire a ovest, come tutti gli altri, tra scintillii violacei senza infamia e senza lode.
La notte si rivelò insignificante tanto quanto il crepuscolo: di una cupezza volgare. Tenebre a parte, sempre piuttosto inquietanti, nulla spingeva ad attribuirle una tensione insolita, ossia più profonda di quella sopportata senza tregua per lungo tempo dal paese, già innestata sulla vita quotidiana. Dal giudice di pace – deluso senza speranza dal fascino appassito della giudicessa e impegnato con una cugina del segretario municipale in un amplesso fatto di movimenti lenti, vigorosi e profondi, mentre lei si scioglieva in un gemito sofferente sopra il tavolo del tribunale, sgualcendo con le natiche il registro dei certificati di morte – sino al metronotte, sempre su e giù per le vie come il setaccio di un panettiere, gli abitanti trascorsero la notte come sempre. Di sicuro l’unica eccezione era costituita da Pasqual de Serafí: steso vestito di tutto punto sul letto matrimoniale, nel mezzo della cantilena snervante del lutto famigliare, scontava la morte che l’aveva sorpreso a metà pomeriggio mentre leggeva un quotidiano sportivo dal barbiere. Niente di straordinario – giacché il paese disponeva di rituali secolari con cui attenuare anche la presenza della morte – alterò dunque le ore e, mentre l’alba risaliva l’Ebro e accendeva di scintillii sfuggenti la vernice del berretto, l’acciaio della picca e i bottoni dorati dell’uniforme del metronotte – che stava percorrendo carrer de les Bruixes per andare a dormire –, il paese riposava placido.
I primi bagliori rossastri dell’alba scalarono il muro che costeggiava l’Ebro partendo dai leuti ormeggiati ai moli silenziosi, e si aggrapparono lentamente all’intonaco ruvido delle case abbarbicate al versante della montagna dominato dal castello. La luce del giorno faceva sempre fatica a penetrare nell’intrico di vie e vicoli. Gli abitanti avevano vissuto per circa un secolo tra le miniere di lignite, e la polvere di carbone si era appiccicata loro addosso quasi come una pelle d’ombra; gli edifici, su cui le imbiancature risultavano effimere, la gente, persino i fiumi, sempre solcati da imbarcazioni nere e coi fondali oscurati dal carbone disperso nei naufragi, sembravano aver ricevuto la stessa patina. Alla fine però, come tutte le altre mattine, la luce, quando ormai i primi rossori impallidivano, riuscì a scavare le ombre: l’antica, decrepita e spesso maledetta sagoma fece capolino, ocra e nera, tra le tenebre. Le strade iniziarono a fremere di una vita intensa, sebbene provvisoria. Orbene, al contrario di ciò che avrebbero affermato in futuro con tanto pathos le testimonianze raccolte dalla cronaca, l’avvenimento delle undici del mattino passò inosservato quasi a tutti. Il paese non rimase in sospeso, i cuori non smisero di battere; il frastuono non si dipanò come un rullo di tamburi funebre per vie e piazze, non risuonò nella valle dell’Ebro né lungo le rive del Segre né sui moli silenti né nelle miniere abbandonate come un annuncio di sventura. Fu un tuono breve in un paese talmente abituato a udire le esplosioni della dinamite da non farci caso. Si diffusero altre fandonie che – curiosamente, giacché erano false tanto quanto le prime – non furono raccolte dall’anonimo cronista. Eppure, erano anch’esse parte della ragnatela spessa con la quale gli abitanti del paese cercavano di soffocare il tarlo della cattiva coscienza. In fondo, era questa la giustificazione segreta della cronaca, ciò che la rendeva attendibile dalla maggior parte di coloro che vissero gli avvenimenti.
Perché, dopo anni e anni a parlarne di continuo, a fantasticarci sopra, a presentirne l’angoscia (nei tarocchi della vecchia Caterina comparivano fenomeni strani, sussulti dagli inferi), ecco che, a eccezione di Honorat del Rom, il farmacista, che si trovava dolorosamente piantato all’angolo tra carreró de l’Ham e baixada de la Ferradura, nessuno si rese conto dell’accaduto. E sebbene nulla sarebbe cambiato in caso contrario, poiché ormai il destino era irreversibile, anni dopo – quando l’incubo sinistro era un ricordo polveroso, un grumo di cenere – alcuni abitanti iniziarono a tessere testimonianze apocrife per far bella figura dinanzi alla storia. Tuttavia non tutto si poteva trovare nelle cronache o si poteva controbattere. Sarebbe stato inopportuno affermare, per esempio, che Llorenç de Veriu, a dar retta alle dicerie che correvano per bar e capannelli, fosse venuto a conoscenza della cosa; alcuni sostenevano che fosse giunto in paese per vedere un’ultima volta la casa in baixada de la Ferradura, quella che aveva costruito con le sue mani nel 1936, quando lui e Carme Castell volevano sposarsi. Molti preferirono credere che la notizia, se mai gli era giunta, non poteva più riportare in vita i resti di Llorenç, polvere inerte e anonima sotto la lontana terra incolta attorno a Teruel, dove trent’anni prima, durante la Guerra Civile, l’aveva falciato una mitragliatrice fascista.
* * *
Gli abitanti sbagliavano a ostinarsi a rendere il 12 aprile del 1970 una data chiave del loro dramma collettivo, così come sbagliavano a sentirsi colpevoli per non aver assistito all’avvenimento. La demolizione del civico 20 di baixada de la Ferradura, origine della rovina del paese – e l’azzardo burocratico indicò quello, così come avrebbe potuto designarne qualsiasi altro tra quelli vuoti –, non fu altro che l’inizio dell’ultimo atto di un lunghissimo incubo. Quando le ruspe tirarono i cavi d’acciaio avvinti ai pilastri e l’edificio cadde in una nuvola di polvere, la distruzione del paese era già in corso da tredici anni.

