La mala ora dell’Ultraliberismo
Viviane Forrester, Una strana dittatura, traduzione di Fabrizio Ascari, TEA, 2003.
Viviane Forrester (qui in uno scatto di Jean-Marc Armani) è morta l’anno scorso. Era di nazionalità francese. E di origine ebraica. Conosceva Georges Perec. Ho saputo di lei grazie a una bellissima videointervista a Perec degli anni Settanta, tuttora reperibile in rete e già citata in un mio articolo cortesemente ospitato da NI. Qui i modi fascinosi della Forrester fanno da contrasto con la voce burbera di Perec, lei in un cappottino scuro con una cintura che le stritola la vita, lui con un montone dal bavero alzato, i capelli e il pizzetto da scienziato pazzo, il suo gesticolare ossessivo. Il video è girato nei pressi di rue Vilin, le prime inquadrature proprio davanti a quello che era stato il negozio di parrucchiera della madre di Perec, deportata e morta probabilmente ad Auschwitz. Dalla descrizione di quei luoghi, oggi completamente stravolti, Perec prende spunto per parlare del suo ultimo libro e per illustrare quello che sarà il suo progetto più grandioso: La vita istruzioni per l’uso. La Forrester sorride, ascolta, fa domande con voce cinguettante, non lo chiama né monsieur Perec, né Georges ma per intero: Georges Perec, dandogli del Voi (che è poi il Lei francese).
Ebbene, mai avrei pensato che una figura tutta delicatezza e femminilità potesse sfoderare gli artigli da leone in un pamphlet pieno di rabbia trattenuta, centottantasei paginette che sono una sorta di “j’accuse” moderno lanciato contro un’intera ideologia: l’ultraliberismo. Lo fa, la Forrester, con un linguaggio lucido e tagliente come un bisturi che non accusa nessuno in particolare se non l’instaurarsi di una forma mentis pericolosissima che si pone come unico obiettivo il profitto in sé, a scapito di tutto e di tutti, anche della distruzione dell’intero pianeta e del suo tessuto sociale.
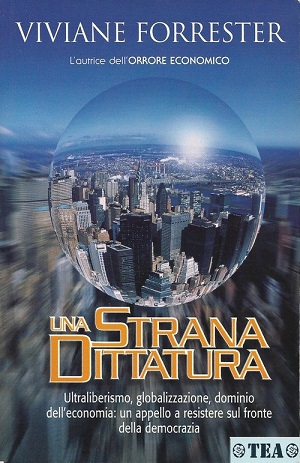 Una strana dittatura è un libro indignato e per gli indignati che ha come unico scopo far aprire gli occhi e mostrare la verità. Uscito nel 2000 per la Librairie Arthème Fayard, e lo stesso anno in Italia per Ponte alle Grazie, fa specie che le edizioni TEA – di cui a fatica ho reperito una copia – l’abbiano riproposto con una copertina bruttina e fuorviante, che sembra quasi uno di quegli Urania o di quei vecchi romanzi di spionaggio tradotti alla bell’e meglio e venduti in edicola. Il suo messaggio, condensato in pochi concetti che attraversano il libro come un leitmotiv incalzante, ruota intorno all’idea di una oligarchia che ha ormai in mano le redini del mondo e sta portando tutti verso il baratro senza che i più non solo l’accettino come un’irreversibile evoluzione storica, ma neppure si rendano conto della catastrofe, né – proprio per questo – tentino di opporsi.
Una strana dittatura è un libro indignato e per gli indignati che ha come unico scopo far aprire gli occhi e mostrare la verità. Uscito nel 2000 per la Librairie Arthème Fayard, e lo stesso anno in Italia per Ponte alle Grazie, fa specie che le edizioni TEA – di cui a fatica ho reperito una copia – l’abbiano riproposto con una copertina bruttina e fuorviante, che sembra quasi uno di quegli Urania o di quei vecchi romanzi di spionaggio tradotti alla bell’e meglio e venduti in edicola. Il suo messaggio, condensato in pochi concetti che attraversano il libro come un leitmotiv incalzante, ruota intorno all’idea di una oligarchia che ha ormai in mano le redini del mondo e sta portando tutti verso il baratro senza che i più non solo l’accettino come un’irreversibile evoluzione storica, ma neppure si rendano conto della catastrofe, né – proprio per questo – tentino di opporsi.
Esagerazioni? Discorso da comunisti? Mire sovversive? È istintivo porsi domande di questo tipo proprio perché questo sistema ideologico fondato “sul dogma (o sul fantasma) di un’autoregolazione dell’economia di mercato”, questa “strana dittatura” che controlla ormai la globalizzazione, rende inverosimile la verità e condiziona a tal punto l’opinione pubblica da far credere storicamente inevitabile ciò che non lo è, dando per assodato il fatto che sia la cibernetica la causa di tutto e non lo sia piuttosto l’uso e il successivo sfruttamento a cui è stata sottoposta.
Ma partiamo da un termine abusato e che la Forrester definisce “perverso”: la globalizzazione. L’ultraliberismo è riuscito a trasformare questo concetto in un sinonimo di liberismo: “Quando parliamo di globalizzazione (definizione passiva e neutra dello stato del mondo attuale), è quasi sempre di liberismo (ideologia attiva, aggressiva) che in realtà si tratta; e questa confusione permanente consente di far passare ogni rifiuto di tale sistema politico, delle sue operazioni e delle loro conseguenze, per rifiuto della globalizzazione e dell’amalgama su cui essa poggia, il quale include i progressi della tecnologia. Facile allora, per i cantori del liberismo, liquidare i loro oppositori con un’alzata di spalle o un sorrisetto beffardi, farli passare per insopportabili retrogradi che, sprofondati nel ridicolo, infiacchiti nell’arcaismo, si ostinano a negare la Storia e a rinnegare il Progresso” (…) “Dimentichiamo che la globalizzazione non necessita di una gestione ultraliberista, e che quest’ultima rappresenta soltanto un metodo (del resto calamitoso) fra i tanti possibili. In poche parole, la globalizzazione non è la stessa cosa dell’ultraliberismo – e viceversa!”
Allo stesso modo la propaganda ultraliberista ha imposto termini ed espressioni che “hanno il dono di persuadere senza bisogno di discussioni”. Ecco allora il mercato libero (di fare del profitto, aggiunge la Forrester), le ristrutturazioni (smantellamenti di imprese o comunque disintegrazioni delle loro masse di lavoratori), o i deficit pubblici da combattere, che sono in realtà – sempre la Forrester – benefici per il pubblico: “Le spese giudicate superflue, addirittura nocive, hanno l’unico difetto di non essere redditizie e di essere perdute per l’economia privata, quindi di rappresentare mancati profitti per essa insopportabili. Ora, queste spese sono vitali per i settori essenziali della società, in particolare quelli dell’educazione e della salute”. La propaganda finisce così per legittimare deregolamentazioni, delocalizzazioni, fughe di capitali e un’economia di mercato costruita su forme sempre più speculative.
Il libro è stato scritto nel 2000. Prima pertanto dell’abbattimento del potere d’acquisto di stipendi e pensioni con l’entrata in vigore dell’Euro (2002), e prima ancora dell’inizio della crisi economica (2007/2008). Eppure l’ideologia ultraliberista era già avviata nella sua allucinante politica di fusioni e di licenziamenti finalizzati soltanto ad aumentare il profitto. La Forrester cita numerosi esempi, come il gigante della telefonia americana ATT che nel 1996 annuncia 40.000 licenziamenti e, subito dopo, vede pubblicato sui giornali lo stipendio del suo direttore generale, Robert Allen, con 16,2 milioni di dollari: triplicato rispetto l’anno precedente pur non avendo al suo attivo nessuna realizzazione di utili se non solo quei 40.000 licenziamenti. Oppure l’Alcatel, 15 miliardi di franchi di utili nel 1996, che annuncia 12.000 licenziamenti, portando a 30.000 quelli che ha effettuato in quattro anni. Oppure ancora la Michelin che durante il primo semestre del 1999 ha un rialzo di utili del 17%, con prospettive favorevoli, e contemporaneamente licenzia 7.500 dipendenti, cioè un decimo degli effettivi, scaglionato in tre anni. In tutti i casi, come negli altri citati dalla Forrester, i titoli in Borsa hanno rialzi prodigiosi: “Gli annunci dei licenziamenti entusiasmano gli azionisti, li stimolano ancora più degli utili”. La propaganda – per constatarlo basta seguire qualche telegiornale – giustifica tutte queste manovre, in Francia come in Italia, come nel resto del mondo. E le scandisce con frasi di rito: la globalizzazione obbliga… la competitività vuole che… e poi l’occupazione dipende dalla crescita, la crescita dalla competitività, dalla capacità di sopprimere posti di lavoro. Vale a dire: per lottare contro la disoccupazione, niente di meglio dei licenziamenti. Certo, questa sì che è una tesi coerente.
Ma la Forrester affonda sempre più il dito nella piaga: la scure dei licenziamenti pesa sui lavoratori superstiti e sulle poche nuove assunzioni a termine esasperando il gioco al ribasso del costo del lavoro e diffondendo nella stragrande maggioranza l’angosciosa minaccia di finire ad ingrossare le file dei disoccupati, spingendo ad accettare sottomissioni e costrizioni sempre più opprimenti. Si arriva così a quelli che già chiamano working poor, ossia lavoratori poveri. Gli Stati Uniti ne sono pieni, così come sono pieni di poveri e di senzatetto: da oltre trent’anni la prima potenza economica mondiale conta lo stesso numero incredibile di indigenti, più di trentacinque milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, molti dei quali non risultano neppure disoccupati perché usciti dalle statistiche in quanto non più titolari di sussidi. L’economista americano Robert Reich, segretario al Ministero del Lavoro dal 1993 al 1996, sottolinea che negli Stati uniti ci sono milioni di working poor che lavorano a tempo pieno e non guadagnano abbastanza per uscire dalla miseria, e questo a causa della flessibilità concessa alle imprese e non ai salariati. Insomma, la prima potenza economica mondiale è anche la prima fra i paesi industrializzati per quanto riguarda il tasso di povertà della sua popolazione. Questo, dice la Forrester, fa riflettere sul senso, sulla qualità, sulla natura dell’economia mondiale.
Prima ancora del crollo borsistico dell’11 settembre 2002 e prima dello scoppio della bolla immobiliare dei Subprime che innescherà nel 2007 la crisi mondiale, la Forrester punta già il dito sull’economia virtuale e sulla speculazione, sui profitti originati da “prodotti derivati”, ossia non-prodotti che si negoziano come se fossero materiali. Si vendono rischi virtuali legati a contratti ancora in stato di progetto, poi si vendono i rischi che scaturiscono dall’acquisto di questi rischi, e così via. Si vende insomma il nulla speculando su ogni negoziazione, scommesse su scommesse su scommesse. A questo porta l’economia di mercato. I profitti sono folgoranti e immediati, a tempo di record. Ma la cosa più preoccupante è che se si produce profitto da utili senza produrre utili da vendita di prodotti reali, non occorrono neanche più lavoratori reali, se non quello stretto necessario per le manovre contabili. E se i prodotti da vendere non contano più nulla, significa che anche i consumatori – ossia gli acquirenti di questi beni – non contano più nulla. Contano piuttosto gli investitori, ossia chi acquista titoli di partecipazione per concorrere alla spartizione di questi enormi profitti costruiti dal nulla. Ecco dove siamo arrivati.
Così la Forrester: “Se la disoccupazione non esistesse, il regime ultraliberista la inventerebbe, perché gli è indispensabile. È quella che permette all’economia privata di tenere sotto il proprio giogo la popolazione di tutto il pianeta mantenendo la coesione sociale, cioè la sottomissione”. Ma se disoccupazione significa anche perdita di consumatori, come può un’azienda permettersi un mancato profitto? Soltanto se il suo carattere di impresa non fosse davvero cambiato, se il suo valore non si distanziasse sempre più dalla sua produzione per essere posto sempre più in relazione alla sua produttività. “Tale valore non dipende più tanto dai suoi attivi reali, dai suoi affari tradizionali, dai prodotti che propone, quanto dalla sua capacità di interessare i mercati finanziari. Ossia dal posto che l’azienda occupa nei fantasmi speculativi” (tradotto in termini nostrani, alla nuova FIAT non interessa più vendere auto ma constatare l’ascesa delle sue quotazioni di Borsa). E allora via con fusioni, incorporazioni, acquisizioni, con creazioni di colossi multinazionali che si muovono in regime di monopolio e con la vendita di prodotti differenziati dai marchi ma omologati in qualità e fattura. Anche il prodotto in sé non conta più nulla: su qualunque marca cada la scelta del consumatore, la multinazionale ha gli utili assicurati.
Un dubbio sorge spontaneo: se la disoccupazione è uno strumento indispensabile per il regime liberista, siamo sicuri che anche l’attuale crisi finanziaria non sia una sua invenzione? Non è forse un ulteriore pretesto per inasprire le sue politiche, sempre con il miraggio di una svolta positiva a favore di una fantomatica esplosione di nuovi posti di lavoro, che quasi certamente non avrà mai luogo? Sì, perché in fondo anche l’inquietante massa di disoccupati viene neutralizzata facilmente attraverso una propaganda adeguata. Basta dipingere l’assistenzialismo come una prassi vergognosa che grava sui contribuenti, i disoccupati stessi come ignobili pigri, incitandoli al lavoro senza offrirne. Un serbatoio di disoccupati in costante aumento per via di licenziamenti di massa effettuati con ragioni – diciamo la verità – che non hanno nulla a che vedere con il valore lavorativo e nemmeno con l’interesse specifico dell’impresa, con la sua produzione e suoi utili reali.
A questo punto ci si chiede chi possa tirare le fila di tutto ciò, chi sia a capo di questa “strana dittatura”, chi sia insomma lo spietato, l’Hitler di turno. Nessuno, questo è il problema. Certo, ci sono le lobby, ma quello che ci troviamo di fronte è un potere anonimo, astratto, fuori portata. Nessuno all’interno dei gruppi industriali vuole distruggere il pianeta o affamarne la popolazione. Non si tratta di una colpa individuale o di malvagità. È semplicemente colpa della logica detta realistica e ritenuta come l’unica moderna dai propagandisti. Se l’amministratore delegato della Michelin, persona per bene, non otterrà utili sufficientemente esorbitanti da attirare gli investitori, nel giro di poco tempo diventerà un’ex amministratore della Michelin. Insomma, responsabile di tutto è il meccanismo assurdo innescato da un mercato che non ammette regole se non quella di macinare profitti ad ogni costo. È un sistema cannibale. Chi non si adegua viene messo in disparte affinché la macchina ultraliberista continui a macinare guadagni.
La propaganda, in questo caso, è subdola e inventa anche strumenti atti a coinvolgere la fascia direttiva dei lavoratori illudendoli di partecipare alla spartizione dei profitti. Esempio lampante i piani di stock option, beneficio accessorio in realtà unicamente speculativi che permettono al piccolo dirigente di acquistare azioni di nuova emissione a un prezzo più basso di quello di mercato e a rivenderle immediatamente realizzando la differenza, oltre tutto con una tassazione bassissima. All’azienda non costano nulla perché l’eventuale monetizzazione è scaricata sul mercato. Peccato che le azioni in circolazione aumentino di numero, il che comporta la necessità di profitti ancora più alti per mantenere inalterati i dividendi unitari, perché gli investitori che contano, è ovvio, vogliono inalterata la loro parte di profitto. Insomma, un altro circolo vizioso che finisce per spingere a tagliare ed economizzare anche a prezzo di una decadenza evidente. Così la Forrester: “Ma sempre e ancora lo stesso interrogativo: perché? A quale scopo? A beneficio di chi o di che cosa, se non del solo profitto?”
Al di là di tutto, la questione non è soltanto morale. Si tratta di un pericolo che è sempre in agguato e che si è concretizzato più di una volta nel corso della Storia: “Non lo ripeteremo mai abbastanza: accettare che esseri umani vengano considerati superflui e che loro stessi arrivino a considerarsi di troppo equivale a lasciare che si instaurino le premesse del peggio. Non è ridicolo affermare che tutti i totalitarismi hanno per base questa negazione del rispetto; questa apre la strada a tutti i fascismi”. Che si sono da sempre instaurati non con la forza ma per colpa di “un certo clima di indifferenza meccanica, di consensi taciti, e l’impressione condivisa da molti (che però spesso cambieranno idea) che la cosa non li riguardi”. Tutto ciò, lo prova la Storia, è una premessa ineludibile ai genocidi. “Opporsi virtualmente ai genocidi non basta. Non avvengono impunemente: hanno bisogno di un terreno preparato; è a monte che vi si deve resistere”.
Ecco che allora il ruolo dell’opinione pubblica diventa fondamentale. Nessuna dittatura ha potuto reggere il potere senza il consenso popolare, palese o tacito. Per questo la diffusione della consapevolezza che non c’è nulla di inevitabile e che l’economia di mercato non è l’unica strada possibile sono il modo più efficace per contrastare l’ultraliberismo. L’opinione pubblica, non dimentichiamolo, è l’unica in grado di influenzare le decisioni dei governi e di battere qualsiasi propaganda.
Dall’uscita di Una strana dittatura sono passati quattordici anni. È dei giorni scorsi la fusione Alitalia-Etihad con trasformazione in azioni di due terzi dei debiti. Le parole che circolano sono quelle ripetute dalla Forrester sino alla nausea: competitività, stabilizzazione dell’azienda, servizio di qualità (ma Alitalia da sola faceva poi così schifo?), costo del lavoro ulteriormente compresso (l’amministratore Del Torchio parla di “decisioni dolorose”, eppure nelle fotografia di gruppo sorride con entusiasmo). Il risultato di tutto ciò sono altre alcune migliaia di tagli di posti di lavoro. E un azionariato soddisfatto. L’ultraliberismo procede nella sua marcia apparentemente inarrestabile. Almeno per ora.



Mi permetto di dire che l’articolo è un po’ confuso, sembra citare vari fatti e idee a caso ricordando un po’ gli articolo complottisti.
O forse è semplicemente il libro ad esserlo (confuso).
L’idea di fondo, se capisco, che la disoccupazione sia voluta artificiosamente alta è un po’ assurda. Vero invece che le aziende si basano troppo sui risultati di breve e le quotazioni di Borsa, ma qui nulla di nuovo, sono critiche che arrivano dallo stesso sistema economico.
Trovo il limite di questi libri proprio questo. Mi basta leggere il curriculum di chi l’ha scritto per capire che si basa più su elementi politici e sociologici piuttosto che economici. E se si parla di economia è ovvio che il libro non ha alcuna base eccetto come appunto pamphlet.
Per questo le critiche al sistema (tra l’altro si parte indicando l’ultraliberalismo per poi parlare indistintamente di liberismo, anche qui non si capisce se è l’articolo o il libro a confonderli) trovano poco appiglio se non appunto nel giro culturale e politico.
Con il paradosso che, soprattutto in Europa, i partiti politici che più teoricamente avversano l’ultraliberismo, sono quelli che più ne sono attigui (a livelli personali).
Per quanto mi riguarda l’ultraliberismo non è altro che uno dei fallimenti del mercato che offre rendite di posizione non tanto alle aziende, ma a banchieri e amministratori vari. Gli alti compensi oggi percepiti rispetto ai risultati conseguiti (oltre che rispetto ai “normali” dipendenti) ne sono la prova principale. Ma come detto, difficile sradicare questa deviazione quando la politica, anche e soprattutto quella presunta contro, non lo è, anzi …
Il liberismo in Italia è come l’araba fenice: che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa.