Migranti, la condanna all’immobilità
di Donatella Di Cesare
(Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autrice e dell’editore, un estratto da “Crimini contro l’ospitalità”, il melangolo 2014. Tra denuncia politica e reportage filosofico, questo libro è un viaggio in un centro di identificazione e espulsione, quell’Ade invisibile e nascosto dove vengono relegate le scorie umane della globalizzazione. Ma il viaggio diventa occasione per riflettere sui campi per gli stranieri, sulla retorica ambigua dell’accoglienza. Dove finisce la protezione umanitaria e dove comincia il controllo poliziesco? Lo stato di permanente emergenza ha sottratto gli stranieri al diritto e ha permesso che, in una continuità inquietante con il passato, si materializzasse in Europa lo spettro del “campo”. Il neorazzismo è la convinzione che ciascuno debba vivere nel proprio paese, la reazione alla mobilità degli esseri umani, la pretesa di bandire gli indesiderabili.)
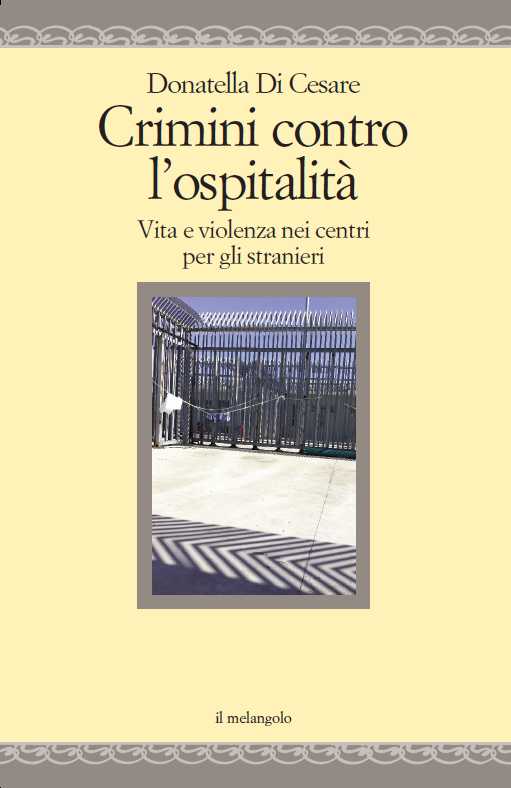 Nel mondo globalizzato il successo si misura con la possibilità di muoversi liberamente. L’immobilità è invece il segno della sconfitta: chi resta indietro è emarginato, escluso dai luoghi che gli altri possono attraversare, confinato a una dimensione locale.
Nel mondo globalizzato il successo si misura con la possibilità di muoversi liberamente. L’immobilità è invece il segno della sconfitta: chi resta indietro è emarginato, escluso dai luoghi che gli altri possono attraversare, confinato a una dimensione locale.
Non stupisce, allora, che il divieto di muoversi rappresenti la punizione più dura, il castigo più crudele, lo strumento più efficace per neutralizzare i soggetti ritenuti pericolosi.
Anche nel passato la segregazione è stata il modo per risolvere il problema posto da tutti coloro che non erano accettati nel corpo sociale: schiavi, stranieri, ebrei, pazzi, malati, lebbrosi, eretici, vagabondi. Il permesso di uscire dai quartieri, in cui erano relegati, prevedeva tuttavia l’obbligo di esibire in pubblico un marchio di appartenenza che li rinviava a uno spazio diverso. La segregazione, cioè l’isolamento spaziale, ha avuto così nei secoli lo scopo di rendere visibile e di perpetuare l’estraneazione dei diversi.
L’idea della prigione nasce da qui. Incarcerare non è che la forma estrema di restrizione dello spazio. Perciò l’internamento è sempre anche esclusione.
Pur nella continuità che lega il CIE alle forme precedenti e coeve di segregazione, c’è però una differenza che non deve sfuggire. Non solo non vi è alcun regolamento, né sono previsti una disciplina formale, un lavoro produttivo o una attività organizzata. Al contrario di altre istituzioni totali, che hanno una finalità riabilitante e mirano alla guarigione, alla reintegrazione o al recupero, sebbene manchino poi spesso il loro obiettivo ufficiale, il CIE non ha altro scopo che il trattenimento e l’espulsione.
La sorveglianza deve assicurarsi costantemente che gli internati, bloccati in quella mortificante sala d’attesa per il terzo mondo, restino dove sono. Non importa quello che fanno; l’importante è, anzi, che non facciano nulla. L’esclusione passa per quel nulla a cui li assegna la condanna all’immobilità.
In questo senso Ponte Galeria, più che a un campo di concentramento, quel laboratorio della società totalitaria, dove si sperimentava la schiavizzazione dell’uomo, appare un campo in cui, nella società planetaria, si mettono a punto le tecniche per smaltire le scorie umane della globalizzazione.
Al rifiuto e all’esclusione si aggiunge dunque, potenziandoli, l’immobilità forzata che, nell’era dell’illimitato, significa negare le libertà globali a una parte dell’umanità. In campi come questi emerge con chiarezza quello che Zygmunt Bauman ha più volte ribadito, e cioè che la globalizzazione al vertice procede di pari passo con la frammentazione e il disadattamento al fondo.


Oggi il mondo si è spaccato in due. La mia libertà di movimento dipende dalla condanna all’immobilità a scapito di un altro individuo. Si tratta di due reazioni speculari dello stesso fenomeno: la regolamentazione internazionale degli equilibri di scambio e di mobilità delle persone tra le varie nazioni, regolamentazione che si fonda su un concetto distorto di cittadinanza e di democrazia.
Per noi giovani transnazionali, vivere per qualche tempo in un paese straniero, fare esperienza diretta della cittadinanza europea attraverso progetti di scambio, studio e lavoro, è diventato ormai una specie di passaggio obbligato per acquisire un certo posto nel mondo, per assumere un ruolo di prestigio, per farsi valere in quanto membro pienamente inserito nella civiltà contemporanea. Con ciò, viene inibito il desiderio di stabilità (si pensi alle retoriche della flessibilità, non solo lavorativa), incentivando l’incertezza e il cambiamento, nonché una nuova capacità di adattamento a luoghi estranei e di resistenza all’indeterminazione identitaria.
Chi non ci riesce è tagliato fuori, “sfigato”, delegittimato. O almeno così si percepisce e, plausibilmente, viene percepito. Esiste infatti un codice che abbiamo ormai interiorizzato: per essere “in gamba” devi saperti adattare ad un paese straniero, essere pronto a separarti dal nido degli affetti quotidiani e parlare quante più lingue possibili (non importa a che livello di preparazione e approfondimento). Se sul curriculum scrivi di aver lavorato sei mesi al McDonald’s, il semplice fatto di aver svolto questo umile lavoro in un paese diverso da quello di nascita, conferisce immediatamente un valore condiviso ad un’esperienza che di per sé, al contrario, è comunemente considerata degradante sia per l’individuo (il lavoro è massacrante, sottopagato e precario) sia per la comunità (i dubbi di legittimità delle condotte dirigenziali e le disinvolte procedure di produzione e trasformazione degli alimenti sono ormai noti).
D’altra parte, per tanti altri giovani, molto meno transnazionali di noi, l’espatrio rappresenta al contrario un’ancora di salvezza, uno sforzo in cui s’impegna l’intera famiglia investendo risparmi, energie e speranze. Per molti giovani che non godono di un passaporto al quale la comunità internazionale riconosce una certa mobilità, connaturata nell’individuo e nella nazione che lo rappresenta, l’espatrio – spesso l’unica via di uscita da una condizione di miseria o di reale pericolo – si fa irto di ostacoli istituzionali, legali e geopolitici. Per queste persone esistono solo due condizioni: o l’immobilità (con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano materiale, sociale, economico, familiare, individuale) o l’illegalità, almeno per un certo periodo di tempo, cioè fino al momento in cui si riesce a rientrare nei circuiti burocratici ottenendo gli agognati documenti che permettono di soggiornare legalmente in un paese straniero.
Ma al di là della difficoltà delle procedure, rese spesso così cavillose e irrazionali da far dubitare della loro buona fede, il solo fatto che il diritto alla libertà di alcuni venga sottoposto al possesso di un permesso di soggiorno, lede dall’interno i principi di democrazia che sono alla base della nostra educazione.
Quali sono le ragioni di una tale, inspiegabile discriminazione? Su quale base viene garantita ai pochi e impedita ai molti tale libertà? Non vorrei dire su base razziale, dal momento che la controversia delle razze è deflagrata in un bagno di sangue nella recente storia europea. Non vorrei nemmeno dire su base socio-economica, considerando che i voli low cost ci permettono di viaggiare, con pochi scrupoli e qualche quattrino, in quasi tutto il pianeta. Si tratta, direi, di una discriminazione su base nazionale, legata alla provenienza, al titolo del passaporto, a un nuovo diritto di nascita che determina una spaccatura profonda tra legittimati e delegittimati. Si assiste al consolidamento di una nuova nobiltà globalizzata, ai margini della quale si distende la valanga di persone che vivono senza tregua nel limbo tra clandestinità ontologica e legalità contingente.
La conclusione è tanto ovvia quanto allarmante. Un passaporto europeo o nordamericano rappresenta, nell’epoca contemporanea, il nuovo titolo di nobiltà per diritto di nascita e trasmissione ereditaria. Al di là si stende una palude indistinta e stigmatizzata dei sans papier che rappresenta un nuovo proletariato globale, una nuova classe di paria, “naturalmente” esclusi dai processi di globalizzazione, incapaci di gestire gli effetti positivi della mondializzazione degli scambi e delle relazioni sociali.