Andrea Melone – Strategia delle ombre
di Andrea Melone
(Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, un estratto da Strategia delle ombre, Gaffi 2014, il nuovo romanzo di Andrea Melone. La storia di un uomo braccato da aguzzini che non gli lasciano tregua costringendolo a fuggire e a cambiare continuamente identità. Il romanzo segue il protagonista in tutti i suoi spostamenti, dagli Stati Uniti all’Egitto, dall’Algeria ad Amsterdam, da Bristol a Roma. In ognuno di questi luoghi, sempre vigile nell’intento di eludere le ombre che lo perseguitano, reinventa la propria vita facendo di sé un altro uomo. Ma perché è costretto a scappare? Qual è la sua colpa? Di cosa è accusato? Strategia delle ombre è il primo volume di una trilogia.)
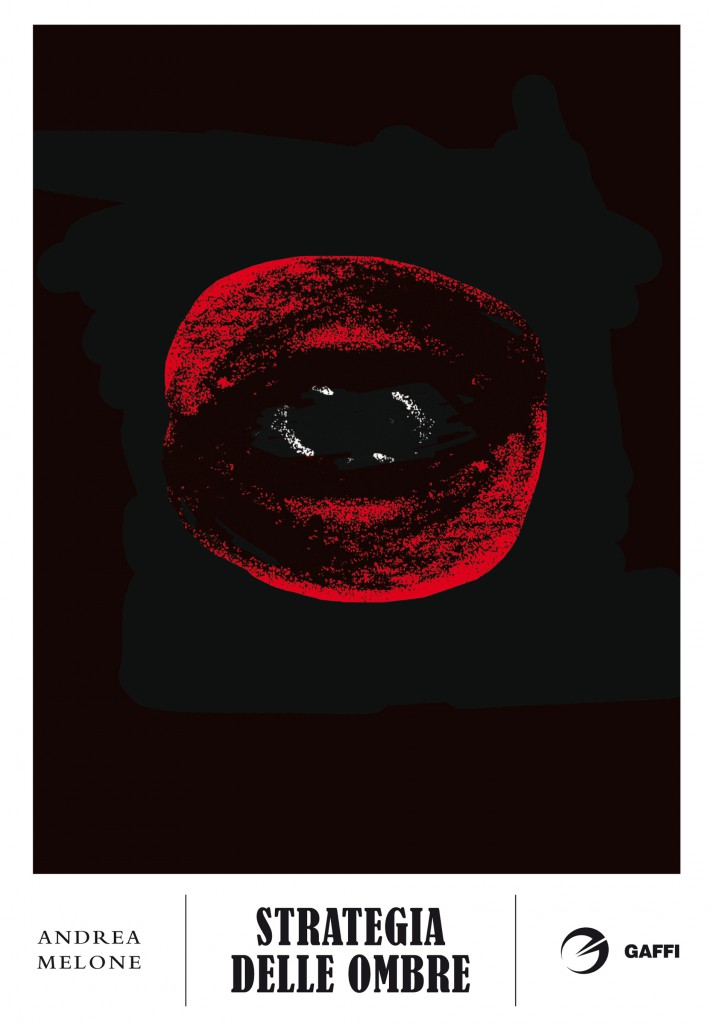 Egitto
Egitto
Era entrato in cantina, aveva aperto il baule accanto alla toletta comprata pochi mesi prima da un antiquario ad Arezzo. Aveva tirato fuori, come dall’erebo, tondi pagliacci di vetro di Murano, libri e lettere in francese, in italiano, in arabo, in inglese, in tedesco, stoffe e coperte e altri panni d’ogni genere, una coppia di dolci, struggenti foto incorniciate di sua madre, unica testimonianza di lei, e poi aveva guardato ancora.
Aveva visto. Aveva richiuso.
Tutto aveva compreso su Ludovica, sulla sua giovane vita, sui suoi incomprensibili sorrisi, e molto aveva pianto, molto era rimasto con la fronte sulle ginocchia.
Dopo aver fatto questo era uscito, aveva raccolto una ragazza per strada e gli avevano ammazzato il figlio.
La sua vita doveva finire.
Guidò verso il mare, il sole era ancora lontano dall’orizzonte.
Sono stanco, pensò. Peregrinare nel mondo incessante.
Peregrinare braccato dalla morte. Peregrinare io seme della morte.
Era in Italia da alcuni anni. Ancora in Italia: per la terza volta in più di trent’anni, sempre in luoghi diversi, sempre con nomi diversi. Tutte vesti di un unico Io. Tegumenti.
Quella notte prese in considerazione per la prima volta l’idea di uscire allo scoperto e di ritornare. Ritornare da Lui. Che il gioco avesse termine.
La desolazione del suo animo era stata causa di troppo male, di inumane sofferenze a sé e altrui.
L’assassinio di suo figlio lo aveva annichilito. È cosa che non si sopporta e iniquo riaversene.
Aveva conosciuto la fine miseranda di Caterina. Caterina, angelo di Dio, sguardo azzurro.
Aveva pianto lei e suo figlio e mentre era seduto con le mani sopra gli occhi, non faceva che tornare davanti a quel corpo impiccato di lei, il suo collo adagiato sulla spalla: sembrava si sciogliesse dal gancio e gli s’avventasse, dall’eternità, come una bestia affamata.
Aveva compreso la verità su Ludovica.
Come lo avevano scovato in Egitto i suoi figli? Anche loro erano ombre? Egli aveva assoldato anche loro? Tutti erano ombre?
Tutto è ombra.
Decise di prepararsi al ritorno e a ciò che avrebbe comportato. Decise di prepararsi al viaggio. L’ultimo viaggio.
Prese la macchina, guidò nella città senza limite. Andò verso il mare, dove così tante volte era stato con Ludovica, con Michela, con Leda.
Scese sulla riva e si sedette, come così tante volte aveva fatto in Egitto con le spalle al deserto cupole d’oro.
L’Egitto!
Gli si schiuse la giovinezza dal petto come da una vecchia panca.
Forse in Egitto, per un certo tempo, era stato felice, se uomo può dirsi felice. Forse perché vi era rimasto molti anni, molti più che in qualunque altro luogo e la sua vita aveva conosciuto la normalità e l’agiatezza di un coloniale. Forse perché in Egitto non aveva contratto amore, nonostante fosse nel fiore dell’età, e non ne aveva patito l’inganno.
Il suo nome in Egitto era Gilberto Gambi.
Scelse Porto Fuad, nel nord del paese, una cittadina deliziosa creata appositamente per bilanciare il peso di Porto Said. L’intento, a quanto pare, non era andato a effetto, sebbene vi avessero stabilito i Tribunali Misti e la maggior parte degli uffici e delle officine della Compagnia del Canale e anche le saline che servivano tutto l’Egitto.
Porto Said e Porto Fuad erano sulle due opposte sponde del canale, quella africana e quella asiatica, collegate da traghetti costanti che impiegavano venti minuti esatti per la traversata.
Tutti dicevano Said e Fuad, arabi, greci, libanesi, italiani, tranne i francesi. Loro rive Asie e rive Afrique. Si distinguevano in tutto i francesi, vestiti di avana e di bianco, non rivolgevano volentieri la parola a nessuno che non fosse francese o inglese, rari sorrisi sopra le labbra, acqua di colonia, le donne innervosite dai figli, troppo esili o corpacciute con ridicoli cappellini a fiori; simpatici e buffi i mocciosetti, alquanto sciupatini, educatissimi, sempre con quell’aria da bagarilli agli esami, i bei ciuffi castani scompigliati, erano i padroni del mondo e si rincantucciavano dietro le gonnelle delle mamme, braccia penzoloni, i padri li sorvegliavano sulla strada, lanciavano occhiate da farli perder d’animo, poveri angeli, convinti solo dai loro affari, con gli orologi alla catena, soprappensiero.
A Porto Fuad, Gilberto riuscì ad affittare una villetta in campagna a poche decine di metri dal mare. Visse alcune settimane diffidente e scorato fino alle lacrime, e la notte sotto quei cieli giubilanti s’aggrappava alla memoria dell’istituto e di don Giacomo, le sue guance glabre, la sua mano che dirigeva il tempo mentre lui era seduto allo sgabello del piano, Dioh, lo avrebbe voluto con sé ora, nella sua casetta sui coralli, e non pensava a che cosa avrebbe fatto domani, alla sua giovane vita, né alla bellezza inorganica di Caterina, ma alle stelle di Dio che rendono giovani coloro che le guardano: questo gli confidò don Giacomo, che le stelle di Dio ringiovaniscono chi le contempla con occhi puri, e non sapeva più che cosa volesse dire e in quel momento, nella desolazione di una terra disperata, era diventato essenziale capirne il senso e venirne a capo, e sarebbe stato come possedere la forza increata del Graal.
Trascorreva le ore in un fabbricato di legno in parte costruito sulla spiaggia, in parte su palafitta che s’addentrava nell’acqua blu cobalto e turchino per dieci metri. Poco al di là s’accostavano i delfini. C’erano alcuni bambini e parlavano con loro da lontano e sembrava potessero intendere quei sorrisi fuggitivi.
Uno di essi era un francese, Jacques, veniva a villeggiare coi suoi, doveva essere il figlio di un piccolo burocrate della Compagnia, e quando Gilberto si presentò a casa con una nuovissima Pontiac Candy Green, Jacques, che non aveva più di otto o dieci anni, gli domandò: «Tu sei ricco o agiato?».
«Sono ricco», rispose, e quello replicò: «No, tu sei agiato, perché le persone agiate hanno una sola automobile, quelle ricche due. Tu ne hai una», e tutti strabiliarono, Gilberto compreso, e sorridendo: «No, sono ricco. Le persone agiate lavorano, quelle ricche no. Io non lavoro», e tutti quei bambini strabiliarono ancora e trattennero il fiato sbigottiti sulla riva del mare infecondo, zaffiro e smeraldo di Porto Fuad.


Effettivamente oggi la vera ricchezza sta proprio nel non dover lavorare, ma temo ne siano rimasti davvero pochi…