Hrabal in maschera
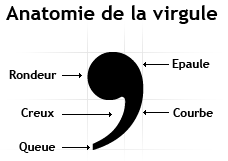 Il manuale di un apprendista sbruffone (1970)
Il manuale di un apprendista sbruffone (1970)
di
Bohumil Hrabal
Traduzione di Annalisa Cosentino
Testo pubblicato in rete qui
Sono un estimatore del sole nei ristoranti all’aperto, un bevitore della luna che si specchia nel selciato bagnato, cammino eretto e diritto, mentre mia moglie, a casa, benché sobria, fa atti mancati e barcolla, una descrizione piena di humour dell’eraclitiano panta rei mi scorre alla gola e tutti i ristori del mondo sono come un gruppo di cervi agganciati per le corna dei discordi, la grande scritta Memento mori che alita dalle cose e dai destini umani è un motivo per bere sub specie aeternitatis, il cimitero di Olšny, la prigione di Pankrác e via Bartoloméjská altrettanto, sono perciò un dogmatico dell’allergia allo stato fluido, la teoria del giunco e della quercia per me è una forza motrice, sono un urlo umano atterrito, che si dissolve in un fiocco di neve, vado continuamente in fretta, per poter sognare due o tre ore al giorno inattivamente attivo, perché so bene che la vita umana è breve e passa mentre si mescolano le carte, che forse sarebbe meglio se fossi lavato via, buttato via dentro un fazzolettino, talvolta mi atteggio come se stessi fiutando un milione, anche se so bene che alla fine vincerò una merda che ride, che la festa è cominciata con una stilla di seme e finirà nel crepitio del fuoco, da inizi così belli così belle conclusioni, dietro un visetto grazioso si può amare l’allegra madrina Morte, annaffio le piante quando piove, nel luglio afoso mi tiro dietro lo slittino di dicembre, nei caldi giorni estivi, per rinfrescarmi, mi bevo i soldi destinati al carbone per scaldarti d’inverno, tremo continuamente di paura perché la gente non trema di paura per quanto la vita è breve, è così poco il tempo, finché ce n’è abbastanza, per le follie e l’ubriachezza, vivo i mattutini postumi di sbronze come campioni nient’affatto privi di valore, anzi, come valore assoluto di un trauma poetico con un accenno di insania, che va assaporata come una santa colica epatica, sono un albero frondoso pieno di occhi attenti e sorridenti, occhi sempre in stato di grazia e come assi appaiati di accidenti e incidenti, che gioia, su un vecchio fusto giovani ramoscelli, che godimento il riso delle foglie appena nate sui giovani rami, il mio clima è il tempo variabile di aprile, una tovaglia sbrodolata è la mia bandiera, nella cui ombra ondulata provo non solo allegra euforia, ma anche slittamento e resurrezione, quel dolore sordo alla nuca, quell’orribile tremito della mano, con i denti mi tiro via dalle zampe piccole schegge di vetro e i residui dell’esuberante notte precedente, ogni mattina mi stupisco di non essere ancora morto, sono sempre in una condizione di morosità, potrei crepare prima di aver fatto follie a mio piacimento, non mi considero un rosario, ma un anello della catena spezzata del riso, il più fragile grano determina la forza della mia immaginazione dissipatrice, è qualcosa in me di castrato, qualcosa che è e allo stesso tempo indietreggia verso il passato, per essere catapultato nel futuro compiendo un arco, nel futuro che poi mi distoglie completamente da labbra ed occhi bramosi, tanto che divento strabico, vedo doppio come attraverso la calcite islandese, oggi è ieri e l’altroieri è dopodomani, perciò sono un produttore di affrettati giudizi sintetici, assaggiatore e sommelier di uno spazio adulterato, considero la sclerosi e la demenza e il balbettio infantile come l’inizio di possibili scoperte, con la giocosità e il gioco trasformo la valle di lacrime in riso, scongiuro la realtà e lei non sempre mi dà un segno, sono un timido capriolo nella radura di un’aspettativa sfacciata, sono la solida campana dell’imbecillità incrinata dal fulmine della conoscenza, l’oggettività in me assurge alla soggettività estrema, che considero un’aggiunta alla natura e anche alle scienze sociali, sono un genio negativo, un bracconiere nelle riserve della lingua, sono il guardaboschi dell’ispirazione piena di humour, una guardia giurata sui campi delle barzellette anonime, l’assassino delle buone idee, il guardiano dei dubbi vivai della spontaneità, eterno amatore e dilettante dell’idiozia e della pornografia, eroe dell’insensatezza pensante, precipitoso crocifero di parallele anticipate, che vuol mangiare una fetta di pane spalmata sul burro dell’infinito, che vuol bere da un boccale la panna dell’eternità subito, ora, e ora e mai più, quindi mai, reputo la spiegazione sbagliata delle parole di Cristo il fascino dei testi apostolici, una trina di Bruxelles inzuppata nelle bave di un epilettico, frantumi di ghiaccio sulle sponde di un torrente invernale sono il mio ornamento, contro il quale ci si può ferire, io sono depressione e spleen e prostrazione, i preparativi al salto di testa contro il muro sono la prova, continuamente rimandata, che si può vivere diversamente da come ho vissuto finora, sono un nevrotico che gode di ottima salute, un insonne che si addormenta profondamente solo sui tram e si lascia così portare fino al capolinea, sono una grande presenza di piccole aspettative e di attesi grandi crack e fiaschi, su un orizzonte grottesco vedo altri orizzonti di minuscole provocazioni e di scandali in miniatura, perciò sono un clown, un animatore, un narratore e un istitutore, proprio come un grande detrattore e delatore di me stesso, redattore di lettere minatorie senza firma, considero le notizie prive di valore un possibile preambolo alla mia costituzione, che cambio di continuo, che non posso mai aver finito, nel progetto di un ombra tracciata lievemente scorgo una costruzione gigantesca, anche se è una piccola tomba di bambino sprofondata da tempo, sono un signore incinto di giovinezza che invecchia già, la mimica e la lingua sono la grammatica in movimento di un gergo interiore, una fetta di polpettone caldo e un bicchiere di birra fredda in mezz’ora riescono a transustanziarmi la materia in buon umore, che metamorfosi a buon mercato, e il primo miracolo è venuto al mondo, una mano posata su una spalla amica è per me la maniglia che apre la porta della beatitudine, dove ogni oggetto amato è il centro del paradiso terrestre, il cuore della natura è lo stato accessibile del bodhi, in cui nel pensiero si può amare una vagina riluttante e ostinata, avvolta per di più nelle più belle curve di carne, verbum caro factum est, il cannibalismo raggiunto a secco, senza prete e senza diploma di maturità, tristi occhi di mucca che si sollevano curiosi sopra le sponde dei camion, sono i miei occhi, una giovenca minorenne attesa da macellai con coltelli luccicanti, sono io, una cinciallegra con le ali rovesciate svuotata in una sera gelata in un secchio d’acqua fredda, sono io, la fiamma a cui ritornano vespe fedeli, per morire bruciate insieme alle altre nel nido che arde, questo è l’abbozzo di un’idea abbastanza precisa di favi che bruciano pieni di un miele preparato solo e soltanto per me, sono dunque un membro corrispondente dell’Accademia della sbruffoneria, un allievo della cattedra di euforia, il mio dio è Dioniso, un leggiadro giovane ubriaco, l’allegria che si è fatta uomo, il mio padre della chiesa è l’ironico Socrate, che con pazienza attacca discorso con chiunque, per portarlo con la lingua e per la lingua fino alla soglia stessa del non sapere, il figlio primogenito è Jaroslav Hašek, inventore da storielle da osteria e geniale viveur e scrivano, che con l’afrore dell’uomo ha reso umani i cieli prosaici e ha lasciato la scrittura agli altri, con gli occhi sbarrati fisso le pupille blu di questa Santa Trinità, senza aver raggiunto il culmine del vuoto, l’ebbrezza senza alcol, l’istruzione senza il sapere, inter urinas etfaeces nascimur ed è come se le nostre madri ci avessero partorito a cavalcioni direttamente nei forni crematori, o in tombe ricoperte di erbetta, sono un toro dissanguato dal riso, al quale qualcuno con un cucchiaino mangia il cervello come un gelato.
Cameriere, ci sarebbe un’altra porzioncina di gulasch?
P.S. Quando analizzo questo testo, che dovrebbe fare da postfazione a questo libro, un testo che ho scritto in cinque ore in pause irregolari mentre spaccavo la legna e tagliavo l’erba, un testo che ha il battito rallentato della scure verticale e la melodia della linea orizzontale di una falce austriaca, devo distinguere tra le frasi defluite come somma di esperienza interiore e quella che ho ricavato dalla lettura. Devo elencare le frasi di autori che, dal momento in cui le lessi, mi affascinano al punto che mi dispiace non averle inventate io stesso. “Non mi considero un rosario, ma l’anello di una catena spezzata” è una variazione rovesciata del nietzschiano “non sono l’anello di una catena, ma la catena stessa”. “Ogni oggetto amato è il centro del paradiso terrestre” è esattamente Novalis. “Verbum carofactum est” è S. Giovanni, “la Parola fu fatta carne”. “Dioniso, l’allegria che si è fatta uomo” è Herder. “Inter urinas et faeces nascimur” dovrebbe essere S. Agostino, “nasciamo tra feci e urine”. E malgrado ciò siamo bellissimi. “Le nostre madri ci partoriscono a cavalcioni in tombe aperte” è uno scolastico spagnolo, di cui ho dimenticato il nome. Eppure siamo magnifici e, dunque, qui. Questo è tutto.
Traduzione di Annalisa Cosentino, MicroMega n. 3/95, pp. 95-98


che dire! immensità
e traduzione ok
una di quelle cose .capito effeffe?