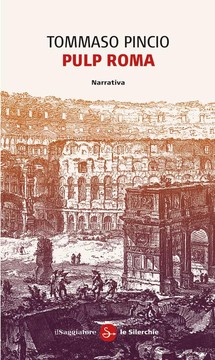L’autobiografia di un’idea di Tommaso Pincio
di Giuseppe Zucco
Ci mette nulla a sparigliare le carte, Tommaso Pincio. Ci mette giusto sei righe per alzare la classica cortina fumogena di una parolina intorno alle sue reali intenzioni: libercolo. Non solo libercolo, ma anche capriccio – ancora meglio, svago. È questa la definizione che dà del suo ultimo libro, Pulp Roma, edito da Il Saggiatore. Quasi si tirasse indietro o mettesse le mani avanti o in qualche modo si autodenunciasse riguardo alla portata minima dei contenuti e delle ambizioni. Un libro che dovrebbe appena raccontare com’è scaturita e in che modo si è sviluppata l’idea che avrebbe dato origine al suo ultimo romanzo, Cinacittà. Libercolo o libricino compilato per evidenziare il legame indissolubile con il luogo in cui vive, la città di Roma.
Se questa è la premessa, qualcosa non torna. Il primo capitolo dà conto del tratto distintivo della capitale, Roma si rivela luogo di sproporzioni: sproporzioni tra io e l’altro, tra il presente e il passato, tra il dire e il fare. Ma soprattutto si rivela un luogo refrattario alla narrazione. Il secondo capitolo avanza il racconto allucinato di un’estate rovente trascorsa in una Roma invasa dai cinesi tra le sponde di un hotel e di un go-go bar dove viene irretito dal mutismo di una ragazza cinese e dal magnetismo di un fermacomande – uno spillone di metallo fissato a una base di legno. Il terzo capitolo chiama in causa Freud, Onfray, Nabokov e una scimmietta per evidenziare che Non c’è nulla di più tortuoso e ingannevole della memoria. Credere di avere il controllo dei propri ricordi, di poterli manipolare a proprio piacimento, si rivela spesso illusorio o, nel migliore dei casi, un’arma a doppio taglio. Risalire alla sorgente di un’idea, percorrendo a ritroso il corso delle sue modificazioni, può riservare sorprese inaspettate […]. Il quarto capitolo restituisce il frammento di un romanzo scritto ben prima del suo esordio, il cui protagonista, Pietro Marana Sforza, agente ausiliario della Piesse, a cui viene assegnato il compito di piantonare l’ingresso dell’ufficio dell’inconoscibile e sfuggente Acaba – un commissario il cui cognome riporta l’acronimo più inviso alle forze dell’ordine, All Cops Are Bastards – si muove negli stessi spazi in cui si stagliò il profilo investigativo di Francesco “don Ciccio” Ingravallo, protagonista a sua volta del capolavoro di Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Il quinto capitolo, attraverso il ricordo di alcune catastrofi reali o del tutto immaginarie, stringe un nodo tra l’idea romantica di apocalisse e la visione delle rovine che affiorano come denti cariati sul sorriso fatale e metastorico di Roma. Il sesto capitolo, frullando la memoria di Kurt Cobain, Federico Fellini, La dolce vita, Blade Runner e il colosseo raffigurato nel fumetto Ranxerox come un albergo puntellato da colate di cemento armato, rischiara la certezza che Roma era un luogo fisico, presente, ma al tempo stesso anche immaginario e da sempre perduto. Il settimo capitolo fa il consuntivo di come sia sfumato il tentativo di sistemare l’idea per il romanzo dentro il righino nero delle tavole di una graphic novel. L’ottavo capitolo rispolvera le tavole della graphic novel, The melting spot, che si avverano alla fine del libro come la summa lisergica e fulminante di quanto è stato confezionato poco prima con le risorse proprie della lingua piuttosto che delle immagini.
Lo stile che Tommaso Pincio usa, soprattutto nei capitoli più riflessivi, è lo stesso impiegato nella stesura del libro precedente, il bellissimo istruttivo toccante Hotel a zero stelle (Laterza, 2011). C’è la stessa lingua – misurata, malinconica, confidenziale, discorsiva ai limiti dell’ipnosi, che ti trascina nei gorghi di una visione o nelle spire di una riflessione. Ma se in Hotel a zero stelle la struttura permetteva attraverso la messa in scena della vita e le opere di una eletta casta di scrittori di venire a conoscenza di alcuni frammenti fondamentali della biografia di Tommaso Pincio, frammenti sempre situati sul confine mobile tra realtà e ricostruzione immaginaria – del resto, già dalla scelta del suo pseudonimo, Pincio fa di questo confine uno dei punti cardine della propria scrittura – in Pulp Roma appare tutto più instabile e precario. Se già i capitoli, nonostante rispondano a una progressione logica, sembrano più giustapporsi che succedersi, entrando anche sottilmente in contrasto tra di loro, come se fossero il risultato scientifico di un collage, l’apporto conoscitivo di cui il lettore potrebbe alla fine vantarsi rispetto a come si sia trasformata l’idea di un romanzo in un romanzo effettivo rischia di collassare nella muta espressione dell’imbarazzo.
Volendo estrarre dalla miniera d’oro della scrittura di Tommaso Pincio la pirite di alcuni dati bruti, si viene a capo di minuti riscontri. La gestazione di Cinacittà è stata lunghissima, soprattutto per la difficoltà e/o la fobia di tratteggiare come sfondo e/o personaggio la città di Roma, un chiodo fisso, a quanto pare, che sembra precedere qualsiasi altra pubblicazione, e che avrebbe generato le pagine riportate nel capitolo quattro. Alla primitiva poi cassata versione del romanzo era stata appioppata dal futuro editore il titolo di Pulp Roma. Il racconto scritto successivamente e da cui si originerà lo stile e la struttura del romanzo si chiamava The Melting Spot, quello del capitolo due. L’avvocato, uno dei personaggi principali di Cinacittà, è stato costruito calcando la mano sulle fattezze reali di Emanuele Trevi, altro scrittore romano. Il romanzo di ambientazione romana, su idea della redazione della rivista Rolling Stone, fu sul punto di trasformarsi in una versione a fumetti da pubblicarsi a puntate.
Se le evidenze si fermassero qui, non varrebbe neanche la pena sfogliare il libro, il tutto si potrebbe considerare inconsistente gossip letterario – tra l’altro, come ogni canonica faccenda di gossip, nessuno rischierebbe le dita sul fuoco per certificarne la presunta autenticità. Ma c’è un modo più sbilenco e obliquo per godere di questa scrittura, e rendersi conto di quale aria sorniona si sia irradiata dal volto di Tommaso Pincio nel momento in cui definiva libercolo il piccolo ammontare di queste pagine. Alla fine, nel suo apparente disordine, nella sua dispersione, nel suo diramarsi lungo le molteplici linee della narrazione e della riflessione, questo libro illumina il modo in cui viene al mondo l’idea per scrivere un romanzo – un’idea che nasce, cresce, arretra, si sviluppa, sbanda, fiorisce di colpo, come di colpo torna ad avvilupparsi su se stessa, prima di diffondersi ancora e attecchire meglio in un terreno irrorato tanto dal desiderio di dare una qualche forma e una qualche compiutezza alle mille idee che confluiscono intorno all’idea originaria, tanto dal presentimento che il fallimento incrinerà ogni possibilità di forma e compiutezza. Le idee per un romanzo germinano al modo disordinato e discontinuo e persistente delle erbacce piuttosto che nell’impennarsi verticale delle grandi conifere. Ed è molto commovente sapere che uno scrittore si è premurato di consegnare al lettore un orizzonte di fitta vegetazione in cui smarrirsi cercando la propria irripetibile posizione nel mondo invece che una circoscritta porzione d’ombra sotto la grande conifera in cui trovare appena un comodo riparo o uno scontatissimo conforto.