carta st[r]ampa[la]ta n.30
di Fabrizio Tonello
Pietro Citati delizia i lettori di Repubblica (20 agosto) con una recensione di L’Odissea di Elizabeth Marsh, “uno dei libri di storia più belli e divertenti che abbia letto negli ultimi anni”. Ecco, il libro di Linda Colley sarà anche bello, ma “letto” non sembra l’aggettivo giusto per dare conto del rapporto fra il critico Citati e il volume pubblicato da Einaudi.
Per esempio, Citati scrive che Elizabeth Marsh, una ragazza inglese figlia di un capo falegname della Royal Navy, “imparò il francese, l’aritmetica e la contabilità, la musica e il canto; aveva una cultura come pochissime donne dell’epoca e si muoveva con disinvoltura nel mondo complicatissimo dei commerci marini”. Il che sarebbe molto interessante se fosse quanto dice il libro.
La Colley (cito dall’edizione originale) scrive che crescere tra Portsmouth, Londra e Chatham, a contatto con gli arsenali della marina inglese, permise a Elizabeth Marsh di acquisire, in un certo senso, “una pseudoeducazione rispettabile” (counterfeit of genteel female education). La ragazza “imparò l’aritmetica e i rudimenti della contabilità dal padre” (quindi non andava a scuola) e prese a interessarsi “di alcuni dei più innocui passatempi diffusi tra i marinai, come leggere, [ascoltare] musica e cantare”. Insomma, la “cultura come pochissime donne dell’epoca” sarebbe consistita nell’aver imparato a leggere e far di conto in casa, oltre ad ascoltare musica e cantare: probabilmente le ballate dei marinai, visto che l’iPod non era ancora stato inventato.
Per essere del tutto onesti con il frettoloso recensore, va detto che a un certo punto la Colley attribuisce a Elizabeth Marsh la conoscenza del francese ma non si sbilancia troppo: “Le visite alla zia Mary e allo zio Duval a Londra sembra abbiano permesso a Elizabeth Marsh di imparare a parlare e a leggere il francese”. Non esattamente una frequentazione della Sorbona: Jean Duval, come precisa il volume, faceva il panettiere e non l’insegnante di lingue , o almeno il precettore.
Quanto alla “disinvoltura nel mondo complicatissimo dei commerci marini” nelle 349 pagine del libro non ce n’è una sola dove si parli di Elizabeth come di una donna con un’attività lavorativa indipendente: chi si occupava di traffici di vario tipo, dal baccalà agli schiavi, era il marito James Crisp mentre l’eroina del libro di Linda Colley poco sembra aver fatto nella vita salvo ballare, bere vini liquorosi e mangiare ostriche (sulla vita mondana i dettagli riferiti da Citati sono esatti) e scrivere uno scarno volumetto sulla prigionia in Marocco, di cui diremo tra un momento.
A questo punto sarà forse utile riassumere il libro, che palesemente è l’opera di uno storico serio ma con l’occhio attento alle vendite, a cui l’editore ha imposto un titolo roboante, The Ordeal of Elizabeth Marsh, su cui gli uffici stampa marciano allegramente. Per inciso, “ordeal” in inglese ha un senso più forte di quello che ha “odissea” in italiano, riferendosi a esperienze orribili ma anche alla pratica del “giudizio di Dio” che consisteva nel sottoporre l’accusato a prove come camminare nel fuoco per accertarne l’innocenza (“ordalia”).
Elizabeth Marsh era la figlia di Milbourne Marsh, un capo falegname della marina inglese, e nacque a Portsmouth nel 1735. Fino a 19 anni fece una vita del tutto normale sulla terraferma, poi seguì i genitori a Minorca, allora una base della Royal Navy nel Mediterraneo, e a Gibilterra. Da lì iniziano le sue avventure, che consistettero essenzialmente nel cadere nelle mani del sultano del Marocco assieme all’equipaggio della nave su cui stava tornando a Londra e al futuro marito James Crisp, che è il protagonista delle parti interessanti del libro. Liberata dal Marocco grazie a diplomatici che sapevano il loro mestiere, si stabilisce a Londra dove fa una vita agiata e per nulla avventurosa mentre Crisp crea un impero commerciale che spazia quattro continenti: ha interessi nel traffico di schiavi tra Africa e America, nella pesca del merluzzo in Atlantico, nella raccolta del corallo nel Mediterraneo, negli scambi con il Baltico e con l’oceano Indiano. La Colley descrive nei dettagli questa fase di protoglobalizzazione dell’economia e l’ascesa della Gran Bretagna come potenza mondiale.
Le storie emozionanti che riguardano Elizabeth cominciano quando Crisp fa bancarotta in una crisi che ha le sue radici nella guerra di successione spagnola e, dopo aver sperato di cominciare una nuova vita nelle colonie americane, parte per Dacca, nell’odierno Bangladesh, che era all’epoca un’avamposto della Compagnia delle Indie. Elizabeth, rimasta a Londra, parte per raggiungerlo nel 1770 e ci arriva sette mesi dopo avendo fatto tappa anche a Rio de Janeiro (il Boeing 747 non era ancora stato inventato). A Dacca Crisp riesce ad avviare una nuova attività commerciale ma la moglie sembra apprezzare poco la vita in colonia o i doveri familiari: prima rispedisce la figlia in Inghilterra, poi affida il figlio di 9 anni a un mercante che frequenta l’Iran perché impari il persiano e, infine, lascia il marito per un tour dell’India orientale che dura 18 mesi. Nel 1777 lo abbandona definitivamente per raggiungere la famiglia a Londra e torna a Madras solo dopo la sua morte, probabilmente per occuparsi dell’eredità (in realtà, solo debiti).
Fin qui il volume della Colley, che si basa essenzialmente su un libro scritto dalla Marsh per raccontare le sue esperienze in Marocco, The Female Captive, e su uno scarno diario del viaggio in India (censurato dalla famiglia) da cui appare chiaramente che Elizabeth era una sciocchina principalmente interessata alla vita di società, sia pure capace di affrontare i rischi e le fatiche fisiche dei viaggi settecenteschi (il Club Mediterranée non era ancora stato inventato). Le parti interessanti di L’Odissea di Elizabeth Marsh sono quelle in cui si parla dell’ascesa della potenza inglese, della spietatezza con cui armi e commercio marciavano insieme, della mobilità sociale nella Londra dell’epoca.
Tutto questo cosa diventa nella paginata di Repubblica del 20 agosto? Un ridicolo “Elizabeth alla conquista del mondo”, illustrato da un quadro dove marito e moglie consultano inseme una carta geografica. Peccato che si tratti palesemente di un dipinto che non c’entra nulla con l’epoca di Elizabeth Marsh perché mostra due coniugi vestiti alla moda di fine Ottocento, o forse inizio Novecento, che studiano quella che sembra essere la carta di un’isola nella sala da pranzo di una comoda villa da qualche parte nel Mediterraneo (si vedono le linee altimetriche). Una “conquista del mondo” che non sembra andare più lontano di Capri, Ibiza o Porquerolles, insomma.
Torniamo a Citati, che non solo cede alle lusinghe dell’ufficio stampa ma ci mette del suo: la madre di Elizabeth Marsh, Elizabeth Bouchier, era “probabilmente una mulatta”. La Colley si limita a dire che la vedova conosciuta da Milbourne Marsh in Giamaica non compariva nelle liste degli immigrati dalla Gran Bretagna né in quelle dei bambini battezzati in loco, però potrebbe essere stata la figlia di una donna presente nei registri di Port Royal con il nome Margaret Boucher, una grafia leggermente diversa, come abitante nella parrocchia di razza bianca. Oppure, in teoria (conceivably) “potrebbe essere stata una mulatta, la figlia battezzata di un proprietario terriero bianco (…) e di una madre schiava africana”. La Colley non dà alcun elemento per affermare che Elizabeth Bouchier era “probabilmente una mulatta”: si limita a registrare anche questa possibilità in mancanza di fonti certe.
Passiamo alla Kingston, la nave che riportò in Inghilterra Milbourne Marsh e la moglie. Citati si preoccupa di precisare che “doveva impedire il contrabbando dello zucchero della Giamaica, e gli assalti degli spagnoli alle navi mercantili inglesi” ma omette la parte più interessante della frase, che è: “…and to suppress any slave rebellions within Jamaica itself”. Un particolare non trascurabile: il motivo della partenza era una rivolta di schiavi, chiamati maroons, nell’interno dell’isola, una rivolta che portò il governatore a proclamare la legge marziale e a chiedere l’invio di sei compagnie di soldati per fronteggiare la situazione. Marsh, lui stesso proprietario di alcuni schiavi, decise di filarsela prima che la situazione precipitasse, o almeno prima di essere arruolato nella milizia che doveva difendere la capitale. Quattro anni dopo, gli schiavi ribelli avrebbero costretto gli inglesi a firmare un trattato per mettere fine alla guerriglia e sarebbero rimasti di fatto indipendenti fino al 1796.
I Marsh si imbarcano e, scrive Citati, la moglie “passava le giornate sul ponte della Kingston”. Forse sulle navi passeggeri di oggi i turisti passano le giornate “sul ponte” nel senso di stare all’aperto a guardare il mare ma su una nave da guerra inglese del ‘700 il ponte era un luogo alquanto affollato di marinai addetti alle vele, che sicuramente non volevano donne impiccione tra i piedi (la Costa crociere non era ancora stata inventata). La signora Marsh, scrive la Colley, “si riposava sul ponte inferiore (orlop deck) il posto più tranquillo, buio e riparato [che ci fosse] a bordo”.
Nasce Elizabeth che, come abbiamo visto, ha una vita senza emozioni fino a 19 anni, poi segue i genitori a Minorca e, nel 1756, a Gibilterra, dove il padre è incaricato di ispezionare le fortificazioni e proporre miglioramenti in vista di un possibile attacco francese o spagnolo. La guerra, e le epidemie, convincono immediatamente la ragazza che non è un posto per lei e decide di tornare in Inghilterra, facendosi catturare dalle navi del sultano del Marocco.
La permanenza a Marrakech di Elizabeth Marsh dura pochi mesi e James Crisp, il compagno di prigionia fatto passare per marito allo scopo di frenare l’interesse virile del sultano, chiede la sua mano nel 1757 e la ottiene. Seguono dieci anni di vita tranquilla e agiata a Londra, in cui Elizabeth dà alla luce due figli e non pensa affatto alla “conquista del mondo” (i marines amricani non erano ancora stati inventati). Nel 1767 Crisp fa bancarotta, a causa della perdita della sua base commerciale sull’isola di Man, indipendente fino al 1765, e di una crisi commerciale nel Mediterraneo: a Genova le sue navi cariche di granaglie vengono sequestrate per fronteggiare l’emergenza carestia. Citati preferisce sottolineare che Elizabeth “rimase sola con due figli di nemmeno sette anni, senza casa, senza danaro e senza un lavoro di qualsiasi genere”.
Per quanto riguarda il “lavoro”, dal libro della Colley non risulta che Elizabeth abbia mai fatto nulla in vita sua, se non chiamare la servitù per farsi servire il tè, o portare in palanchino quando era in India. E’ vero che nel 1767 l’intraprendente Crisp non aveva più quasi nulla ma nel frattempo la famiglia della moglie aveva fatto strada, in particolare lo zio George Marsh, che era diventato Clerk of the Acts, il funzionario più alto in grado della marina: Elizabeth non rischiò mai di restare senza un tetto. Infatti, quando il marito partì per l’India in cerca di fortuna lei rimase tranquillamente a casa dei genitori a scrivere The Female Captive per occupare il tempo e anche guadagnare qualche soldo (il libro vendette 750 copie, una tiratura rispettabile per l’epoca, ma non fu ristampato). Poi, come si è detto, raggiunse il marito con una navigazione non facile nell’Atlantico, ma nulla di più avventuroso di quel che capitava a mercanti, soldati e marinai che a decine di migliaia andavano e venivano per mare all’interno dell’Impero britannico.
Quanto alla scoperta dell’India sconosciuta (il viaggio di 18 mesi in India, “per terra e per mare” su cui Citati si dilunga) basterà dire che la nostra esploratrice definisce “moschee” i templi indù e manifesta ad ogni tappa la sua pocaggine: “Era l’ignoranza il maggior ostacolo per lei” scrive onestamente la Colley. E’ sempre l’autrice inglese a spiegare che gran parte della cosiddetta odissea consistette in visite alle città e alle basi commerciali della Compagnia delle Indie in compagnia di tale George Smith, che Elizabeth presentava come suo “cugino”. Durante queste tappe, alcune delle quali durarono per settimane o mesi, Elizabeth Marsh si dava al ballo, ai party e in generale ai piaceri della vita coloniale : non precisamente un safari nella giungla, né l‘esplorazione dell’Antartide in solitario (le spedizioni polari non erano ancora state inventate).
I commenti a questo post sono chiusi

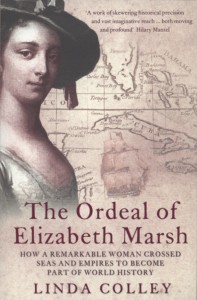

Ovvio, il regime mondialista vuole che la storia sia interpretata secondo canoni femministi, multirazziali, omosessuali ecc…
Naturalmente ogni regime interpreta e manipola la storia a suo modo, comunque oggi fare lo storico è uno dei mestieri più pericolosi che ci siano, si rischia anche di finire in galera…
Ma è chiaro che chi scrive su “Repubblica” non rischia niente!
Urrah! Che gusto, Citati vittima della propria nonlettura… imperdibile!
Occhio, in campana miei cialtroni
della carta st(r)ampa(la)ta,
ché a sturar il vostro ugello
ci pensa il vigile Tonello!
Beh, certo che anche la copertina dell’edizione originale non scherza: “L’odissea di Elizabeth Marsh: Come una donna eccezionale attraversò mari e imperi per divenire parte della storia del mondo”.
Sticazzi…
Va bè ma questo è cercare il pelo nell’uovo.. ^__^
.. grande!!!
la rima di D’angelo è oscena ^__^
@Ares
appunto!…
che palle voi razionalisti
sempre tutto preso sul serio, alla lettera
siete noiosi noiosi noiosi
che importa se quello che dice citati sia vero o meno???
il fatto è che scrive da dio
ed il senso della letteratura è proprio questo
altrimenti leggevamo i manuali di logica