Chat noir Chat
Schwarze Katz (il gatto nero)
di Francesco Forlani
a Raul di Isabella
Un nome così a Berlino, a Parigi, non suscita mica ilarità, mica si presta ai doppi sensi, con quella sua pronuncia che sulla seconda parola accentua le zeta con indomita soddisfazione, come succede da noi, mica da voi. Da noi se chiami un Pub Schwarze Katz, minimo minimo ti arrestano per oltraggio al comune senso del pudore, oppure, non se ne fa nulla perché da noi tutto è oltraggio. La città moderna è oltraggio alla Reggia che si gira sull’altro fianco della pianura, e a quella antica che si limita a darle un’occhiata dalla Torre impizzata nella collina. E la guarda fare, la sua vita che è oltraggio alla vita. Alessandra Schwarze Katz era la vita. Avevamo pochi anni, ma nell’epica di quei pochi anni diciamo che lei era l’eroina mentre io non contavo un cazzo per nessuno. Per nessuno tranne che per lei, che mi dedicava sempre grandi sorrisi ogni volta che ci vedevamo in comitiva, giganteschi mostri di motorini e braccia che si muovevano lungo un perimetro assai ristretto e che si sviluppava intorno al centro della città lungo un asse che andava dalla sala giochi del Jolly Joker, con il muretto poco distante di una piccola piazza, fino alla fine della centralissima Via Mazzini. In una delle stradine sulla destra c’era appunto lo Schwarze Katz, il gatto nero. Il mio gatto invece era grigio, pelo lungo, persiano, una gatta in verità dal nome imprestato dagli Aristogatti, Minou come qualche anno prima avevamo depredato per il nostro dalmata, il nome Pongo alla carica dei centouno. Avevamo in famiglia di vero borghese soltanto gli animali domestici e dio.
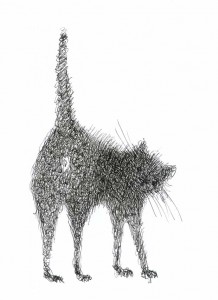
Così mentre Minou mi faceva le feste sempre quando tornavo succhiandomi l’anima ogni volta che, da sotto al braccio scostava il muso a sporgersi sulla mia faccia per trasformare il mio respiro in un ingranaggio di voce, un motore di fusa regolari in un travaso di vita interrotto soltanto dal risveglio, ritrovavo ogni giorno, subito dopo i compiti l’amico del cuore e di sigarette Cicciotto dell’Aquila. Io di borghese avevo il latino del mio liceo, lui tutti i libri del Capitale, e di Lenin, lasciati in giacenza da suo fratello in fuga per l’italia. E così un giorno tra le braccia del mostro giovinezza si erano sfiorate appena le falangi di una confraternita all’interno della grande comitiva, confraternita in cui due sorelle avevano varcato la soglia della solitudine autistica di due adolescenti, ed una delle due sorelle era Ale, Alessandra Schwarze Katz. C’era di mezzo sicuramente il cuore, non mio – chi non conta un cazzo il cuore se lo sogna appena per dimenticare il resto – e non so quante settimane si sarebbero susseguite né se quel tempo fosse umano o gattesco, con quella storia di un anno vale sette, un giorno un mese. Un gatto si sa che non fa in tempo a vivere che già muore, e per questo si commuta il computo in un nove vite, nove code, con cui graffiare ogni corpo che respiri, prendere a morsi l’inarrestabile durare delle cose, fino a sbrecciare il tempo e ridurlo a memoria. Quando non poteva venire andavamo noi da lei, nel piccolo pub di una strada a pochi passi dalla sede di Lotta Continua. Interdetta a Cicciotto più per gesto di autocensura – le visite domiciliari notturne della Digos si perpetuavano nella volante appostata sotto casa quando il fratello di Ciccio era ancora latitante e si sperava di acciuffarlo al rientro.
Ale ci offriva allora da bere e quando non c’era più gente, in chiusura abbandonava il banco al suo corso per sedersi con noi e tirare su i piedi sul tavolo di noce, dove le punte quadrate dei Camperos si allineavano ai boccali da birra da un litro pesanti e luminosi come lampadari. A Minou venivano spesso dei nodi di pelo che le impedivano di respirare, e nonostante le spazzole e il talco che le davamo a turno, fratello dopo fratello, sorella dopo sorella talvolta bisognava tagliargli dei ciuffi di pelo facendo attenzione a non tagliarle la pelle. E così nonostante quei buchi attraversava la casa fiera e rigonfia come una nuvola, pronta a farsi grattare ogni volta, a carezze che staccando gli occhi dai libri di storia le facevo, con la gratitudine di averla come compagna. Alessandra Schwarze Katz, dai capelli corti che sembrava cantarti e invece parlava sempre sommessamente le note portanti di “ragazza dell’Europa”, con maglioni colorati, le guance rosse da nord e da timida rivolta, era stata compagna di altri, non mia.
Quando finirono quei giorni, un mese, un anno, sarei partito poco dopo per andare in collegio. E allora capitava che durante le libere uscite talvolta incontravo gli amici fraterni di un tempo, ed anche lei, una volta, sul corso principale della città, e dove nonostante i capelli rasi al suolo dalla caserma, e l’uniforme da cadetto, mi dedicò lo stesso sorriso d’un tempo. Nell’epica dei quindici anni non c’è perdono che assolva l’abbandono e l’assenza delle persone che abbiamo amato, ma accade che il tratto di strada che s’era condiviso lasci tracce tanto profonde che per quanto si prendano strade diverse, dell’uno e dell’altro risuonano i passi e le orme, sono cose vive.
Quando un gatto comincia a perdere la vista, te ne accorgi da come si serva delle pareti come un bastone, e così, accasciata lungo lo stipite in basso della porta, mi aspettava ogni fine settimana, durante i permessi della scuola militare. Nulla è più terribile nella vita di un gatto della velocità con cui la parola vita percorre il suo giro. Nella velocità vertiginosa di un giro di giostra, di una giovinezza che bastava a se stessa con la stessa ineluttabilità dei grandi destini compiuti del mondo del Rock. Janis Joplin, Jimi Hendrix, e poi quasi per ultimi John Lennon e Bob Marley. A comunicarmelo era stato un mio compagno di corso Ciccio Panico, amico della migliore amica di Ale. Cioè a dirmi che Alessandra Schwarze Katz, se n’era andata, partita, scomparsa, trasferita, ci aveva lasciati, di merda, quello sì, con un gesto che somiglia a un volo, se non ci fosse il catrame ad accoglierti. Minou, aveva smesso di respirare alla fine di un sogno. Ricordo mio padre, che di tutti l’amava forse meno, raccoglierla da terra con le lacrime agli occhi e una forza che sembrava dire nella mutezza di quei momenti, che a noi sarebbe rimasto solo il dolore astratto della pena di non vedere più, quella nuvola di grazia che saltava, graffiava, scivolava sul tavolo della sala da pranzo riuscendo ogni volta a evitare di rovinare contro il vaso di cristallo innalzato al centro. A noi avrebbe risparmiato il lavoro sporco della sepoltura. Eppure, ogni volta che un gatto nero mi attraversa la strada, penso che sia lei, in una terza o quarta vita rapita alla vita felina. Altrimenti come spiegarsi il fatto che non ci siano cimiteri per gatti? Alessandra Schwarze Katz, una ragazza così a Berlino, a Parigi, non muore mica ogni volta, mica si presta ai dubbi, ai rimorsi, con quella sua andatura di chi sa cosa significhi la vita, di chi sa a chi si debba sorridere e a chi no, e che ti lascia un segno nell’anima ogni volta che pronunci il suo nome e sulla seconda parola accentui le zeta con indomita soddisfazione, come succede da noi, mica da voi.
Racconto che uscirà in un’antologia curata da Isabella Borghese a fine anno.



Quando Francesco Forlani racconta dal suo paese, dalla sua città, dalla sua infanzia, accade il miracolo di tenerezza. Ho letto questo racconto in una lettura nel senso primo, anche se immagino che il gatto nero sia un simbolo. E’ un omaggio al più magnifico animale che sia nel mondo.
Il felino ha vita nuova, di un salto attraversa spazio di eternità. Si invita da noi, con incredibile dolcezza, come lo racconta Francesco, e accompagna i momenti della giovinezza, si mette sul nostro petto e consola di tutto, è l’ombra della nostra amicizzia. Il gatto grigio, nero, fa della nostra vita un brano epico di libertà e di mistero.
Se il gatto penetra la nostra mente, rimane con il suo pensiero segreto. Penso sul serio che il gatto conosce tutto del cuore umano e dell’eternità. Penso anche che il gatto è uno scrittore felice, che vede cose che sigillano i nostri occhi.
E mi sembra che regalando una parte del suo cuore, Francesco ha raggiunto questa felicità solo conosciuta dai gatti.
Piccola aggiunta: i designi di Raffaella Nappo dedicano tutta la bellezza e l’impertinenza ai gatti.
Mi piace. Di solito l’autobiografismo mi deprime, ma Forlani no. Qui la ragazza-gatto, il nome tedesco schwartze katz, dal suono esitante tra il grottesco e il magico, e il gatto in carne ed ossa dell’autore, sono elementi che permangono accostati e non sovrapposti, non forzati a simbolo, e formano quella che Benjamin avrebbe chiamato una’costellazione’, sotto la quale il racconto personale puo’ trovar luogo, cioe’ non restare solo, appunto, personale. Restituendo, ad esempio, lo struggente senso di incompletezza del’adolescenza, la cui arcata di vita manchevole nel ricordo si protende pero’ con il sapore dell’epica. Etc.
Ma oggi, caro Furlèn (a proposito, davvero bravo il tuo quasi omonimo uruguayo), oggi cos’hanno di “vero borghese” in casa le famiglie italiane, a parte il dio dei crocifissi leghisti?
diciamo roberto che quello che un tempo le famiglie avevano di borghese in casa oggi ce l’hanno in garage ! effeffe
grazie a fabrizio per la lettura (e scrittura) che ne ha fatto e che condivido in toto, (beh tranne il bravo che altrimenti fa kitsch)
effeffe
Mi parli di “visioni” a volte o delle mie “allucinazioni” come quelle che sanno “di uomini con cani in spalla” ad esempio … le tue profumano di assoluta quotidianità e son talmente belle che non te ne accorgi neanche che forse oggi non esistono più.
gustoso raccontino, e solito talento di ff nello scovare disegni e immagini fantastiche (qui una fantasticità stecchita e filamentosa)