Fabrica di Fabio Franzin
[a cura di Franz Krauspenhaar]
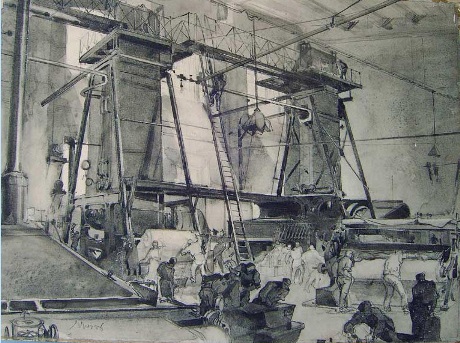
Fabrica (Atelier, pagg.96, euro 10,00) di Fabio Franzin, nato a Milano nel ’63 da genitori veneti, è una specie di bomba; un ordigno che preme dal cuore e dallo stomaco del poeta e che deflagra sulla pagina, narrandoci una storia, la propria, che è quella del duro quotidiano degli operai di oggi. La storia di un lager come mille altri, Una giornata di Ivan Denisovic in versi, dove il protagonista di una giornata nel gulag è qui il poeta stesso, operaio nel Nordest operoso e disperato, disperso nell’assenza di valori, chino sulla fresa e sul piatto di minestra nelle stanche sere della tregua. Si tratta di un vero poema della fabbrica, del canto agonizzante di un girone infernale del lavoro, scritto nel dialetto veneto praticato dall’autore e con un testo a fronte in italiano, così che possiamo leggere i versi nelle due maniere e accostare non solo due lingue ma anche due modi d’intendere; Fabrica è qualcosa di doloroso e importante che ci riporta ai tempi nei quali i nostri migliori scrittori e poeti si occupavano di questi problemi, quando scrivere era spesso trasferire esperienze personali difficili, rianimare un passato o un presente di bisogno, riscattare e innalzare, col potere della letteratura, il basso dai propri sotterranei e spesso imprendibili cunicoli. Ora ci si rifugia nell’alienazione della vita privata, spesso scopiazzando il nostro cinema minimale e anemico, come se il mondo della fabbrica, le aziende coi loro organigramma del potere rozzo e prefabbricato, il lavoro nudo e crudo che impasta e sporca e spesso annienta un giorno dopo l’altro non fossero materia di poetica denuncia e attenzione incisiva, non fossero più artisticamente trattabili. Fabio Franzin colma un grosso vuoto in Italia in campo letterario. Fabrica l’ho letto d’un fiato, senza interrompermi, col fiato sospeso dall’emozione che dà solo la verità sporca, nuda, inaccettabile. (f.k.)
FABRICA
(Fabbrica, nel dialetto Veneto dell’Opitergino-Mottense (Treviso)
(…o se anche soltanto vogliamo renderci conto di quello
che avviene in un grande stabilimento industriale)
da “I sommersi e i salvati” di Primo Levi, Einaudi, 1986
(a Metello, a Cipputi)
Varda chii operai, varda
come che i se perde via
fra i só pensieri intant che
i se fuma ‘na cica sentàdhi
contro ‘l muro dea fabrica
vàrdii, stràchi e spàzhi,
co’i gins che ‘na volta
i ièra quei boni, e ‘dess
i ‘é sol un pèr de bràghe
màssa curte e taconàdhe
‘e scarpe zhòzhe de còea
o de ojàzh, zhéjie e cavéi
zai de segadùra. I par squasi
dei pajiàzhi scanpàdhi via
da un circo, cussì, ridìcoi
e maincònici come i comici
del cinema mut, e muti i ‘é
anca lori parché ‘a fadìga
ghe ‘à portà via ‘a paròea
vàrdii ‘dèss che i schinzha
‘a cica soto i pie e a testa
bassa i torna dae machine
che spèta ‘ncora i só sèsti
servi; i sogni soeàdhi lontani.
Guarda quegli operai, nota / come sono assorti / fra i loro pensieri mentre si / concedono una sigaretta seduti / contro il muro della fabbrica // guardali, stanchi e sporchi, / con i jeans che un tempo / erano alla moda, ed ora / sono solo un paio di brache / troppo corte e rattoppate // con quelle camicie sbiadite, / le scarpe lerce di colla / o di oliaccio, ciglia e capelli / gialli di segatura. Sembrano quasi / dei clown fuggiti // da un circo, così, ridicoli / e malinconici come i comici / del cinema muto, e muti sono / anche loro perché la fatica / gli ha estirpato la parola // guardali ora mentre schiacciano / la cicca sotto i piedi e a capo / chino ritornano dalle macchine / che attendono ancora i loro atti / servili; i sogni volati altrove.
Se sta là, tuti ‘tacàdhi,
sì, ma parché toca, pì
che altro, picàdhi tuti
aa cadhéna del bisogno,
fin che ‘a ne tièn duro.
Un fià come chii carèi
‘tacàdhi in fra de lori
fòra dai supermercati:
po’ ‘riva un parόn nòvo,
el fraca un schèo drento
el tό scasseìn, el te porta
via co’ lu; contento de tì
el te inpenìsse, te colma
de ròbe e regài. Po’- te ‘o
capisse sol aa fine del sό
percorso – le svòdha tute
tel baùl suo, chee ròbe,
fra i tό feréti in crose
resta sol che un sachét
de bajìji, desmentegà
là, forse par sbàjio. Co’
el te torna ‘tacàr al tό
luchét, i ‘à stuà ‘e luci;
te sta là, picà ben strent
a fradhèi che no’ te conόsse.
Si sta lì, tutti uniti, / sì, ma perché tocca, più / che altro, appesi tutti / alla catena del bisogno, / finché tiene. // Un po’ come quei carrelli / uniti fra loro / fuori dai supermarket: / poi giunge un padrone nuovo, / spinge un euro dentro // il tuo taschino, e ti porta / via con lui; contento di te / ti riempie, ti colma / di cose e regali. Poi – lo / comprendi solo alla fine del suo // percorso – le svuota tutte / nel baule della sua auto, quelle cose, / fra i tuoi ferretti in croce / rimane solo un sacchetto / di noccioline, dimenticato // lì, forse per sbaglio. Quando / ti riaggancia al tuo / lucchetto, hanno spento le luci; / rimani lì, legato ben stretto / a fratelli che non conosci.
Un zhigo. E po’l nostro
‘córer verso ‘l compagno
che i ‘é za drio portàr via;
tel traversón nero del capo.
E chea macia de sangue
scuro là, tea segadhura,
come un continente nòvo
te ‘na carta gìografica
del lavoro; cussì de sèst
tea segadhura. ‘E jozhe
perse drio i reparti par
che ‘e segne un sentiero
de doeór. Po’ chel bissi-
bissi bass fra un siénzhio
che pesa. Se va in zherca
dei dó tòchi de déo come
che, altre volte, se zherca
‘l càibro, ‘l bòro o ‘a ciave
da disdòto… Calcùn varda
chea lama colpévoe… Po’
el capo ne ricorda che no’
sen qua pa’ perderse via;
se torna sòchi drio i tòchi
da far, co’i déi che trema.
Un urlo. E poi il nostro / accorrere verso il collega / che già stanno portando via; / una sua mano avvolta / nel grembiule nero del capo. // E quella chiazza di sangue / scura, lì, sulla segatura, / come un continente nuovo / nella carta geografica / del lavoro; così opportunamente // sulla segatura. Le gocce / sparse lungo i reparti sembra / che traccino un sentiero / di dolore. Poi quel brusio / di voci sommesse fra un silenzio // che pesa. Si cercano / due falangi come, / altre volte, si è cercato / il calibro, il pastello di cera o la chiave / da diciotto… Qualcuno guarda // quella lama colpevole… Poi / il capo ci ricorda che non / siamo qui per perdere tempo; / e mesti ritorniamo ai nostri pezzi / da fare, con le dita tremanti.
Chissà se ghe sarà mai
perdono pa‘e bestéme
che ghe sbrissa fòra
daa boca ai operai, se
Dio no’l sarà anca lu
là, in pie, a ‘spetàrli
co’e man strente drio
‘a schena, el vistito scuro,
i ociài de oro che slusa;
come ‘n’antro parόn
pronto a darghe ‘a carne,
a ‘contarghe pa’a mièsima
volta ‘a fàvoea de chi che
l’à creà un mondo da sol,
senza riposàr mai, nianca
el sètimo zorno. Chissà
se inmanco lu ‘l capirà
che porchidhàr vièn cussì
naturàe drento ‘na fabrica,
che anca al pì sant casca
tee man un dio, ‘na madhόna
òni tant, casca chel nome
sacro in mèdho aa pressa
e al sudhόr, al doeόr de no’
‘ver pase, aa crose dee ore.
Chissà se ci sarà mai / perdono per le bestemmie / che sgusciano fuori / dalle labbra agli operai, se / Dio non sarà anche lui // lì, in piedi, ad attenderli / con le braccia strette dietro / la schiena, il vestito scuro, / gli occhiali dorati che luccicano; / come un altro padrone // pronto a mostrargli il danno, / a raccontargli per l’ennesima / volta la favola di chi / ha creato un mondo tutto da sé, / senza riposare mai, neanche // la domenica. Chissà / se almeno lui comprenderà / che bestemmiare viene così / naturale dentro una fabbrica, / che anche al più santo cade // nelle mani un dio, una madonna / ogni tanto, cade quel nome / sacro fra la pressa (la premura) / e il sudore, il dolore di non / trovar requie, alla croce del tempo.
Marta l’à quarantatrè àni.
Da vintizhinque ‘a grata
cornìse co’a carta de véro,
el tanpón, ‘a ghe russa via
‘a vernìse dura dae curve
del ‘egno; e ghe ‘à restà
come un segno tee man:
carézhe che sgrafa, e onge
curte, da òn. I só bèi cavéi
biondi e bocoeósi i ‘é ‘dèss
un grop de spaghi stopósi
che nissùna peruchièra pòl
pì tornàr rizhàr. Co’a cata
‘e só care amighe maestre
o segretarie, ghe par che
‘e sie tant pì zóvene de ea,
‘a ghe invidia chee onge
cussì rosse e longhe, i cavéi
lissi e luminosi, chii déi
ben curàdhi, co’ i sii pàra
drio ‘e rece, i recìni. Le
varda e spess ‘a pensa
al só destìn: tuta ‘na vita
persa a gratàr, a gratarse
via dal corpo ‘a beézha.
Marta ha quarantatre anni. / Da venticinque / leviga cornici col tampone, / la carta abrasiva, con questi umili strumenti frega / la vernice dura nelle modanature // del legno; e le è rimasto / come un segno nelle mani: / carezze che graffiano, e unghie / tozze, da uomo. I suoi bei capelli / biondi e ondulati sono ormai // un groviglio di spaghi stopposi / che nessuna parrucchiera potrà / più rimodellare. Quando incontra / le sue coetanee, maestre / o segretarie, le trova // tanto più giovani, / le invidia quelle unghie / così rosse e lunghe, i capelli / lisci e luminosi, quelle dita / ben curate, quando se li scostano // dietro le orecchie, gli orecchini. Le / osserva e spesso pensa / al suo destino: tutta una vita / persa a grattare, a fregarsi via dal corpo la bellezza.
A Roberto no’ l’é che
‘e ghe piase pì de tant
‘e batùdhe e ‘e barzeéte
che ‘l diretór el conta
co’l passa fra i reparti
come pa’ dirghe “vedéo
che simpatico che son,
che òn bon” no’ le trova
cussì comiche, zherte po’
le conósse za, però, visto
che ridér no’ costa niént,
visto che tuti i só coèghi
i se sganàssa, lo fa ‘nca
lu, parché ‘l sa che sì, che
insóma convièn sempre
èsser un fià lechìn, che l’é
sempre mèjio tègnersee
bone zherte persone, i capi
spèzhie, quei che comanda;
là in fabrica, po’, l’à vist
de sì se fa pì strada, l’é pì
fàzhie far carièra, e ‘lora,
capìa ‘a règoea ‘l se ‘dàta,
in coro. Manco duro ‘l lavoro.
Roberto non le trova / così irresistibili / le barzellette e le battute / che il direttore racconta / quando sosta fra i reparti // come se volesse suggerire a quelle maestranze “vedete / che simpatico sono, / che buon uomo” non le trova / così comiche, certe poi / sono anche vecchie, però, dato // che ridere non costa nulla, / dato che tutti i suoi colleghi / si scompisciano, lo fa anche / lui, perché sa che sì, che / insomma conviene sempre // essere un po’ yes-man, che è / sempre meglio tenersele / buone certe persone, i superiori / specialmente, quelli che comandano; / lì in fabbrica, poi, ha constatato // che a ridere e ad annuire / sempre si fa più strada, è più / semplice far carriera, e allora, / capìta quella regola vi si adatta, / in coro. Meno duro il lavoro.
El Repetón po’, e cussì
tant che ‘l par pròpio
lu, tee fabriche, ‘l parón;
tut un tun-tun de pache,
de sfiati, un gron-gron
continuo de rui e cadhéne…
e dee volte el par davéro
insoportàbie, come se
calcùn, chel dì, ‘l ‘vesse
alzà de colpo el voeùme
fin a farte s.ciopàr ‘a testa;
‘bituàrse no’ l’é fazhie, no’
l’é fazhie farlo deventàr
sol un sotfondo. In fondo
a chel rumór sta ‘a tortura
pì granda de òni operaio:
‘e paròe bisogna che ‘e se
stòrde in zhigo pa’ esister,
là in mèdho, sorde ‘e vose
che ciama indrìo un sogno.
Fabriche come discoteche
senza bàeo. El siénzhio
se sconde sot ‘e tasse ‘ndo’
che l’òn che no’ saeùdha
buta via ‘l veén pa’ i sordi.
Il Frastuono poi, e così / assordante che sembra proprio / esso, nelle fabbriche, il padrone; / tutto un pulsare di colpi, / di sfiati, uno stridio // continuo di rulli e catene… e alle volte pare davvero / insopportabile, come se / qualcuno, quel giorno, avesse / alzato di colpo il volume // sino a farti scoppiare la testa; / assuefarcisi non è facile, non / è facile ridimensionarlo / sino a sottofondo. In fondo / a quel rumore sta la più sadica / tortura per ogni operaio: le parole debbono / piegarsi in urlo per esistere, / lì in mezzo, sorde le voci / che chiamano a sé un sogno. // Fabbriche come discoteche / senza balli. Il silenzio / si nasconde sotto i bancali ove / l’uomo che non saluta mai / butta i bocconi avvelenati per i topi.
Lore, ‘e Machine: ‘e sie
presse, torni, o scaricatóri,
‘e sta là, ciuse tel siòeo
dea fabrica, co’e só vidhe,
‘e só cabine, i só perni
co‘l peso de tut ‘l só fèro,
i só manomètri, i botóni.
Vardarle ‘a matina, cussì
ferme e siénzhiose, cussì
bone, fa squasi sujezhión:
come de ‘verle sorprese,
de scondión, intant che
‘e se riposéa, intant che
no’e se ‘o ‘spetéa. Po’
i motori i parte, e tuta
chea feràjia trema, i rui
gira, ‘e cadhéne cridha,
se inpìzha i botóni verdi,
e quei rossi che lanpidhéa;
pin piàn Gòldreik se svéjia
el taca a mòver i só brazhi –
tentàcoi, a scati, el te brinca
e co’e só lame de aciàio el
tàjia a fetine ‘a tó ànema,
el ghe fa ciao aa tó libertà.
Esse, le macchine: siano / presse, torni o scaricatori, / stanno lì, infisse nel suolo / della fabbrica, con le loro viti, / le loro cabine, i loro perni // col peso di tutto il loro ferro, / i loro manometri, i pulsanti. // Guardarle al mattino, così / immobili e silenziose, così / innocue, fa un po’ soggezione: // come di averle sorprese, / di nascosto, mentre si concedevano / un riposo, mentre / non se lo aspettavano. Poi // i motori si avviano, e tutta // quella ferraglia si scuote, i rulli / girano, le catene ringhiano, / si accendono i pulsanti verdi, / e quelli rossi, lampeggianti; / un arto dopo l’altro Goldrake si ridesta // inizia a muovere le sue braccia – / tentacoli, a scatti, ti afferra / e con le sue alabarde d’acciaio / taglia a fettine la tua anima, / dà l’addio alla tua libertà.
I commenti a questo post sono chiusi


beh, bellissime!
Quando i suoni immaginati delle parole lette sottovoce si mutano nelle immagini della fabbrica e ti fanno venire un nodo alla gola… credo che la poesia abbia raggiunto (o superato) il suo scopo.
Un nuovo Pasolini?
Semprini Nevio