Le scimmie all’aeroporto
|
|
[ img © ,\\’ ]
di Paolo Sperandio
Esimio Scrittore,
quella che legge non è una storia vera, non è una storia inventata, forse non è una storia. Tutto quello che è sta nel titolo, che sta nella mia memoria del Poeta. Avevo oltrepassato la sua esistenza come il sangue scavalca un grumo venoso, che c’è però non fa male, finché non ho letto il Suo articolo. Più che un articolo un monito, un richiamo al rispetto: abbiate rispetto del Poeta. A chi è rivolto? Se, come Lei afferma, “il mondo è dei mediocri”, sono i mediocri a leggere i giornali. Come me.
Li leggo nelle pause, tra due infarti, tra un’angina e un’aritmia sistolica. Nei monitor brilla lo zig-zag di quella striscia verdina che tratteggia la vita dei pazienti. Quella del Poeta è la più irregolare, dalla stanzetta in fondo al corridoio rimanda le sue torsioni elettriche per rimanere vivo. Come qualsiasi altro malato. E’ il ronzio uniforme delle macchine che dovrebbe rassicurarmi, e che mi fa invece dubitare delle mie decisioni. Che farò quando si metterà a vibrare, quando la spia rossa lancerà un fischio di allarme perché i contorcimenti del Poeta stanno avendo la peggio? Sarà il momento che ho atteso, senza saperlo, da trent’anni, eppure ancora ne ignoro la ragione. Abbassare il volume, allacciarmi meticolosamente le scarpe e uscire senza fretta, magari fermandomi in bagno, perché muoia una buona volta, e da solo… Oppure precipitarmi coi farmaci e il defibrillatore già acceso, salvarlo? Il gelo di queste luci bianche condensa blocchi interi di stanchezza, sento che dovrei partecipare più da vicino agli eventi, stare vicino a me stesso mentre sta compiendosi tutto. Ma Lei ha ragione, al Poeta “si può fare del male con poco”. Troppo poco, per una vendetta.
E’ questo che vorrei farLe capire: pur essendo un mediocre non ambisco vendette. Lei così introspettivo, così attento indagatore dell’anima, mi domanderà allora perché decisi di fare medicina, perché di darmi proprio alla cardiologia. Sarebbe arguto collegare la scelta ai malesseri di quell’ombroso adolescente, di cui già la Poesia turbava il cuore con le sue irrequietezze. Più blandi, i malesseri miei dell’età, credo ormonali, non meritavano che lui li considerasse, non erano degni del suo sguardo “al mondo nella sua interezza”. Perché (mi permetto nuovamente di citarLa) già allora il Poeta scopriva che “esiste un altro livello a cui si può convocare la vita, e sentirla, accusarla, denunciarla, avversarla e, nonostante tutto, volerla”. Mi chiesi allora (e non ho smesso di chiedermi) se al di sotto di questo livello non c’è altro che colpa. Se perché annusavo le ragazze, perché mi appassionavo alle motociclette e alle avventure spaziali più che a Gide, se per questo meritassi un disprezzo così intenso, così definitivo e aggregante.
Era la strategia del Poeta. Aggregava intorno a un nucleo di insulti i seguaci di passaggio, li caricava del medesimo spregio rivolto verso bersagli cangianti, vittime mobili inclini a scambiarsi di posto coi seguaci, secondo i tempi. La mia condanna era di essere poco seguace e quasi sempre bersaglio. Avvertivo il suo lavorio per escludermi dalle gite infarcite di cannabis, dalle blues-session cui non davo alcun apporto musicale. Lei oggi mi spiega che ero parte di un “mondo grasso e volgare”, e ben mi sta perciò, retrospettivamente ben mi stava.
Il ronzio delle apparecchiature ha la stessa linearità di un passato troppo distante per smuovere alcunché. Sto curvo seduto sul lettino, in calzini e con un camice ricucito buono per una periferia della sanità e dello spirito. Mi va largo, da quando ho sperimentato io stesso l’ischemia. E’ ciò che unicamente avrebbe finito per legarci, se non l’avessero ricoverato proprio qui. Non altro, non ricordi cui siamo diventati estranei né alcuna misericordia di ritorno. Se il Poeta non giacesse sedato nell’ultima camera laggiù, non mi preoccuperei del mio cuore.
In seguito ho riflettuto che la sua Poesia poteva aver bisogno dell’antipoesia come Cristo di Giuda, se no non è tale. Gli anni avevano una durata ingenua, fatta di eternità ripetute: da un capo all’altro della spiaggia, dall’inizio alla fine di un trimestre, senza mai un troncamento, una cesura avvertita come tale. Giocare a carte per lui non era degno, a calcio sì, presumevo valori e disvalori segreti, noti solo al Poeta. Mi incolpavo di scorgere nel gioco solo il gioco. Lui emanava verdetti repentini. Sciocchi i motori, vana la lotta sociale, al fondo di ogni esistenza Celine più che la vera esistenza. Io non ci arrivavo. Forse perché non studiavo le religioni orientali, forse non amavo abbastanza Celine… E tuttavia in quei pomeriggi sorridevo, di più se era maltempo e il tonfo della pioggia ci dotava di un riparo e caffè, e tranquillamente veniva la burrasca notturna.
Perché nel nostro mondo piccolo, di numeri e spazi contenuti, sentivo principalmente protezione, dall’uno all’altro di noi. Contavo sull’affetto di mia madre, forse, non so lui. Agli analisti sancire se è una colpa anche questa. Se lo è, in me corrispondeva all’innocenza. Che persi per azione deliberata del Poeta.
E’ stato il momento della realtà, della crescita, direbbe uno scrittore. E’ stata la chiazza di sangue su un cespuglio quando alle feste si attraversava la campagna. Un annegato risospinto a riva dal mare, nella calca dei bagnanti. E’ stato il male, intravisto ma ancora sconosciuto. Un’estate intera di nuotate, i dopopranzo assorbiti dall’afa e dalla musica, alla sera sigarette fino a tardi. Insieme. In cinque, ricordo il numero nel mio ragionieristico approccio, mi scuserà. Eravamo in cinque. Il Poeta in realtà non mi scusava, criticava subdolamente i miei dischi, la mia allergia alla pittura. Capivo di essere l’ultimo in classifica e tuttavia mi industriavo a permanervi, sentivo nei nostri stivaletti una forza che sopravanzava i miei demeriti, nel nostro slang da beatnik di provincia. Ero il solo a portare occhiali scuri. Mentre le lenti spesse del Poeta attestavano un nevrotico tormento, analogo a Ginsberg almeno quanto io differivo da Kerouac, e nonostante le camicie a quadri. Oggi ancora mi pervade lo sgomento ricordando di quando rientravo a sera un po’ brillo, allegro di un’ebetudine mia sola, in virtù unicamente della quale riflettevo che in fondo, tutto sommato eravamo noi pure un bel gruppetto di amici. Ho appreso presto che l’allegria degli altri era di natura maligna, se c’era aveva me come pretesto, la mia rimarcata grullaggine. Rincasando, un giorno non diverso dagli altri, udii parlare di coincidenze e di treni, di permanenze in stazione che si annunciavano lunghe. Senza il coraggio delle domande dirette, appresi che era in programma un viaggio, che si partiva per Londra presumibilmente martedì. Che si partiva in quattro.
Ognuno ha solcato il momento in cui l’innocenza si smarrisce, l’istante interminabile che cambia tutto per sempre, che cambia soprattutto il passato. Si scopre un bozzo, una malformazione interiore, ed è un mistero dove se ne sia stata e come abbiamo potuto non sentirla. Non so dire quanti anni avevamo. So dire il colore della maglia di qualcuno, la rivista che stava sfogliando qualche altro. Non cambiò niente, seguitammo a sfilare lungo la via deserta con le mani nelle tasche dei calzoni, il Poeta se non sbaglio era davanti. Nessuno mutò di andatura o smise di fischiettare. Le stelle persistevano in una crittografia indecifrabile. Ci salutammo dopo un po’, come ogni volta.
Poi mi sono detto che combatteva così la solitudine: a spese dei più sciocchi, dei più attaccabili del gruppo. E che se non fosse stato lui allora, sarebbe stato presto o tardi un altro. Ma fu lui. Fu lui a suscitare per me il male, un male che neanche supponevo esistesse tanto era strisciante, occulto, tanto era immotivato. Per questo, quando ho scorto il Suo titolo (“Il male nobile della poesia”) avrei voluto che mi spiegasse cosa dobbiamo intendere per male, e come la sua nobiltà si manifesta. Nel Suo trafiletto, oltre al titolo, Lei adopera quattro volte la parola poesia, cinque la parola poeta. Sono io, peraltro, ad usare costantemente la maiuscola.
Ma sono storie di ragazzi. La vita, si sa, va avanti e travolge questi drammi da nulla. Il viaggio si tenne ed ebbe fine, tutto riprese uguale, ognuno aveva bisogno degli altri perché infine tutti eravamo poco più che ragazzini. Mi iscrissi a medicina, Le giuro, per il vago desiderio di riuscire utile agli altri; se preferisce: per il bisogno che gli altri avessero bisogno di me. Il Poeta seguì la sua via. Aiutato a sopravvivere perché aveva scarsi mezzi, perché era malaticcio e l’astrazione doverosa dell’arte ne escludeva qualsiasi senso pratico. Altri se ne facevano carico: parenti, conoscenti (non oso scrivere: amici)… Piccoli sostegni accettabili, affari di cucina, lavanderia, pratiche burocratiche. Era giusto così, lo penso ancora. Era giusto addirittura che non lavorasse, se fosse stato possibile. Che altri lavorassero per lui, che tutti lavorino per chi non può lavorare. Io la penso così, Poesia o meno. Ma non era giusto il suo disprezzo. Che non era verso il lavoro, non verso la lavanderia e la cucina, bensì verso chi lavorava, verso chi aveva famiglia e andava ogni giorno in ufficio. Verso chi accudiva una casa. All’artista si addice un certo infantilismo, al genio una dose di sprezzante crudeltà. Ma per ciascun connotato di cui era privo, il Poeta covava un sotterraneo rancore: per chi era innamorato, era sano, o soltanto viveva una normale routine.
Lui, naturalmente, si professava innamorato di un’idea. La figlia prepubere di un vicino di casa, la mendicante di una foto del National Geographic… In seguito ho saputo di qualche fidanzata. Non mi sono fatto domande, né me ne faccio. Però non riesco a stupirmi che nessuna sia ancora venuta a fargli visita.
Lei ha certamente ragione: “il lavoro di un poeta non è dare musica alla vita, ingentilirla, passeggiare nei boschi a primavera, descrivere l’odore dell’aria, parlare d’amore”. Fatto sta che lui d’amore parlava. Di un suo amore folle e visionario, poetico perché impossibile o impossibile perché poetico? Comunque disperatamente unico e diverso. Diverso dai nostri amorazzi, dalle cotte che ci hanno ridotto in pantofole davanti a una tv sempre accesa… Qualcuno doveva farcela pagare, in anticipo.
L’ultimo maltrattamento che mi riservò fu come sempre indiretto. Fui tra i primi a impiegarmi. In un ambulatorio scalcagnato. A cena prese a inveire contro l’oscenità dei pullman di pendolari, contro il pranzo tenuto al caldo nel thermos: meritava la vita chi viveva così?, esagerava con ilare sarcasmo. La birra induceva all’accordo, il vino a ridere di un’umanità degradata. Per una volta, non so perché, mi ribellai. Commosso dal suo ultimo sonetto, bellissimo e struggente, ho avuto pena di me: gli ho rispedito il suo odio, ho accettato di restare da solo, finalmente. Contavo sull’affetto di mia moglie, forse, neanche rammento se ero sposato o no. Con lui sono rimasti commensali irretiti dal calduccio del camino, dai tardivi spinelli e dall’ora. Me ne andai senza nemmeno salutare.
Ero già medico, la mia specialità era il cuore. Palpitazioni il Poeta ne lamentava da sempre, le attribuivamo (le attribuiva?) all’angoscia del mondo, alla Poesia. Speravo invece in un accidente dei ventricoli? Non credo. Tuttavia, anteponendo l’ordine alla vendetta, mi pareva quella la sola condizione per ricondurlo al riguardo, alla pietà per le banali altrui cose: che ne avesse l’urgenza, un’urgenza più disperata dei suoi versi. No, mai gli ho augurato la percussione di un frastuono al torace, ma da qualche parte covavo questa immagine, il Poeta ridotto all’umiltà di un battito impazzito, in balia del casuale cardiologo di turno.
In un’ora qualsiasi del passato ci eravamo incontrati. Era mattina, facevo la mia stupida passeggiata salutista, in parallelo alle onde. Lui seguiva probabilmente il filo di una rima. Qualche collina lontana attestava di una sincerità praticabile. La linea degli agrumeti o delle nuvole, o le colline stesse scrivevano forse una storia. Ci eravamo parlati in confidenza. Mi aveva detto di un sogno nel quale io scrivevo un racconto, addirittura me ne annunciava il titolo, al momento lo presi come augurio, senza coglierne la mortificante costrizione. Mi illudevo di stare nel sogno di Bob Dylan, “I dreamed a dream that made me sad, concerning myself and the first few friends I had”. Mi illudevo di amici che non erano tali. Prima o poi ogni cosa si spezza, secondo quello che chiamiamo verità.
Si spezzò tutto. Non ci siamo visti mai più, sebbene ci incrociassimo ogni giorno. Il mio tempo è trascorso, vuoto come ciascuna speranza. Del tempo del Poeta apprendo, grazie a Lei, che lo impiegò a “cambiare discorso”, a “scavalcare i limiti della comprensione e della logica”. E’ certamente così: il suo compito era “non incrementare la bellezza dell’ovvio, ma trovarla dove non c’è. Dove nessuno la cercherebbe. Avere il senso acuto della morte. Essere cavia di se stesso”. Compito nobile. Che fece cavie di noi, della nostra giovinezza da poco.
Quando il cuore mi si è contratto di colpo, in parte morendomi dentro, non pensavo affatto al Poeta. Non ci pensavo da anni (anni ed istanti si affastellano nel ritmo scompensato del narrare, mi perdoni). Sono rimasto in terapia intensiva riflettendo, al pari di ogni ammalato, quanto è intempestiva la morte. La morte di chiunque. Quella sensazione mi è ritornata in mente col Suo scritto. Nel quale invoca giustizia per il Poeta, cui la Poesia “non ha mai procurato alcun utile, alcun avanzamento di carriera, alcuna notorietà, alcun incarico, alcun premio in denaro o in altro tipo di merce”. Quasi a sancire una fretta, a dire: “fate presto”. Signor Scrittore: ma è tutto ciò che il Poeta nobilmente, coerentemente, poeticamente disprezzava! Proprio di questo accusava la restante umanità. E’ giusto, piuttosto, che io non scordi il male con cui mi ha investito. E non lo faccio. Che i nostri bassi cieli di ragazzi rimangano striati di disillusione e di bianco, resti così per tutti. Ogni cosa.
Da un attimo all’altro fischierà la spia rossa, i trattini verdi guizzeranno nel sobbalzo di un richiamo, lancinante. Ancora non riesco a credere che soltanto il Poeta sia in pericolo di vita. La vita stessa è in pericolo, comunque vada a finire. Mi vado assuefacendo a una respirazione convulsa, curiosamente analoga a quella che proviene da laggiù. Impropria in un cardiologo di turno. Da dove giunge il frastuono che mi copre la voce, dal torace di chi?
Ciascuna menzogna si spezza in ciò che consideriamo verità. Sotto le barche nascondevamo i panni rimanendo in costume, una maglietta mi fu rubata senza rischio. Una maglietta celeste, con le righe. Ne fui ferito tanto da fare finta di niente, o avrei indotto l’ironia del Poeta. Cos’altro poteva spezzarmi? Merita di essere detta una verità tanto insulsa? Non ho studiato medicina. Sono impiegato di banca. Non ho mai scritto un rigo.
Meno che mai potrei adesso, con questi tubi alle braccia, con questi fili che mi collegano ai monitor. Con questo pianto che mi sta dentro da allora e non riesce a scoppiare. Sotto il gelo di luci che percuotono i muri della stanza, la penultima alla fine del reparto. Il mio racconto me lo sono scritto in testa. Parola per parola, in silenzio, nella ripetizione interiore di segni cui non corrisponde alcun senso se non quello “acuto della morte”. Che è unico per ognuno, e dal quale non pretendo affinità inesigibili. Uno solo è il Poeta, io di unico conservo la linea degli scogli, l’aria che respirammo e i versi della canzone in quell’ora. Tornava da uno dei loro viaggi, in India questa volta. Si era messo per collana un rosario comprato lì, fatto di grani di giada. Quali animali avessero visto sbarcando dall’aereo si poteva immaginare. Il suo comando fu che scrivessi una storia. Si sarebbe chiamata Le scimmie all’aeroporto. Poi si era accoccolato sulla rena, come posandomi una mano sulla nuca, nell’imperturbabilità delle colline. Immobili, le nuvole mi sembrò che leggessero.
Consapevolmente lo assecondo, in questa propaggine di esistenza in cui è viva solamente la vita. In cui la differenza tra noi è il numero della camera e la probabile ora del decesso, così come, in fin dei conti, è stato sempre. Ora che siamo vicini come non mai ad essere amici. E che il solo ricordo che non sfuma è quello di una luce inquieta, di una voce, di un tragitto in parallelo alle onde.
[ E’ veramente una lettera più che un racconto, quella che precede. I suoi fatti sono in massima parte reali. Lo scrittore cui non l’ho mai spedita è Diego De Silva. Il giornale dell’articolo è Il Mattino. Del poeta, il cui nome non pronuncio da anni, ho il diritto di non dire altro. P.S. ]
I commenti a questo post sono chiusi

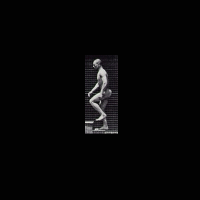

Quest’autore, come anche in prove precedenti, bisogna leggerlo sentendo il ritmo delle frasi, oltre che la storia. Qui è una musica nostalgica, che attraversa gli eventi e colpisce con la forza della poesia. Che poi siano eventi reali la rende ancora più intensa.
Reader’s digest
Una vicenda toccante, anche se non si capisce che cosa è realtà e che cosa fantasia. A me il libro Certi bambini di DeSilva è piaciuto molto, questa lettera non credo che abbia lui come bersaglio. Quanto invece l’autore stesso, la sua sensibilità ferita e quella un pò di tutti
Il non capire cosa è realtà o fantasia è la cosa più bella e spiazzante di questa lettera racconto scritta con una sicurezza di mezzi e un controllo davvero notevoli. Le domande che lascia in sospeso sono l’incertezza di tutti rispetto alla doppiezza dei fatti e dei casi delle vite.
With haunted hearts through the heat and cold
We never thought we could ever get very old
We thought we could sit forever in fun
Our chances really was a million to one.
How many a year has passed and gone
Many a gamble has been lost and won
And many a road taken by many a first friend
And many I’ve never seen again.
I wish, I wish, I wish in vain
That we could sit simply in that room again
Ten thousand dollars at the drop of a hat
I’d give it all gladly if our lives could be like that.
I’m deeply moved from this story, then … io c’ero.
Un pezzo come pochi, Paolo, mi trovo in sintonia col commento di Gentili e ho sempre più l’impressione leggendoti di aver incontrato uno scrittore autentico.
Grazie sinceramente a chi è voluto intervenire. Grazie dell’attenzione: a chi l’ha manifestata e a chi non lo ha fatto. Particolarmente grazie a Domenico, con il quale, evidentemente, non solo parliamo la stessa lingua ma cantiamo anche le stesse canzoni. E naturalmente grazie a Orsola. Di tutto.
P.S.
pare si scriva “aeroporto”.
Si aspetta.
Si aspetta ancora.
Che arrivi qualche parola degna
di figurare come commento
a un pezzo come questo.
Perché ne capitano pochi,
così.
*
Il dire la verità significa
che mente e discorso devono
corrispondere all’oggetto;
mente e discorso debbono
essere così come è ciò che
è stato visto o udito.
PATANJALI, Gli aforismi sullo yoga.
*
Poi capita invece che ci si accorga
che la disparità è troppo grande.
Non possediamo parole degne di questo.
Possiamo solo ringraziare.
Paolo e Orsola.
volevo solo testimoniare l’effetto della lettura di questo racconto/non racconto. ho dovuto fare più di qualche respiro profondo per tornare abile.
qusto per dire solo grazie.
ora dateci i titoli dei libri di questo autore. tutti.
qualche lungo respiro dopo questa lettura, e poi un grazie.
ora dateci i titoli di questo scrittore. tutti
un saluto
Cavolo, me lo stavo perdendo! Il problema è che non vengo a cercarti con costanza. Leggere online non mi attira molto.
Ho difficoltà a commentarlo, anzi dovrei dire a commentarla, trattandosi di una lettera. Ho difficoltà perché tendo a decriptare il suo ermetismo attraverso alcuni fatti che conosco.
Ho l’impressione che per alcuni di noi giunge un tempo in cui la nostra “umanità” non riesce più a contenersi. Per questo trovo la tua lettera stupenda. Chissà se il Poeta l’ha mai letta!
A meno che io non sia completamente fuori bersaglio ed abbia letto come un messaggio in codice dall’anima un semplice artificio letterario ben fatto.