VivaVoce#03: Sylvia Plath [1932–1963]
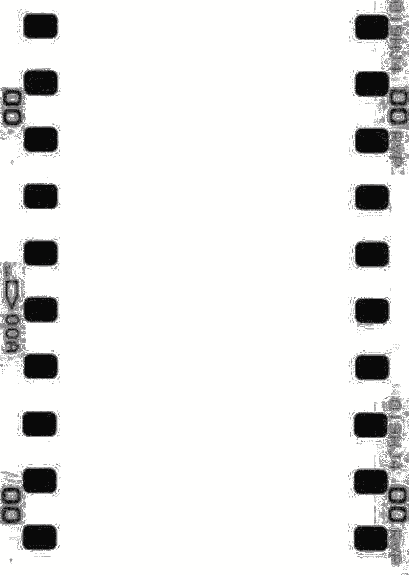
Daddy
[ dalla viva voce di Sylvia Plath – che sorride ironia amara – con una cattiveria forzata e finale – quasi neutra – a tratti spezzandosi – in una registrazione per un programma della BBC del 30 ottobre 1962 – viva ancora per poco – il cuore nero di questa filastrocca di morte (di questa nursery rhyme che danza sull’orlo di un precipizio le sue rime in u come presagi di gufi) avrà il sopravvento pochi mesi dopo – l’11 febbraio 1963 – due tazze di latte e qualche fetta di pane di fianco ai lettini dei bambini – la finestra socchiusa – la porta sigillata con il nastro adesivo – la testa nel forno della cucina – niente più lotta d’acrobata contro il dolore – quel dolore dei bambini che si credono sempre colpevoli loro per le disgrazie degli adulti – in quel suo you ripetuto per 23 volte si declinano e trasfigurano in figure mostruose il padre e la sua lingua nemica – figlio di immigrati tedeschi – amputato non in guerra ma per il diabete – morto troppo presto – per embolia – professore di entomologia – mai stato nazista – e il marito Ted Huges che anche l’ha abbandonata troppo presto – loro due e tutto il dolore storico del secolo del nazismo e dello sterminio – gridano insieme – scorrono nella stessa pellicola che va fuori quadro – giù di nuovo nello stesso sacco del delirio di morte di Ivan Il ‘ic di Tolstoj: Gli sembrava che volessero ficcarlo a forza in un sacco nero, stretto e profondo e che cercassero di spingerlo sempre più giù senza riuscirvi. ]
You do not do, you do not do
Any more, black shoe
In which I have lived like a foot
For thirty years, poor and white,
Barely daring to breathe or Achoo.
Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time–
Marble-heavy, a bag full of God,
Ghastly statue with one gray toe
Big as a Frisco seal
And a head in the freakish Atlantic
Where it pours bean green over blue
In the waters off beautiful Nauset.
I used to pray to recover you.
Ach, du.
In the German tongue, in the Polish town
Scraped flat by the roller
Of wars, wars, wars.
But the name of the town is common.
My Polack friend
Says there are a dozen or two.
So I never could tell where you
Put your foot, your root,
I never could talk to you.
The tongue stuck in my jaw.
It stuck in a barb wire snare.
Ich, ich, ich, ich,
I could hardly speak.
I thought every German was you.
And the language obscene
An engine, an engine
Chuffing me off like a Jew.
A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.
I began to talk like a Jew.
I think I may well be a Jew.
The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna
Are not very pure or true.
With my gipsy ancestress and my weird luck
And my Taroc pack and my Taroc pack
I may be a bit of a Jew.
I have always been scared of you,
With your Luftwaffe, your gobbledygoo.
And your neat mustache
And your Aryan eye, bright blue.
Panzer-man, panzer-man, O You–
Not God but a swastika
So black no sky could squeak through.
Every woman adores a Fascist,
The boot in the face, the brute
Brute heart of a brute like you.
You stand at the blackboard, daddy,
In the picture I have of you,
A cleft in your chin instead of your foot
But no less a devil for that, no not
Any less the black man who
Bit my pretty red heart in two.
I was ten when they buried you.
At twenty I tried to die
And get back, back, back to you.
I thought even the bones would do.
But they pulled me out of the sack,
And they stuck me together with glue.
And then I knew what to do.
I made a model of you,
A man in black with a Meinkampf look
And a love of the rack and the screw.
And I said I do, I do.
So daddy, I’m finally through.
The black telephone’s off at the root,
The voices just can’t worm through.
If I’ve killed one man, I’ve killed two–
The vampire who said he was you
And drank my blood for a year,
Seven years, if you want to know.
Daddy, you can lie back now.
There’s a stake in your fat black heart
And the villagers never liked you.
They are dancing and stamping on you.
They always knew it was you.
Daddy, daddy, you bastard, I’m through.
[da Ariel,1966]
Papy
Non mi stai più, non mi stai tu
Scarpa nera, proprio più
Dove come un piede ho vissuto
Per trent’anni, povero e bianco,
Osando a malapena un respiro o un Etciù.
Papy, avrei dovuto farti fuori.
Sei crepato prima che ne avessi il tempo–
Peso di marmo, una sporta zeppa di Dio,
Orribile statua con quel solo alluce grigio
Grosso come una foca di Frisco.
Quella testa nell’Atlantico mostruoso
Dove versa verde vivo nel blu
Nelle acque al largo della bellissima Nauset.
Sempre a pregare di ritrovare quel che eri tu.
Ach, du.
In lingua tedesca, in quel paese polacco
Grattato via a tappeto dal rullo
Di guerre, guerre e guerre.
Ma il nome di quel paese è comune.
Il mio amico polacco
Dice che c’è n’è una dozzina o due.
Così mai potuto sapere dove tu
la radice, il tuo piede ficcasti giù,
Mai potuto parlarti di più.
La lingua attaccata al palato.
S’impiglia in una trappola di filo spinato.
Ich, ich, ich, ich
Potrei a stento dire.
Pensavo ogni tedesco fossi tu.
E la sua lingua oscena
Una locomotiva, una locomotiva
Ciuff ciuff mi deporta come un ebrea.
Un’ebrea a Dachau, Auschwit, Belsen.
Cominciavo a parlare da ebrea.
Penso che potrei esserlo proprio ebrea.
Le nevi del Tirolo, la birra chiara di Vienna
non sono così pure o vere.
Con la mia ava gitana e la mia stramba sorte
E i miei tarocchi, il mio mazzo di tarocchi
Potrei esserlo ebrea un poco.
Mi hai sempre terrorizzato tu,
Con la tua Luftwaffe, il tuo gramlò.
E quei tuoi baffi curati
E quei tuoi occhi ariani, così blu.
Uomo panzer, uomo panzer, o Tu–
Al posto di Dio una svastica
Nera che neanche il cielo riesce a farla fuori.
Ogni donna adora il fascista,
Lo stivale in faccia, il brutale
Brutale cuore di un bruto come sei tu.
Stai in piedi alla lavagna, papy,
Nella foto che ho in cui ci sei tu,
Un taglio nel mento invece che nel piede giù
Ma non sei meno un diavolo, no no
Non sei meno l’uomo nero che
A morsi spezzò il mio rosso cuoricino in due.
Ne avevo dieci quando ti seppellirono
A venti cercai di morire
E tornare, tornare, tornare dove sei tu.
Pensavo mi bastassero anche le ossa.
Ma mi tirarono fuori dal sacco,
E mi rimisero insieme con la colla.
Capii che altro non potevo fare più
Mi costruii un modello come eri tu,
Un uomo in nero con l’aria da Meinkampf
E un amante del bastone e del torchio.
E lo dissi sì lo voglio, lo voglio
Così papy, alla fine ho messo giù.
Il telefono nero sradicato via,
Le voci non ci strisciano dentro più.
Se ho ucciso un uomo, ne ho uccisi due–
Il vampiro che diceva che eri tu
E succhiò il mio sangue per un anno,
Per sette anni, se proprio lo vuoi sapere.
Papy, tornatene pure a nanna.
Hai un paletto in quel tuo nero cuore di lardo
E i paesani non hanno mai amato quel che eri tu.
Stanno ballando e pestando sopra quel che eri tu.
L’hanno sempre saputo chi eri tu
Papy, papy bastardo tu, non ce la faccio più.
[traduzione di orsola puecher]
VivaVoce#01: Thomas Stearns Eliot [1888–1965]
VivaVoce#02: Gherasim Luca [1913–1994]
VivaVoce#03: Sylvia Plath [1932–1963]
,\\’
I commenti a questo post sono chiusi


Questa poesia mi ha sempre colpito per questi versi
”
Ogni donna adora il fascista,
Lo stivale in faccia, il brutale
Brutale cuore di un bruto come sei tu.”
Perchè sono lontani da me, ma nello stesso tempo mi han sempre suscitato domande su un certo tipo di donna.
Grazie per questo post Orsola.
Terrificante.
qui:
Every woman adores a Fascist,
The boot in the face, the brute
Brute heart of a brute like you
salta la puntina del disco! :-(
E’ terribile come pietre scagliate contro il cuore. Le parole squarciano il tessuto della lingua paterna, un odio di se, una paura di raggiungere un paese ” in nommable”.
E’ la morte che accoglie le parole, la morte per soffocamente che intralcia tutta parola. Penso a tutto il coraggio che deve avere per mettere la testa nel forno, a questa voglia di morire.
Penso alla morte di Virginia Woolf che vedeva la guerra accadere, la sua morte in acqua e le tasche piene di sassi, vedo una traiettoria parallela.
PS Condivido Nadia.
“There’s a stake in your fat black heart”: un verso che una ha scritto, ma che molti hanno martellato e martellano, nel loro (Nobo)daddy.
Un caro saluto,
Roberto
“Every woman adores a Fascist” questo è il verso, chissà se casuale, che viene saltato nella registrazione. Il tutto colpisce dritto allo stomaco.
immensa.
immenso il suo dolore
Una volta, a 16 anni, mi ero rotto l’avambraccio e, oltre a ingessarlo, mi ci hanno infilato due lunghi ferri per tenere a posto le ossa, uno per il radio e l’altro per l’ulna. Tolto il gesso, c’erano due uncini che uscivano da sottopelle, uno in alto sul polso e uno in basso vicino al gomito. Il medico li ha afferrati e tirati, estraendo i due ferri. E’ stato un attimo, ma ricordo ancora la sensazione agghiacciante del ferro che mi strofinava sull’osso.
La poesia della Plath in generale, e questa in particolare, mi dà la stessa sensazione.
A questo indirizzo http://www.bbc.co.uk/arts/poetry/outloud/plath.shtml si può ascoltare Sylvia Plath che dice Lady Lazarus, altrettanto straziante. Sylvia Plath era innamorata della vita: come succede per tutti gli amori, la vita non la ha ricambiata.
Grazie a tutti.
Eh sì la puntina salta dove il dente duole, dove il ferro stride sull’osso.
Il fascista annidato e nascosto nell’animo umano è sempre in agguato.
lo stivale in faccia sempre pronto a scattare.
Nemmeno l’intelligenza e la cultura a volte salvano da questo.
L’incapacità di ribellarsi, una inconscia componete di masochismo degli affetti, anche, è sempre lì, strisciante.
Presentando questa poesia alla radio Sylvia dice:
Ecco una poesia in cui parla una ragazza con un complesso di Elettra, il cui padre muore quando ancora lei lo crede Dio. Il suo caso è reso ancora più complesso dal fatto che il padre era anche un nazista e la madre probabilmente in parte ebrea: nella figlia le due eredità si sposano e si paralizzano a vicenda e lei deve inscenare(act out) un’altra volta la piccola tremenda allegoria per potersene liberare.
Ma anche la scrittura a volte non libera, non cura, non ha catarsi.
Non basta.
,\\’
Questo è uno di quei testi che spiazzano. O almeno che hanno sempre spiazzato me. La forza delle immagini, come in tutta la Plath, è formidabile, il contenuto è morboso (anche qui – come in moltissima Plath – diario compreso -), urtante e alla fine fastidioso nel suo mescolare le carte di un dramma personale e della nevrosi con la storia.
Del resto la letteratura, la parola poetica quando è autentica (e questo è il caso) ha un enorme potere distorcente: forgia la sua verità come se fosse universale. Bisogna guardarsi dai poeti. “Ogni donna adora un fascista”, vero, moltissime volte, purtroppo, ma il fascismo della Plath, non era nel padre né nel marito – i suoi due burattini, i due mezzi per scrivere poesia, l’unica cosa che lei abbia davvero amato. Era piuttosto il fulcro stesso della malattia e della vita della poetessa, questa continua competizione con il mondo, questo ego spropositato da cui non è mai uscita e che infine ha rivoltato contro se stessa. Non penso come dice Niki lismo, che la Plath amasse la vita e la vita non l’abbia amata. La Plath amava solo la sua scrittura. Non ha avuto tempo per la vita, se la vita è quella cosa che succede quando si trova la forza di superare e dimenticare sé stessi. Per Sylvia ho avuto una passione spropositata d’amore e rabbia – lo stesso poeta come nume tutelare (Yeats), tra l’altro -. Però mi ritrovo molto in quello che ha scritto Heaney su di lei, esaltandone la poesia e tuttavia vedendola nei contenuti troppo preda di se stessa. Orsola parlava di catarsi (mancata per l’esperienza vitale di S.P.): la Plath nella lingua/vita poetica è un fuoco da cui si passa, ma da cui poi ci si libera. Lei non si è data il tempo di farlo. Non c’è nella sua opera nemmeno un verso, mai, di accettazione/comprensione dell’altro. Questa è la sua devastante grandezza ed il suo limite.
Tutti i veri depressi condensano il mondo intero al proprio interno, quasi mai riuscendo a fuoriuscirne. Più terribile è quando hanno la sensibilità per accorgersene. Francesca Matteoni individua una componente para-patologica nella poesia di Sylvia Plath, e in buona misura è nel giusto. Che amasse la vita (e la sua condensava tutte le altre) senza esserne ricambiata, è sintesi un po’ estrema, e della quale mi scuso, ma con la Matteoni sostanzialmente in accordo.
@niky lismo: ma perché scusarsi? il tuo commento va a toccare proprio quella confusione che sussite tra scrittura e vita: per molti che scrivono le due cose spesso pericolosamente coincidono.
Il confronto-conforto che spesso i padri ispirano ai figli sono specchio del disadattamento a vivere che questi ultimi patiscono dopo e a causa di rapporti familiari laceranti e totalizzanti. In più lo stridore assordante tra l’angoscia che si stabilisce dentro di noi e la necessità di condurci fuori dal vicolo cieco per imporci una vita normale molesta continuamente la nostra sensibilità. E nei poeti lo stridore diventa lancinante e fa perdere le coordinate della resistenza, fa universalizzare il dolore e la rabbia, pone lo scrittore come protagonista sul patibolo ad ammonire gli scettici. Vittima e banditore, accusa ed estrema difesa. Ma il ciglio della morte spesso ci sdrucciola sotto senza preavviso e senza rimedio.
una delle cose che mi ha più straziato della Plath è Certe volte guardo il cielo ma il cielo mi sembra vuoto.
ho sempre ritenuto che fosse una sintesi della continua messa in scena e, nella messa in scena, del continuo tentativo di approssimazione alla realtà. come se nella finzione potesse fingersi pure la fatica. e quindi sopravvivere.
io penso che la letteratura l’abbia salvata quanto possono le parole.
che se non recidono vene nemmeno sono cerotti o bende.
io penso che amasse la vita ma che gli amori, ricambiati o meno, non durano per sempre. pace.
mi piacerebbe credere che in Plath sussistesse una parziale sovrapposizione tra scrittura e vita. sarebbe facile pensare di gettarsi oltre il margine del foglio senza allungarsi a prenderne un altro. un gesto di inevitabile stanchezza. ho sempre piuttosto pensato alla fortissima crasi, alla distanza tra scrittura e vita. a quanto, nonostante le continue messe in scena (act out – come lascia bene orsola) la vita le rimanesse inesplicabile, a-reticolare, a-metrica, oltre la descrizione poetica.
da questo punto di vista penso che le vicende umane di Woolf e Plath siano differenti. in Woolf sussiste una totale e fascinosa sovrapposizione tra diari e narrazioni e quindi tra vita e scrittura. o viceversa. in Woolf non si capisce mai bene cosa venga prima. in Plath la poesia tenta, o così mi è sempre sembrato, di razionalizzare, inscenare la vita.
è pur vero che conosco meno Plath.
I am inhabited by a cry.
come al solito bellissimo il montaggio di immagini e parole. e questo. :)
chi
Sylvia come specchio chiaro e scuro delle nostre poetiche soggettive, di scrittura e di vita, e(d) anche ognuno di noi come specchio chiaro e scuro dell’altro/a.
Quando scrivere qui e commentare ha un senso ed un valore.
Grazie davvero a tutti/e.
,\\’