Pelle di confine
di Franz Krauspenhaar
Dal di fuori la sembianza è quella italiana, di quella terra solcata dai mari, di quella terra solcata a strati d’altre terre. Terra di Siena la faccia, quando al brillare durevole del sole il bronzo si alliscia sulla pelle, e prima s’arrossa. Nel grigiore a metropoli, Milano da bere e vomitare, aperitivi sbagliati, come negroni a qualità registrata, la mia faccia è su quella tinta-non tinta, colore non colore, come pennacchi di fumo, come nebbia d’argento. Il colore dei capelli è la neve dura d’inverno della mia città, in medio, la Mediolanum, in medio tra il nord e il sud dell’Europa. Gli occhi sono azzurri, ma potrebbero tagliarsi da angioini, da normanni lontanissimi per parte meridionale di madre. Fuori il mio corpo è Italia, il mio corpo è d’unghie di combattimento medievale, di Guelfi e Ghibellini schermati tra le lance, e le stoppie d’un sangue dei comuni sgorgato bollente come l’olio, giù, dalle torri di guardia.
Fuori il mio corpo è Italia, strati e strati di pelle a geografia di secoli, di dominazioni barbare una sull’altra, come ere di popoli. Il sangue si frammischia e poi impoltiglia sgomitando nelle vene, popoli che si sono picchiati col bastone della fame e della sete urlano flebili matasse di suono. Fuori il rosso di questo sangue si rapprende, e si scurisce in un minimo mare color morto. I peli del petto sono il bosco e i rami d’intoppo, greggi di pecore, mandrie di bufali calpestano, deviano. Là dentro solo piccoli animali s’imboscano, lucertole, arazzi di gatti spellati, lontre a metà immersione nella cavità orale, scoiattoli scodati in buche di pori aperti dalla doccia.
Pelle morta d’Italia squama a piovere, cartografia del corpo millimetrata sul letto, globo che mi gira attorno, sentendomi io un punto solo di terra nell’immenso respiro sovrano.
Dal di fuori la sembianza è quella italiana, il naso importante, per serate di gala, la mano piccola che noiosamente scarta la sigaretta dal pacchetto, l’altezza non retribuita, non alta, tutta una medietà che nel nord più non si trova, e che qui sta sul crinale tra alto e basso, a seconda dei parametri personali, del proprio sentire corpo e corpi. La camminata lenta peristaltica, a pendolo montanaro. E già qualcosa dei camminatori del nord lo puoi trovare, all’osservazione attenta, interessata. O cowboy delle montagne del nord, come di chi ha sbattuto le reni su cavalli e piedi a solco su chilometri d’ettari, tra foglie e frasche nude e nevi spaventate, in inverni infiniti di cieli solo bianchi o neri, a seconda del giro della giornata. Colori primari in coccio duro, agli occhi sgrumati dalla luce intensa.
Tra questi inserti continui di Pianura Padana io trovo confine dal fuori e il dentro di me, come se mi dovessi spezzare in continenti d’estremo. Ma non è così. Mi conduco all’indentro, compio questo viaggio tra il confine del dentro e il fuori. Ed è continuo e da sempre, questo superare la pelle, la frontiera. Alle ferite dei miei avi giungo di nuovo nelle vene-fiume, l’Elba mi porta fino al cuore sepolto del tempo, nei millequattrocento anni dopo la morte del Cristo. Quando gli avi degli avi, dalle terre avarissime d’Olanda ferite a morte dal Nordzee, percossero la terra sull’Elba della Bassa Sassonia, per allontanarsi, come in una disperata fuga senza fine. In barche piccole remarono lungo l’arteria verde, colore di lucertole zigrinate e cieche, nel fogliame sparuto della pianura sempre più orizzontale. Per mesi corsero a passo d’uomo, fino a incontrare terre remote di montagne, le Erzgebirge. Tra la Sassonia e la Boemia. Lì si stanziarono, dominati da fatica e freddo, da lucidi rintroni di speranza bluastra. Da gente di mare a gente di montagna, come liguri entrosterrati a cavare rumenta e a buttarla in mare, che diventasse solida piattaforma per il distacco dei viaggi. I piedi piatti e l’altezza bassa di gente pietrosa, intaccata dalle temperie, al movimento breve abituata. Nostalgia del ritorno per un poco, poi lavoro senza tregua qualsiasi. Capanne costruite spellandosi e ferendosi le mani a sanguinosi assalti, bunker di sopravvivenza che s’ergono piani, verso sole a centimetri, su riscosse di faticato tempo, costruiti sempre a ridosso d’una eventuale fuga, d’emergenza.
Dal di fuori la sembianza sembra tedesca d’un lontano tempo, soprattutto alla veduta degli occhi, che si restringono col sole anche lieve, per naturale riparo fotofobico. Nelle tante generazioni prima di me, le genti costruiscono e sfamano altre genti, sono uccelli migratori divenuti stanziali, sono scorpioni operai, che portano rane in salvo lungo il fiume dell’opera. Più avanti trovano il conforto di pietre più morbide, al costruire si impegnano sempre, ma la civiltà del commercio preme il metallo forte, inducendo alla moneta, ancora di salvezza del sussistere. Dentro di me radici crescono, attendendomi nello scoprirle, come in un viaggio al termine. Come scale, le riempio dei miei passi pigri da montanaro a fine lavoro, io di città nato e cresciuto. D’estate vado a bagnarmi nel mare della madre, nel sud caldo a invasione, profondo come una lingua-madre di fuoco aspro e secco e puntuto. Aspiro coi pori sudoripari quelle parlate brulle, le aspirazioni del concavo impastato delle bocche. Comprendo quasi tutto, gli emozionati gesti, le lacrime lunghe dei respiri. La scalinata del nonno che porta da casa a bottega, e viceversa, il sapore di mou e parmigiano, il caldo sapido della notte bruna. Intanto i tonni saltano sulla cresta delle onde spaccate in blu e bianco, e il pesce spada viene ucciso dalle urla spinate dei pescatori secchi come alici nere. Luce di terra, color belva rappresa da interiora spappolate nella trappola. Le effusioni sono normali, forse troppo per quella città mia, affossata nel medio, che mi attende per tutto il resto dell’anno. Là c’è un razzismo che striscia a graffi sul cuore, e se a ottobre ti fai scappare l’intonazione in errore sono sbuffi di presa in giro, nella scuola nerofumigante, fuori quartiere, appena.
All’inverno di nuovo senza sentirsi cosa, l’Italia che si scontra con le bombe dei treni, finché nella scuola nuova intono sul libercolo deutschesprachlehrefueritaliener il tedesco dei padri, senza capirne che flessioni del timbro, che pochi assopiti sali, allungati nel brodo di coltura. Mischio, dentro le ampolle del senso vagheggiato, il non capire scabro, e fuori le ossa plaudono, le terre si sommano, stratificazioni d’anni s’investono, in un tornado a erompere. Ecco il grande passato di guerra bombardata del padre, lui che racconta, in mutande e canottiera, scolpita sui muscoli a legno. Scoppi di ire nel 1944, Ucraina tesa come lancia confitta nello sterno europeo, ripiegamento, infine, passo di gambero, all’incalzo. Urla di bombe e recinti spaccati da uretre gonfie di soldati morenti. I racconti si susseguono in flusso solido, tra brodi e paste, la mamma che sbriga le faccende, cinguettando. Il padre ricorda, in un romanzo solo, fiume, parte vendicativo dagli anni giovani strappati al gioco, rende demerito al passato, sfoga le sue avventure di terror troppo acerbo. Troppi pochi anni, diciassette, te lo ripete sempre. Dalla pancia si apre un solco di bruna terra d’oriente, fumante come patate cotte a brace. Si spalma la pelle del tuo confine interno e segreto, dentro trovi cesoie, alberi abbattuti dai tiger, venti dell’est soffianti sulle case, a tetti modestissimi, pane di segale. Gli ivan abboccano nella neve severa, scuciono sigarette, lanciano le stesse al di là della linea.
Trincee di conchiglie antichissime, sassi roridi lanciati in stagni d’alluminio, sguscianti terremotate soglie, avanzanti sempre, al di sotto, in cunicoli di stoppa fossile. Cavalleria d’incontro, in battaglia mortai a seguire le spacconate ansanti di fuoco viola. Cadaveri a gittata per nuvole nere, basse. Fà questo il passato non vissuto, tarme di pallottole mai viste fischiano l’allertare sul dosso delle mani, sparute di carne, in ossa confacenti, allo strappo di morti scuoiati nel brillio di fanfare sconfitte.
Ho la pancia aperta come nell’eremo chirurgico, sulla montagna a picco in aquile serpeggianti, e intorno le torri di ardesia nera. Come un antico principe tedesco attendo le mani cuoiate del medico, il naso aquilino, l’occhio perverso, che affondi nella piaga, che liberi, che faccia uscire le travi uraniche dell’antichissimo dolore. Escono a sangue vivo parole, crepitanti, imparate a metà e mezzo, doppelgaenger, quella che ti spiana, su, in una pianura di senso, le scrivi, altre, con occhi pesti nella notte, avanzando, come un soldato monco, di ventura. Dai recessi cunicolari dei sogni saltano cavalieri dalle spade aggiranti, fanno saltare teste, sangue che spruzza come sperma rosso cupo le terre di conquista. Gli avi uccidono per non essere uccisi, e anche per brutale piacere. Germania pallida madre. Da qualche parte senti sparire la terra, poi a Francoforte, dove sei stato una volta, senti una specie di richiamo, allo stomaco percosso, verso la terra greve. Ricordi fitto queste sensazioni furenti e mute. Di nuovo esce dal confine della tua pelle aperta e fritta nella sugna andata a male un giro di biciclette, di bambini biondi, verso Stoccarda, guardàti dal treno. Escono 50 birre scure bevute a una festa, i tedeschi che crollano, uno dopo l’altro, tu no, ancora, a tenere fino in fondo la posizione. Non vomiti. Escono ragazze lisce, di pelle appena abbronzata, le tue dita sono canali, sono lisce mansarde aggrumate di fiori in sequenza, innaffiati al picco, al colloso attaccamento. Escono lingue rosa su rosanero, dure pulsioni a pantaloni stretti e montanti veloci, affondi accarezzati e liquorosi a pelle, gigli. Escono materiali da costruzione, autostrade, ferramenta, casupole, in ciminiere a grani di fumo traspiranti. Escono le malizie dell’inverno, le scatole nere dell’estate, escono ancora km e km di capelli biondi, zucchero e miele liquidissimo, marmellata di more, doenerkebab, stinco sincopato da torme di patate, leccate nel burro, pietraie, conficcati pugnali nel cuoio a listelli delle pareti, in stanze profumate di burro salato, la mattina. Escono fabbriche metallurgiche, sirene, tram aerei, cattedrali gotiche, allarmi d’acqua alta. Escono batteri cogenti e notiziari sotto piogge battenti, e chimici prodotti industriali in pulviscoli strinati, coagulati in raschi cancerosi della gola. Escono ricordi d’altri, libri letti, Karl May il Salgàri tedesco, massicciate rupestri, polveri d’amianto, scappamenti d’ingordigia. Escono poesie di Goethe lette al mare, Boell e i suoi romanzi di dolente Colonia letti a letto, un Wilhelm Meister regalato a una donna. Esce Fassbinder che filma una Martha pazza, esce Fritz Lang Metropolis, e il suo occhio finto che guarda cinico la prossima disfatta, universale. Esce la luna che fa da stella del mattino ai campi di fieno tagliato. Esce una hostess bruna della Air Bremen, serve champagne, mi sento come l’Homo faber di Fritsch. Esce lo sporco della mia città, i suoni acuti, stupidi degli imbecilli che vorresti uccidere, stridendo loro gli occhi al cavo dei polpastrelli, vermi duri. La loro sporca, inutile vita, da radere al suolo, secondo la tua giusta rabbia di secoli. Esce tutto e tutt’altro. Emorragia di visioni, continue, impellenti, e non basta. Non basta mai. Bisogna richiudere, adesso. Potremmo fare uscire cose dal passato per sempre, ma non si può. Bisogna dare un taglio al taglio. Ricucire la pancia del mio passato e trapassato, ridare sfogo al sorriso, socchiudere comunque con questi ieri, rialzarsi dalla branda, e cercare l’orizzonte. Verso un posto che sia di tutti, che sia anche mio. Finire di sentirsi apolide nell’anima. Trovare l’isola che c’è, da qualche parte, forse bucando il petto, con un trapano di sentimento nudo, alla ricerca dell’armonia prima. Forgiare da noi stessi un luogo nuovo, che cresca da quella terra che esce lentamente, da noi stessi. Sogni in realtà, terra nuova, luogo nuovo. Spianato il passato a ricerca di un destino. Illudersi di essere liberi senza un passato. Catapultarlo fuori dai nostri ricordi, e ricominciare. Dare un taglio al taglio. Allungare il collo non più teso, tenuto morbido, in avanscoperta. Tendere forte. Verso un posto che sia di tutti. Verso un posto che sia anche mio.
(Letto in una versione leggermente abbreviata il 14.05.2007 – Fiera di Torino/Letture Indiane)

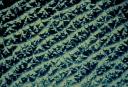

“Esce lo sporco della mia città, i suoni acuti, stupidi degli imbecilli che vorresti uccidere, stridendo loro gli occhi al cavo dei polpastrelli, vermi duri. La loro sporca, inutile vita, da radere al suolo, secondo la tua giusta rabbia di secoli. ”
Anche i colletti delle nostre camicie sono sempre più sporchi…dovremmo tutti centrifugarci ad almeno 85°.
Ciao!
Godibilissimo trattato di fauna europea.
mi piace molto l’accostamento geografico, mi piace molto il suo di questa scrittura che si annoda e si scioglie costantemente.
Decisamente brutto. Senz’anima.
Chi non ha vissuto a lungo a Milano non ha mai esteso il suo Io sul corpo senz’anima della città. Non ha mai eiaculato sul ventre di una morta a se stessa per non collassare. Non capisce un cazzo. Quanto mi manca la Gina che a 90 anni mi diceva: O te mangiet la minestra o te saltet dala finestra.
Ma quand’è che Iannozzi proverà a motivare una delle sue (tante) stroncature?
Detto questo, in generale, credo che si dovrebbe ridurre un po’ (anche più di un po’) l’estensione dei pezzi.
Saluti
Per Franz,
Lo trovo magnifico il tuo testo, scritto con un ritmo e una musica! Il corpo scavato, modellato dalla terra, lavorato dalla storia. Il corpo straziato, la voce materna, la lingua madre che scorre nella gola, il nome del padre straniero, un paese presente e un paese fantasma.
La sensibiltà, il dolore, l’anima, io li vedo;
Baci.
Franz Krauspenhaar, leggendo il tuo racconto, mi era venuta una gran voglia di chiamare la Gina. Erano due anni che non lo facevo. Quando ha sentito la mia voce ha subito sbuffato. Che afa. Con affetto. Gina ti ho telefonato perché… Ho appena letto di uno stato d’animo che solo tu puoi raddrizzare. El primm che s’è casciàa l’è mort, mi ha gridato. Deve essere diventata sorda.
Sono d’accordo con The O. C. quando dice che forse dovresti dare qualche sforbiciata…
Morgillo, se riuscissi a capire i tuoi commenti… A parte le sforbiciate da dare, non ho capito praticamente nulla.
E grazie a Veronique in particolare.
Iannozzi è diventato garanzia di qualità, una specie di critico a inversione. Se dice che una cosa fa schifo, vuol dire che è perlomeno decente. Grazie, per il nostro ego sei insostituibile.
No.
Se dico che fa schifo, per me vuol dire che è decisamente al di sotto della soglia del puro schifo.
Prego. Passo. Ritornerò.
sai descriverti bene, Franz!
amalgamandoti all’ambiente che sembra appartenerti ma
il tuo cuore è lontano, le tue radici -roride – non trovano innesto…
Esuberante la tua vena potrebbe spaccare il mondo
superando ogni malinconia che vorresti tranciare di netto
ma tutto passa
ci assorbe-assorbiamo…
pezzo impegnativo, fk, anche da leggere.
bravo.
Concordo con Ziggy.
E’ un passo vertiginoso che solo chi ha sangue bastardo può comprendere. Non è per i puri, per gli asettici, e neanche per i clinici della scrittura. E’ per chi ama la storia di un uomo e dei suoi popoli dentro.
Argomenti che sento profondamente, essendo di sangue misto come te, Franz barbaro. Torno ora da un viaggio al centro delle razze e delle mescolanze. Trovo questo passo e, in maniera inaspettata, tutto quello che avrei voluto scrivere, l’ho appena letto qui…
Chi cercava l’anima e non ha saputo trovarla in questa pagina, è persona sfortunata. I conflitti interiori sono ricchezza. Saperlo scrivere come fai tu, è da … riserva indiana.
Grazie.
secondo me, avete equivocato tutti.
quando ha scritto il suo primo commento, iannox si stava facendo la barba.
quando ha scritto il secondo, era intento a guardare inorridito l’intruglio che si stava preparando per cena.
‘prego. passo. ritornerò.’
sono le ultime parole della telefonata in corso col dottor gerardo carotenuto. o forse era il dottor felix peyote. comunque, siamo lì…
Noi viviamo sulla pelle. La pelle, il confine, la membrana sempre più assottigliata è dove i luoghi esterni si incontrano e si mescolano con quelli interiori, continuandosi o interrompendosi a vicenda. E’ dove si scontano le eredità e si cerca compulsivamente un affrancamento. E’ un pezzo tutto d’un fiato questo, difficile da vivere, prima che da scrivere. Che non tutti lo provino a comprendere è solo segno della fatica che non si è disposti a spendere. E l’arte, tanto più restituisce una vita, è soprattutto fatica.
a me è piaciuto. non credo sia facile narrarsi senza cadere nel compiacimento o nel voler compiacere. Mi è piaciuta la struttura, i due piani in cui si svolge, uno verticale-temporale, l’altro orizzontale-emotivo.
Lo scrittore si è narrato facendo del racconto un tessuto, intrecciando fili di terre, di ricordi, d’immagini, di tempo che c’è e di tempo passato tessendo al telaio trama ed ordito.è un tessuto ruvido, imperfetto. come la vita.
Franz, ho riletto il tuo racconto. È un pezzo di Letteratura. Raro. Strutturando le immagini in un più netto percorso narrativo, forse dovresti asciugarlo. In una scrittura densa come la tua, solo tu puoi farlo. Lascialo decantare. Ma ti dico questo probabilmente perché non riesco ad accettare completamente il totale lirismo del pezzo che si muove solo su un tempo esclusivamente interiore.
Entrando nel merito… L’uso esteso della metafora analogica, presentando scarti anche molto dilatati rispetto al referente, crea inaspettate angolature prospettiche, sostenute da un uso sapiente dello straniamento sintattico. La concretezza delle immagini riesce a dare una percettibilità materica di emozioni e di stati d’animo non convenzionali, colpendo il Lettore.
Grazie ancora. Il pezzo va sicuramente lavorato a fondo, sì, sono d’accordo.
Ciao a tutti.
amico,
la tua prosa è carne e sangue ancora vivo, è quadro fatto e finito.
io dico che non c’è niente da toccare, in questo caso.
no, asciugare i sentimenti non si può.
A volte è necessario farlo. Grazie comunque, amico.
Un ricordo di mio padre.
Mio padre era un uomo rigido, autoritario, di poche parole, una roccia, insomma uno “tutto d’un pezzo” eppure sveniva alla vista del sangue, ne bastava una sola goccia e giù, lo trovavi disteso a terra, bianco, indifeso.
Ti è mai capitato di svenire? Un’emozione profonda e poi il nulla.
Leggo, ho letto e riletto con calma, rubando il tempo al tempo che non ho, di notte come una ladra, una clandestina nell’ora buia. Ho letto con l’anima e con il cuore, gli unici mezzi che conosco, l’unica cultura che ho e l’unica base di tutte le altre.
“Si, viaggiare …” un viaggio a ritroso nella memoria e i suoi luoghi, da nord a sud lungo un percorso preciso: le origini. Un viaggio all’interno del corpo alla ricerca delle proprie radici per trovare un punto fermo da cui ripartire, un punto solido su cui ricostruire. Un viaggio sulla pelle per riscoprirne le sensazioni. Un viaggio all’indietro per poi rinascere a nuova vita. Un appello a se stesso e al mondo troppo spesso indifferente, per chiedere aiuto, supporto, una via di uscita dal passato e proiettarsi verso il futuro. Comunicare.
Ma non esiste un futuro se non si affondano le radici nel passato. Senza storia non siamo nulla, senza terra non siamo nulla, senza genitori e origini non siamo nulla. Bisogna trovarle le radici e affondarle nella terra perché poi come una grande quercia si possa tendere verso il sole, verso la libertà, la gioia, l’azzurro profondo del cielo.
Ma il viaggio è lungo e faticoso, doloroso. Mille volte vorresti tornare indietro verso lidi sicuri, tranquilli, nell’oblio dell’anima.
Magistrale il parallelo con la vita vissuta e le fotografie, istantanee di vita quotidiana passata e presente, di città, per descrivere meglio il male di vivere, quel continuo conflitto interiore fra essere o avere, dare e ricevere, vivere o morire. Inquietudine, tormento, insofferenza dell’anima proiettata al di fuori del corpo, nell’immagine di noi riflessa in uno specchio e descritta con dovizia di particolari. Per poi calarsi di nuovo dentro e cercare le radici della oscura sofferenza che impedisce di respirare e il desiderio di far uscire tutto il dolore che soffoca.
Il desiderio di alzare le braccia al cielo e afferrare quella mano che sbuca fra le nuvole e uscire finalmente dal baratro, trovare l’isola che c’è, da sempre e come una madre attende, attende di riabbracciare il figlio ramingo per il mondo, apolide nell’anima per scelta mai per origine, il padre.
Chi di noi ha il sangue puro? Siamo figli del mondo, di incroci di popoli, di corpi nudi in talami nuziali, in verdi prati di periferia o voli d’alta quota, ubriachi di passioni, schiavi dell’antico istinto bestiale e non d’amore.
Siamo apolidi per scelta o per bisogno d’amore? Ma lo cerchiamo quell’amore? o ci spaventa così tanto da farci dimenticare le radici e ci riempie il ventre di vermi putridi che divorano l’anima e accecano, accecano … alimentando l’indifferenza anche a noi stessi.
Ho letto Franz e riletto e non ho dormito, ho respirato il pathos, ho respirato il dolore, ho respirato il desiderio di liberarsi, di rinascere, ho respirato …
Se questo è l’inizio allora continua, va avanti, liberati e trova le radici, affondale, afferra la mano che da tempo è tesa verso di te dal cielo. Afferrala e scrivi sull’onda del ricordo, dell’emozione, a fior di pelle e liberati affinché tu possa trovare quel posto che è anche tuo.
Liberati di chi non legge, liberati di chi straparla solo perché ha una bocca, ma ha dimenticato di avere due orecchie, liberati dall’indifferenza che la fa da padrona e uccide le radici e i germogli dell’albero. Richiudi il ventre e chiudi la bocca di fronte a tutto ciò che non è amore assoluto, arte a molti sconosciuta.
Ah se ogni tanto abbassassimo il volume della nostra voce e rallentassimo il battito del nostro cuore! Ci renderemmo conto che ci sono altri cuori che battono e altre voci che gridano, come palpita e grida il testo che hai scritto.
L’indifferenza ci ha chiuso gli occhi, inaridito i pensieri, siamo diventati insensibili di fronte a un uomo che muore, fisicamente o spiritualmente.
Per cercare quelle radici ti sei inchiodato alla tua croce ora devi solo risorgere. Perciò chiuditi nel tuo “sepolcro” e continua a scrivere questa opera con la stessa profondità del prologo.
Si, siamo insensibili di fronte a chi vuole comunicare, dare amore senza chiedere e lo inchiodiamo sulla croce, siamo insensibili da millenni di fronte a un uomo che muore. Ma quell’uomo ha lasciato ancora una speranza, la via della resurrezione.
Potrà mai questa bellezza rovesciare il mondo? Potrà mai il sangue che scorre lungo la croce lasciarci ancora indifferenti? A tutto siamo indifferenti ma non al sangue che scorre, l’odore è pungente non si può far finta, l’emozione è forte, si sviene e poi il nulla, un attimo prima della resurrezione.
Cosa vuoi che aggiunga ancora?
“Chiedi e ti sarà dato,
bussa e ti sarà aperto,
cerca e troverai.”
Scrivi Franz sto aspettando la resurrezione dall’isola che c’è.
un abbraccio
Stella
P.S.: scusa se non ho capito, scusa se ho divagato ma l’invito era uno di quelli a cui proprio non si può dir di no.
Stella Maria, hai capito e ti abbraccio con gratitudine.
Ps.: scusate, ma quando qualcuno mi capisce io mi emoziono:-)
ti emozioni?!? allora sei vivo!
un abbraccio
Stella
O signur….ma che emozione!
sei VIVO, Franz?
mò ti abbraccio anch’io
stella bela della zia !