Bestiario: Paolo Trama
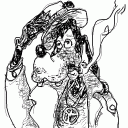
disegno di Andrea Pazienza
Animalità e fantasmi della scrittura:l’an(t)imetafora
di
Paolo Trama
In un certo senso, se lo scrittore è colui che spinge il linguaggio al limite, limite che separa il linguaggio dall’animalità, dal grido, dal canto, allora sì, bisogna dire che lo scrittore è responsabile di fronte agli animali che muoiono, responsabile degli animali che muoiono. Scrivere, non per loro, non si scrive per il proprio gatto o per il proprio cane, ma al posto degli animali che muoiono, significa portare il linguaggio a questo limite. E non c’è letteratura che non porti il linguaggio e la sintassi al limite che separa l’uomo dall’animale. Bisogna stare su questo stesso limite. Credo… Anche quando si fa della filosofia. Si è al limite che separa il pensiero dal non-pensiero. Bisogna sempre essere al limite che separa dall’animalità, ma appunto in modo da non esserne più separati. C’è un’inumanità propria al corpo e allo spirito umano, ci sono dei rapporti animali con l’animale.1
Nelle battute conclusive della voce ‘animale’ del suo Abecedario, così Gilles Deleuze illumina quella vertigine regressiva che spinge la scrittura al suo limite, ovvero sulla soglia che separa il linguaggio dall’animalità, dal grido, dal canto: «non c’è letteratura che non porti il linguaggio e la sintassi al limite che separa l’uomo dall’animale», sul confine dove l’umanità si separa dall’animalità, «ma appunto in modo da non esserne più separati».
E qui si vorrebbe appunto fornire qualche traccia dei ‘rapporti animali’ che la scrittura letteraria intrattiene con l’animalità, quella sorta di ‘divenire-animale’, per dirla ancora una volta con Deleuze, che, in alcuni testi letterari più di altri, agisce tra le pieghe delle immagini e delle metafore.
In Alice in wonderland di Lewis Carroll e in Parole in agitazione di Tommaso Landolfi le interazioni tra bocche, parole, animali configurano uno strano mondo dove la funzione linguistica regredisce allo stadio primario, per diventare grido infantile o verso animale, fino, addirittura, a ridursi alla proiezione di fantasmi delle parole stesse, alimenti indigesti che tornano a infestare ogni strenuo tentativo di attribuire senso al discorso umano.
1. In Pig and Pepper (Pepe porcellino), capitolo VI di Alice in Wonderland2, Alice tenta di salvare un «bambino Porcellino», condannato a morte con l’accusa di starnutire troppo, dopo aver abusato del pepe eccitante. La scena si apre su di una cucina (un immediato richiamo al cibo, dunque), dove si assiste alla graduale trasformazione di un infante in porcellino, appunto la metamorfosi di un essere umano in animale ‘commestibile’. Lo strano fenomeno giunge inizialmente all’attenzione di Alice grazie ai grugniti dell’ibrida creatura:
il povero piccolo rispose con un grugnito (aveva finito di starnutire). — Non grugnire — disse Alice; — questo non è il modo migliore per esprimersi.
Il bimbo grugnì di nuovo, e Alice inquieta lo guardò in faccia per scoprire cosa gli accadesse. Non vi potevano essere dubbi che avesse un naso molto all’insù, e che assomigliasse più a un grugno che a un naso vero; anche gli occhi stavano diventando notevolmente piccoli per un bimbo; insomma ad Alice l’aspetto del bimbo non piacque affatto.3
La voce/grugnito del bimbo/porcello resta costante, mentre il suo corpo cambia forma, a suggerire la continuità tra essere umano e animale. Come ha fatto notare Akira Mizuta Lippit, mettendo in contatto le due nature del bimbo e del porcello attraverso il grugnito, Carroll indirizza l’attenzione verso l’oralità in generale e verso la bocca in particolare. Ma, oltre che per fare rumori, la bocca viene utilizzata per mangiare. Tutta la scena che si svolge in cucina enfatizza le varie funzioni ad essa attribuite: la Duchessa culla (con sadica ninna-nanna) il bimbo che starnutisce e strepita, la cuoca cucina e il gatto ghigna da orecchio a orecchio. Insomma, in Wonderland le bocche sono posti pericolosi, o quantomeno misteriosi: il bimbo rischia di morire, forse mangiato; fino al momento in cui il gatto parlante del Cheshire, dopo varie apparizioni e sparizioni:
svanì lentamente, cominciando dalla punta della coda e finendo col sogghigno che rimase là per qualche istante dopo che tutto il resto era sparito.4
Qui, Carroll gioca costantemente con due livelli: corpo/bocca e oralità/linguaggio. Insomma, le due attività orali, parlare e mangiare, si scambiano continuamente di posto, generando il caos e l’indistinzione tra animale e umano, e quindi la crisi di ogni significazione:
Ricco o povero che sia, un linguaggio qualsiasi implica sempre una deterritorializzazione della bocca, della lingua e dei denti. La bocca, la lingua e i denti trovano la loro territorialità primitiva negli alimenti. Votandosi all’articolazione dei suoni, la bocca, la lingua e i denti si deterritorializzano. Vi è dunque una certa disgiunzione fra mangiare e parlare — e, ancora più, malgrado le apparenze, fra mangiare e scrivere: è certo possibile scrivere mangiando, è più facile che parlare mangiando, ma la scrittura trasforma in maggior misura le parole in cose capaci di competere con gli alimenti.5
2. In questo racconto di Tommaso Landolfi, Parole in agitazione, ritorna il nesso bocca\parola\animale. Stavolta, però, la bocca vomiterà parole vive in forma di fantasmi:
Al mattino, quando mi levo, naturalmente mi lavo i denti. Sicché stesi sullo spazzolino un vermicciuolo di dentifricio lungo circa un centimetro e mezzo, mi ficcai lo spazzolino in bocca fregando vigorosamente, quindi, colla bocca ancor piena di schiuma, succhiai un sorso dal rubinetto. Dico questo per dire che insomma feci tutto come al solito.
Mi sciacquai la bocca e sputai. Ma ecco che, invece di venir fuori la solita disgustosa miscela, vennero fuori loro, le parole. Non so come spiegarmi: erano parole ma erano vive, e guizzavano qua e là nel lavandino, per fortuna vuoto. Una scivolò e andò quasi a finire nel buco sul fondo, ma si riprese e si salvò. Parevano vispe e allegre, benché un po’ pazzerelle; giravano come fanno qualche volta i coniglioli in gabbia o le giovani lontre nelle rapide. Poi decisero di dare la scalata allo specchio. Non proprio allo specchio: volevano inerpicarsi sulla mensola dello specchio, e ci riuscirono benissimo, non so in che modo. E qui mi accorsi che discorrevano anche, o meglio gridavano con un vocino acutissimo, sebbene sempre fievolissimo per le mie orecchie. Sulla mensola fecero un monte di balletti, di lazzi e d’inchini, come fossero su una ribalta, e poi presero a far dei cenni, da cui capii che volevano parlarmi. Tesi l’orecchio e accostai il viso, e così, non senza sforzo, potetti udirle; non solo, ma, abituandosi il mio occhio, cominciai a riconoscerne alcune. In verità dovrei dire a individuarne o leggerne alcune, giacché molte le conoscevo appena per prossimo; ad ogni modo vidi la parola Locupletale, e Massicotto ed Erario e Martello ed altre.6
Allo scrittore che al mattino si sta lavando i denti, al posto della «solita disgustosa miscela», si presentano delle parole vive, che guizzano nel lavandino dopo che egli ve le ha sputate. Scalata la mensola dello specchio, «ribalta» dove prodursi in balletti, lazzi e inchini, le parole, gridando con un «vocino acutissimo», per quanto «sempre fievolissimo», si rivolgono allo sconcertato protagonista, il quale pure riesce a individuarne o ‘leggerne’ alcune, nonostante si tratti di parole desuete o rare. Adeguandosi a una pratica diffusa in tempi di «rivendicazioni, di ridimensionamenti e consimili ri», la loro protesta consiste nel pretendere una ri-distribuzione dei significati in base al loro significante, alla disperata ricerca di un legame necessario con quanto significano a partire dal suono stesso che le identifica:
«Ebbene ascolta. Io, per esempio, son Locupletale: e cosa significo?»
«Significhi press’a poco Attinente alla ricchezza.»
«Già, perché lo sai; ma se non lo sapessi?»
«Che razza di domanda.»
«No, vedi, io significo quello che hai detto, ma ti par giusto? Dovrei invece significare Attinente a ruscello o in genere ad acqua che scorre.»
«Ma perché?»
«Perbacco, lo-cu-ple-ta-le: non ce l’hai l’orecchio?»7
Il punto è che non sarà sufficiente, come pure avrebbe sperato lo scrittore, operare delle inversioni reciproche, dal momento che, espropriata di quello convenzionalmente attribuitole, la parola non si accontenta di acquisire il significato di quella che le ha sottratto il suo, ma aspira a sua volta a impadronirsi capricciosamente di quello di un’altra. In questa confusione babelica, le parole vengono con uno stratagemma costrette una a una ad accettare il significato che il caso ha loro attribuito: compresse tutte insieme in una bottiglia e poi estratte una alla volta, alle parole ribelli, prima che si disperdano negli angoli della casa, viene affibbiato uno dei vari significati che in precedenza lo scrittore aveva avuto cura di annotarsi man mano che le imbottigliava; ma, a operazione compiuta, il malcapitato si avvede che non sarà più in grado di ricostruire le nuove attribuzioni, dal momento che non ha fissato i «vari passaggi». Si ritrova così con delle parole vaganti per la casa che, «un giorno o l’altro, vedrete, mi risalteranno addosso»8.
Dunque, le parole, espulse dalla bocca e divenute creature autonome, scelgono come interlocutore proprio colui che ne fa tanto un uso comune («tratta»), quanto uno specifico, creativo («bistratta»):
«Noi siamo parole» prese a dire Locupletale che sembrava la comandante. «Lo vedo» risposi. «Noi siamo parole, e tu sei un di quelli.» «Chi quelli?» «Un di quelli che ci tratta e ci bistratta. Ragion per cui è legittimo che proprio a te ci rivolgiamo per giustizia.»9
Lo scrittore ha dunque perso il controllo su questo rigurgito verbale che gli si rivolta contro. Le parole gli ritornano alla bocca come massa indigerita, presentandosi come ‘cose vive’ — veri e propri fantasmi — prendendo corpo e manifestando la loro consistenza sonora e grafica sotto forma di puri significanti; allo stesso tempo, però, ripudiano l’accezione comune socialmente attribuitagli, provocando uno scompenso sul piano dei significati, che slittano all’infinito e si perdono nella memoria di chi ne faceva uso; così, non resta altro che provarsi ad attribuire loro dei significati ‘a caso’ in attesa della successiva incursione.
Il «vocino acutissimo» ma «fievolissimo», a stento udibile dall’esterrefatto scrittore, allude con ogni evidenza allo «stato di insufficienza» che lo scrittore lamenta in più punti della sua opera: si tratta di una condizione creativa in cui domina un forte senso di epigonismo alla cui costituzione contribuiscono fattori tanto esistenziali quanto sociali e storici, una profonda predisposizione nostalgica sia verso una parola primigenia, adamitica, in grado di creare la cosa stessa nominandola; sia verso la grande letteratura del passato, capace di plasmare con la parola mondi ben più veri di quello reale. La scrittura landolfiana si dispiega dunque anzitutto come lutto per il dominio che in un tempo più o meno mitico lo scrittore esercitava nei confronti delle parole, piegandole docili ai propri fini, ripiene di un’energia primigenia più o meno magica.
Operatasi quindi una profonda scissione tra significanti e significati a causa di un utilizzo veicolare e profano della lingua, questi ultimi manifestano tutta la loro instabilità, finché le parole si ribellano e si trasformano in veri e propri significanti-fantasma, indigerite e indigeribili, che assediano proprio colui che più di ogni altro dovrebbe farne buon uso: è così che il linguaggio perde del tutto la sua portata figurale socializzabile, regredendo allo stadio orale-alimentare, da cui pure aveva avuto origine.
In questo racconto si teatralizza lo sprigionarsi di forze primigenie rimosse e pertanto incontrollate dimoranti nei meandri stessi della lingua. Ecco perché sono appunto le parole più desuete a portare avanti la ribellione: sono queste a conservare più intatto il patrimonio di una potenza che non può più a lungo essere elusa, pena il ritorno del rimosso sotto forma di puro revenant. La lingua non è un medium trasparente – Landolfi sembra voler qui ricordare minaccioso – ma un potente strumento medianico, in grado di mettere in comunicazione con altri mondi, altre dimensioni dello spirito e della materia.
3. Questo stesso racconto – quasi un elzeviro, in verità, considerata la sua trasparenza tematica – offre la possibilità di indagare più approfonditamente tra le pieghe di questo delicato intreccio tra oralità, parola e animalità. Appena oltre il livello meramente contenutistico e già ad apertura, presenta infatti una ingegnosa metafora zoomorfa: «vermicciuolo di dentifricio», dove materia grafica e materia sonora del veicolo animale sembrano voler mimare la forma serpentina della cosa evocata, cioè la porzione di dentifricio nel suo sinuoso snodarsi sulle setole dello spazzolino.
Inoltre, le presenze animali accompagnano in costante contrappunto i pochi scarni eventi qui narrati. È evidente come, al fine di rimarcare la loro genesi orale in esseri viventi, le parole vengano animalizzate; sono, cioè, più volte assimilate ad animali: sul principio, a «coniglioli in gabbia» e a «giovani lontre nelle rapide», per la loro vivace irrequietezza; a dei «sorci in trappola», verso la fine, allorché vengono pressate tutte insieme nella bottiglia10. Per non dire poi del proverbio invocato dal personaggio-scrittore per descrivere icasticamente il subbuglio prodotto da parole vocianti che litigano per accaparrarsi un nuovo significato: “«Calma,» dissi io «è proprio vero che due femmine e una papera misero un mercato a Napoli»”11.
4. Di fronte a una crisi profonda del linguaggio (e della letteratura), la scrittura mette in scena la risalita alla fonte stessa della parola (la bocca), e quindi alla sua origine: e proprio qui la scrittura di Carroll e Landolfi incontra l’animale come fantasma incorporato nella scrittura, definibile come ‘antimetaforico’, perché, per quanto privo della parola – e anzi proprio per questo – funge da efficace emblema del limite della figurabilità della parola e, al contempo, dell’origine stessa della funzione del linguaggio. L’animale viene incorporato nella parola come accade al fantasma in un lutto non elaborato. Come ci insegna la ricerca clinica sul lutto e la melanconia dei due psicoanalisti ungheresi Nicolas Abraham e Maria Törok, sulla scorta delle indicazioni già fornite da Sandor Ferenczi, in casi di mancata elaborazione di una perdita, si può circoscrivere un uso peculiare del meccanismo primario dell’‘incorporazione’, rispetto al più generale e ‘normale’ meccanismo dell’‘introiezione’:
Se si vuole comunque vedere un linguaggio nei procedimenti che governano una tale fantasmatizzazione, conviene inventariare una nuova figura retorica, per cui proponiamo il nome di antimetafora. Precisiamo che non si tratta di ritornare semplicemente al senso letterale delle parole ma di farne un uso tale – in parole o in azioni – che la loro «figurabilità» ne è come distrutta […] ciò che vi è di più antimetaforico è l’incorporazione stessa: essa implica la distruzione fantasmatica proprio dell’atto che rende possibile la metafora, ossia l’atto di mettere in parole il vuoto originario, l’atto di introiettare.12
Prendere alla lettera ciò che ha valore figurato e oggettivare ciò che si è perduto sotto forma di fantasma da ibernare vivo-morto nell’inconscio: sono esattamente queste le strategie messe in atto nel processo dell’incorporazione, che subentra al più normale e progressivo processo di introiezione, allorché, di fronte a un lutto troppo gravoso per l’economia psichica, il soggetto regredisce allo stadio orale-alimentare, precedente alla costituzione di quel sistema di significazione figurato che è il linguaggio.
Questo modello di spiegazione, elaborato in sede psicoanalitica per spiegare gli effetti patologici di un lutto non elaborato, può rendere conto dell’«azione sovversiva» che le presenze animali, fungendo da inconscio artificiale della scrittura, esercitano dal suo interno:
Il porrovio! Che bestia è il porrovio? Mi duole dire che io stesso non lo so, e la medesima cosa mi capita colla beca. Lui ha un’aria tra il tapiro e il porco o il babirussa, è quasi senza collo. Compare quando la notte corre come una lepre al sole, colle orecchie trapassate dalla luce; e quando dall’ombra mi spia e mi cova la follia, accovacciata come un gatto, o meglio come un escremento di vacca, cogli occhi gialli.
Da molto tempo la mia vita è ossessionata dalla ricerca o dalla sistemazione di parole. Il porrovio si aggira grigio nelle tenebre, il porrovio viene e va, il porrovio è una massa che io non posso inghiottire.
Il porrovio non è una bestia: è una parola.13
Ecco perché l’animale incistato nel testo letterario è definibile anche come ‘animetaforico’: per la sua purezza incorrotta, è capace di trasportare dentro le fibre del linguaggio, dopo averne azzerato la portata figurale, un’energia segreta che, giungendo da un altrove-prossimo, spinge la parola oltre il suo più scontato potere comunicativo-referenziale: forse è proprio qui, in questa dimensione an(t)imetaforica, il rapporto animale che la scrittura intrattiene con l’animale; forse è proprio questo il vero e proprio divenire-animale del testo.
Note
1 S.v. Animale, in Abecedario di Gilles Deleuze, video-intervista in 3 dvd a cura di Claire Parnet, regia di Pierre-André Boutang, Roma, DeriveApprodi, 2005.
2 Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, testo inglese a fronte, Milano, Rizzoli, 1978, (cap. VI) pp. 140-165. Per l’analisi di questo capitolo, si utilizzeranno le pagine ad esso dedicate, presenti nel volume di A. M. LIPPIT, Electric animal. Toward a rhetoric of wildlife, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, pp. 136-143.
3 L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, cit., pp. 154-155 [«The baby grunted again, and Alice looked very anxiously into its face to see what was the matter with it. There could be non doubt that it had a very turn-up nose, much more like a snut than a real nose; also its eyes were getting extremely small for a baby: altogether Alice did not like the look of the thing at all.»].
4 Ivi, p. 162-163 [«it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone.»].
5 Gilles Deleuze e Felix Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, trad. it., Macerata, Quodlibet, 1996, p. 35.
6 Tommaso Landolfi, Parole in agitazione (tratto dalla raccolta Un paniere di chiocciole del 1968), in Id., Opere, a cura di Idolina Landolfi, Milano, Rizzoli, 1992, vol. II: 1960-1971, p. 855.
7 Ivi, p. 856.
8 Ivi, p. 858.
9 Ivi, p. 855.
10 Inoltre, una di esse «squittisce» nel rispondere ad un’altra (ivi, p. 857).
11 Ibidem.
12 Nicolas Abraham e Maria Törok, Lutto o melanconia. Introiettare — Incorporare, in Eid., La scorza e il nocciolo [trad. it.], Roma, Borla, 1993, p. 261 — corsivo del testo.
13 T. Landolfi, Cancroregina [1950], in Id., Opere, a cura di I. Landolfi, Milano, Rizzoli, 1991, vol. I: 1937-1959, p. 564
L’articolo è di prossima uscita sulla rivista “Dialogica”


Parevano vispe e allegre, benché un po’ pazzerelle; giravano come fanno qualche volta i coniglioli in gabbia o le giovani lontre nelle rapide.
Che bel testo. Come non ricordare Lettera a una signorina a Parigi del Bestiario di Cortazar, uno straordinario piccolo racconto dove allo strano protagonista che scrive la lettera all’amica che gli presta il suo appartamento a Buenos Aires, capita, ogni tanto, così, con naturelezza nei momenti più impensati, di vomitare deliziosi piccoli coniglietti bianchi con un leggero solletico in gola.
Quando sento che sto per vomitare un coniglietto, mi ficco due dita in gola come una pinza aperta, e aspetto di sentire nella gola la peluria bionda tiepida che sale comeun’effervescenza di sali di frutta.
Uno ogni tanto è facile regalarli e sbarazzarsene. Ma, ospite della casa dell’amica Andree, il fenomeno diventerà stranamente sempre più frequente, i coniglietti, chiusi di giorno in un armadio all’arrivo della domestica, di notte cominceranno a devastare la casa distruggendo ogni cosa ed insieme minando l’ordine chiuso, logico della vita.
Andrée,
io non volevo venire ad abitare nel suo appartamento di via Suipacha. Non tanto per i coniglietti, piuttosto perché mi addolora entrare in un ordine chiuso, costruito ormai fin nelle più sottili maglie dell’aria, quelle che in casa sua preservano la musica della lavanda, il volo di un piumino per la cipria, il gioco del violino con la viola nel quartetto di Rarà.
Ed alla fine non gli resterà che saltar giù dall finestra, lui e i coniglietti.
Allora ecco l’alba e una fredda solitudine che racchiude l’allegria, i ricordi, lei e forse assai di più. Ecco questo balcone su via Suipacha pieno d’alba, i primi rumori della città. Non credo che sarà difficile raccogliere undici coniglietti disseminati sul selciato, magari non si accorgeranno neppure di loro, affannati come saranno intorno all’altro corpo che conviene portar via subito, prima che passino gli scolari più mattinieri.
Come le parole espulse dalla bocca si assemblano in significati nuovi e misiteriosi, i coniglietti diventano entità incontrollabili.
lo leggo stasera…
;-)
bel testo… per un laureato in filosofia poi… ;-)
io quel Pippo lì…
me lo magno!
Tutto ciò che riguarda la bocca è
cibo che nutre la mente,
latte bianchissimo da sorseggiare
Leccare il sentiero e farlo proprio….
Vorrei conoscere quel sentiero.