Poetto Galli
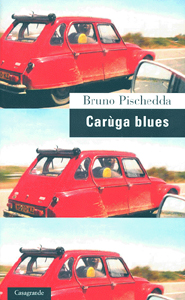 di Bruno Pischedda
di Bruno Pischedda
[episodio tratto da Carùga blues, Casagrande, 2003, che molto mi piacque, e perciò ho chiesto ed ottenuto da Bruno la possibilità di pubblicarlo qui su NI. Rammento che di Bruno Pischedda è appena uscito questo libro. ]
La sede dei comunisti stava all’estrema punta nordorientale del paese, come quella dei socialisti del resto. Qualche decina di metri oltre c’era la piazza Primo Maggio, il tavolato sul quale si sgranava e si batteva il mais, a settembre, dove si installava la giostra per la festa del santo patrono ma anche il tendone del Circo Williams: un’esile compagnia di guitti, muniti di una vecchia leonessa, di pochi cavalli maremmani, che pure, appena dodicenne, Clara aveva visto bene di seguire dopo l’ultima rappresentazione. Era il sessantanove, il settanta, la cronaca nera già marciava a tutto vapore, e Clara era sparita. Dramma generale. Il padre, la madre, il parroco, il vicinato, parenti e affini di ogni ordine e grado erano entrati in uno stato di subbuglio ansioso. Il panico si diffondeva e mieteva vittime nei cortili, tra i benpensanti, non tra i carabinieri di Senago, che a colpo sicuro erano andati a prelevare la fuggitiva prima che scendesse la notte e scattassero le denunce per ratto di minore.
– Chi, lei…? – pare avesse risposto il più estroso dei Williams, evidentemente già invaghito, – lei…? è mia cugina, facciamo il numero con i coltelli…
E si beccò un centrone in piena faccia dal maresciallo. Per cui sommossa, sara sara, tiro alla fune con Clara in mezzo che piangeva, articoli sul bollettino locale…
Via dei Martiri, la Bindelina – un lungo casamento a ringhiera, senza ali, privo di cinta muraria –, il Circolone con le sue rappresentanze politiche e le strutture per lo svago, quindi la piazza Primo Maggio. Più in là ancora, a nemmeno un lancio di fionda, iniziavano i boschi e la terra grassa e argillosa di groane.
Dal di fuori come dal di dentro, la base dei rossi (ul palasàsc, ul circulùn) aveva gli intonachi che cadevano a pezzi. Agli inizi del novecento una trentina di cesatesi si era costituita in cooperativa edilizia, l’Edificatrice, e lì, tra un cortile e un casermone agricolo, aveva tirato su un monumento complicato, tutto scale e corpi sporgenti: il Circolone, dopo che era passato sotto il controllo dell’Arci (per opera di Gavrìli), mentre il Circolino era quello delle Acli. Il calzolaio e una rivendita di pane, sulla facciata, poi si saliva per una scalinata ripida, fino a uno spiazzo di cemento grezzo, in fondo al quale rimaneva il bar con il bocciodromo, per i tornei interregionali. Sul lato destro dello spiazzo si inarcava una seconda scala esterna, in ferro, lunga pochi metri, e su quella incombeva il casotto di proiezione del cinema Mignon: vero rifugio anticattolico, luogo di turbamenti e di stra-nezze erotiche godute in mezzo ai topi e alla muffa, in compagnia degli scarafaggi bianchi, dei furbìs; galleria senza platea dove non si accendeva la luce tra il primo, il secondo e il terzo tempo affinché le poche giovani che vi si azzardavano la domenica pomeriggio non fuggissero con le mani nei capelli, e magari sbottonate o in tutto e per tutto discinte (biòtt).
Helga, di un regista ignoto, era la pellicola che doveva lasciare un segno nelle nuove gene-razioni del benessere, Helga e il suo seguito, Helga e Michel, con una scopata quasi completa e un parto a camera fissa, frontale. Ma anche Il giardino dei Finzi Contini, ossia le poppe in piena luce di Dominique Sanda, alte e ben areolate, i pullover bianchi con il collo a semirombo per giocare a tennis, per aggirarsi signorili tra le vie del paese montati sulle nuovissime biciclette Graziella.
Alla Bindelina abitava Poetto Galli, ul fiœu dal Mudestin, un non vedente in cura da un noto psicologo milanese. Lievemente obeso, ma agilissimo nei movimenti, capelli lunghi e laterali sempre allisciati, baffi radi, poco più che un’ombra sulla bocca, Poetto all’età di tre anni aveva contratto una malattia, gli occhi di bue la chiamavano in paese. A causa di un contagio virale le cornee avevano subito una deformazione e i bulbi si erano fatti opachi, bolliti, ricadendo all’infuori. Ma fino ai tre anni ci aveva visto, memoria di volti e colori, strade, giochi in compagnia ne aveva. Così questo psicologo lo visitava settimanalmente, a titolo gratuito, perché aveva in progetto un trattato scienti-fico risolutivo sui sogni dei ciechi divenuti.
Si fa presto a pretendersi unici, irripetibili. Chi più ostenta la propria originalità, contrappo-nendosi con impegno al proprio prossimo e al proprio tempo, di solito risulta ridicolo o unanime-mente s’centràa, fœura; mentre coloro che senza dubbio rientrano nel gruppo degli eccezionali, non lo sanno. Gli orbi e i cicati di tutte le risme andrebbero suddivisi in due grandi categorie: i treme-bondi, che si sentono in balìa di tutto e di ciascuno, e dunque si limitano negli affetti, negli svaghi, negli interessi intellettuali persino; e i pazzi irresponsabili. Poetto Galli apparteneva a questa seconda categoria, poi senza nulla di studiato o di programmatico ci aggiungeva largamente del suo.
Refrattario all’assistenza dell’Unione Ciechi, capace di cacciare di casa con una bestemmia arabescata le dame della San Vincenzo che cercavano di portargli conforto, cioè di tenerlo legato alla parrocchia, Poetto aveva lasciato ingrassare il cane specificamente addestrato fino al punto da immaialire. Bartolo era il nome, ereditato da un vecchio cane da caccia del nonno: nemmeno si alzava più dalla cesta accanto alla stufa, né abbaiava, né snasava se qualcuno varcava la soglia di casa. E lui, Poetto, si accontentava di un bastoncino pieghevole che una volta memorizzato il percorso gli consentiva di picchiettare disinvolto alla meta. Qualunque meta, paesana o cittadina, pianeggian-te, acquorea, in rilievo.
Studiare aveva studiato, in un istituto superiore per ciechi, perché la famiglia ci teneva, non badava a spese; e assunto in seguito come centralinista presso un giornale cattolico Poetto si era detto non soddisfatto: – L’è no asé… – ripeteva, – l’è minga pusìbil ca l’è propi tüta ki (la cultura, intendeva, ul savér i robb ben, inscì da sbusà ‘l cü di sapientùni e de fagh fàa la figüra dal ciuculatè: in modo da bucare il culo ai sapientoni, tradotto, e da far fare loro davanti a tutti la figura dei cioccolatai), – e così si era iscritto di buona lena all’università, nel ramo letteratura filosofica.
Con un apparecchio Akai semiprofessionale a quattro piste, avvolgimento rapido, microfono direzionale, io gli registravo i libri da portare agli esami. I dialoghi di Platone, Coinema e Icona di Franco Fornari (perché lo psicologo dal quale era in trattamento l’aveva suggestionato), Al di là del principio di piacere di Freud, Essere e tempo di Heidegger, Aut-Aut di Kierkegaard.
– Allegria! – gli dicevo, in brevi commentari che dovevano introdurre all’opera vera e propria. E – Scusa, a ’l su no, – se di qualche termine greco o tedesco mi era impossibile anche solo azzardare la pronuncia. Ogni bobina durava dodici ore, quattro per ogni pista, e nella bobina rimanevano prigionieri anche gli stornelli cantati da mia madre, da basso, le liti tra Grazietta e l’appigionante-amante-padre presunto, i latrati di Zagor che satollo di avventure e di libertà chiedeva di rientrare alla base.
Più di trenta libri gli registrai. Mi dava ottomila lire per ciascuna pizza, duemila per ogni pista. Insieme facemmo gite montane, in baita, isolati dal mondo; lui a un capo del tavolo che ascoltava me registrato (perché riversava le pizze su semplici cassette, a puntate), mentre io cercavo di concentrarmi sui libri che avevo comprato con i suoi soldi: quelli che mi dava per le incisioni, quelli per acquistare le bobine, di cui presto aveva perso il conto, e quelli per l’Akai che, gli spiegavo, continuando a guastarsi necessitava di riparazioni specialistiche, a Milano.
Non terminò mai. Nella redazione del giornale cattolico conobbe un’avventizia e la sposò, ebbe figli, abbandonò Cesate andando a stare dalle parti di Legnano. Un irresponsabile stupidamente generoso era. Molti anni dopo, quando anch’io avevo lasciato il paese, lessi in un articolo di cronaca cittadina che un non vedente a nome P. G. camminando in una stazione della metropolitana era sprofondato in una condotta di aerazione lasciata criminalmente scoperta. Quattro ore c’erano volute per tirarlo fuori, si era incastrato. E alla giornalista che lo intervistava a botta calda, mentre ancora si tastava le ossa e gli infermieri lo reclamavano per una visita di controllo, aveva assicurato che non c’era problema, su de doss, e tapìla.
Domanda: avrebbe citato l’azienda municipale per danni? Cioè milioni e milioni, come dire, gite a ufo oltre cortina, bei vestiti, apparecchi elettronici di nuova invenzione al posto del braille. Risposta: No. Si accontentava che la lezione fosse servita, e che in futuro casi simili non avessero a ripetersi per altri come lui o diversi da lui.
Telefonai ai genitori, mi feci dare il numero di Legnano.
– Imbecille! – gli lasciai inciso sulla segreteria: – Tu non sei cieco, cerca di non confonderti, sei imbecille!
La scena potevo immaginarla. Perché talvolta, alla stazione di Cadorna, sulla banchina della metropolitana lo avevo incontrato anch’io.
Faceva impressione. Veniva giù fiondato dalla scala con il suo bastoncino del cazzo, tap, tap, tap, agile come un elefantino, fischiettante, e TAP!, quando i presenti già stavano per mettersi a urlare, si inchiodava a una spanna e anche meno dal baratro.
Lo chiamavo, allora. E lui, brancicandomi il petto con trasporto esagerato: – Carùga! Uh diu, quant’è che non ci si vede?
– Tutta la vita, – era la risposta che cercava.
Perché gli garbava, addirittura lo entusiasmava sentirsi dare del cieco cicato e bollito. Potersi incontrare al bar o in casa di questo e quell’altro per lui coincideva sempre con la possibilità da vidès; a sa vedum, era il saluto; mentre il consiglio di lasciar perdere, di quietarsi, suonava varda no; insultare qualcuno in lingua era vedi di andartene affanculo: altrettanti modi per ostentare la forza d’animo e più forse la spavalderia con cui sopportava una menomazione tanto severa.
Una mattina, in montagna, anzi un’alba, eravamo scesi di qualche centinaio di metri per mendicare una secchia di latte nello stallatico di un pastore. Ero ancora in pigiama. Cioè. Indossavo la mia tuta chiara, di spugna, e zampettavo infreddolito picchiandomi con ambedue le braccia pinzate sulle maniche.
– Carùga, come cazzo è che ti sei vestito, da Cappuccetto bianco?
Rimasi folgorato. Evidentemente non è che Poetto non ci vedesse del tutto. Da dietro gli occhiali affumicati, coperti ai lati, riusciva ancora a distinguere le fonti luminose, i contrasti. E contro il cielo nero di nuvole, tutt’altro che promettente, su quei ronchioni scuri anch’essi e umidi di brina così mi aveva interpretato.


Volevo rendervi noto che questo venerdì alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Manzoni, insieme a Bruno Pischedda che presenta il suo ultimo lavoro, ci sono Giuseppe Genna e Stefano Salis.