FICTIONSCAPE. Splendori e miserie della fiction televisiva italiana #1
di Giorgio Vasta
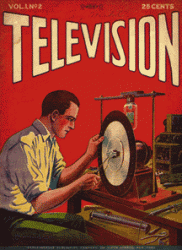 Da un po’ di tempo avevo intenzione di ragionare a fondo sulla fiction televisiva italiana contemporanea, sulla sue premesse culturali, sulla sua fattura e sui suoi obiettivi, partendo dall’idea che la fiction tv è un dispositivo narrativo che produce una determinata lettura del mondo e che genera un immaginario popolare. Poi, qualche settimana fa, il ministro delle comunicazioni Landolfi, rispondendo a una dichiarazione di Prodi, ha affermato che la fiction televisiva italiana, in questo specifico momento, è di sinistra, quasi comunista, portando l’esempio del Commissario Montalbano e del Grande Torino, in onda in quegli stessi giorni. Questa affermazione mi ha colpito e mi ha suscitato una serie di considerazioni. Rendendomi conto che non era possibile affrontare il discorso da solo, ho chiesto a chi lavora nella produzione della fiction (sceneggiatori, head writer, script-editor, story-editor, produttori) di discutere di questo argomento, riassumibile in una frase: come si fa la fiction tv in Italia, e che cosa fa la fiction tv all’Italia?
Da un po’ di tempo avevo intenzione di ragionare a fondo sulla fiction televisiva italiana contemporanea, sulla sue premesse culturali, sulla sua fattura e sui suoi obiettivi, partendo dall’idea che la fiction tv è un dispositivo narrativo che produce una determinata lettura del mondo e che genera un immaginario popolare. Poi, qualche settimana fa, il ministro delle comunicazioni Landolfi, rispondendo a una dichiarazione di Prodi, ha affermato che la fiction televisiva italiana, in questo specifico momento, è di sinistra, quasi comunista, portando l’esempio del Commissario Montalbano e del Grande Torino, in onda in quegli stessi giorni. Questa affermazione mi ha colpito e mi ha suscitato una serie di considerazioni. Rendendomi conto che non era possibile affrontare il discorso da solo, ho chiesto a chi lavora nella produzione della fiction (sceneggiatori, head writer, script-editor, story-editor, produttori) di discutere di questo argomento, riassumibile in una frase: come si fa la fiction tv in Italia, e che cosa fa la fiction tv all’Italia?
Ho quindi realizzato alcune interviste (per posta elettronica, una domanda alla volta), che in realtà sono vere e proprie conversazioni, e altre ne sto portando avanti. Alla fine di ogni conversazione mi limiterò a pubblicare il tutto su Nazione Indiana senza modificarlo, cosa che comporterà a volte qualche inevitabile ripetizione, della quale mi scuso.
Si parte con un dialogo in tre parti con Giovanna Koch, sceneggiatrice per il cinema e per la televisione (da Sottovento! a La squadra alla sit-com Belli dentro, realizzata in collaborazione con alcuni detenuti di San Vittore), che ringrazio per la grande disponibilità.
LE BOTTEGHE RINASCIMENTALI, LE LOGICHE DELLA COMMITTENZA E LA NO MAN’S LAND DELL’AUTORE
GIORGIO. Quello che mi interessa – a partire dalla recentissima affermazione del ministro delle comunicazioni Landolfi circa la natura di sinistra, se non addirittura comunista, di parecchie fiction contemporanee – è riuscire a ragionare a fondo sul modo in cui vengono concepite le fiction in questi anni in Italia, su quali siano i modelli narrativi prevalenti, se è sensato supporre che questi modelli narrativi siano per certi versi più determinanti, ai fini di suggerire una particolare lettura del mondo, della specifica storia raccontata (eventualità che smentirebbe Landolfi ma anche chiunque ritenesse che la fiction tv in Italia può essere di destra o di sinistra).
La mia sensazione – che vorrei mettere in torsione nel corso di queste interviste – è che la fiction produca una dimensione valoriale che prescinde dai colori politici e che al limite è loro trasversale. Insomma, quello che vorrei fare è un discorso molto concreto, stabilendo un nesso tra tecniche narrative (lo strumentario a disposizione di chi scrive e produce la fiction) e conseguenze nella percezione delle cose.
GIOVANNA. La mia idea da qualche anno è che per la fiction noi stiamo vivendo una condizione molto simile alle botteghe artistiche del periodo rinascimentale. Allora – come adesso – i soggetti da raccontare erano “obbligati” da necessità diverse dalla pulsione artistica. Diciamo che dobbiamo raccontare, oggi come allora, madonne e storie di santi. Non credo affatto che le tecniche narrative per i generi televisivi, che sono a nostra disposizione come allora i pennelli, le dimensioni dei quadri e i tempi di consegna e i soldi, rappresentino una dimensione valoriale. No. Potremmo metterci dentro tutto e il contrario di tutto. Sono strutture che – anche se obbediscono a necessità editoriali – sono estremamente duttili, come ci insegna la fiction seriale americana. Dunque sono i contenuti, i valori a essere obbligati dal committente. Più o meno sangue, più o meno sesso, più o meno sociologia sono indicazioni precise della committenza. Talvolta la committenza non si allinea con i desiderata del governo, ma è ugualmente precisa, nel senso che vengono ugualmente censurati da sinistra sia personaggi troppo fascisti che il sarcasmo contro personaggi idealisticamente da proteggere come disabili, poveri, operai ecc… L’ideologia formale è sempre stato un deterrente dell’arte e francamente non mi pare interessante andarla a stanare perché si stana da sola. L’ideologia annoia. Quello che mi pare più interessante è la sfida che ogni singolo autore raccoglie quando si accinge a scrivere con gli input obbligati che riceve insieme all’assegno che gli consente di sopravvivere. La sfida è trasformare il trasformabile in arte e cioè far corrispondere emozione profonda a segni chiaramente leggibili per la maggioranza delle persone. Non tutti i quadri che rappresentano madonne sono uguali: alcuni sono brutti e altri belli. Così sinistri o destri possiamo fare cose belle o brutte. Quel che è certo è che quando una cosa è bella porta anche il segno dell’emozione di chi l’ha creata. E dunque passa attraverso i canali culturali dell’autore: se è di sinistra, l’emozione passerà attraverso sensibilità tradizionalmente di sinistra, se è di destra idem. Dunque se le fiction che raccolgono pubblico lasciano il segno e vengono considerate belle, sono di autori di sinistra, vuol dire semplicemente che quegli autori sono di più e più bravi e che sono riusciti a pervadere gli spazi aperti delle strutture della fiction con la loro arte mista alla loro cultura. Forse si può dire anche che la sinistra tende a lasciare – con le sue tematiche e la preferenza valoriale accordata all’individuo – un contatto più aperto con quella che viene definita realtà, mentre la destra può farsi condizionare più facilmente da meccanismi ripetitivi e aridi, perché fa parte dell’ideologia di destra preferire i valori collettivi (e dunque gli standard) ai valori individuali. Insomma è la retorica delle ideologie che ci spinge a posizionare gli artisti a sinistra, ma è solo una questione di numeri. Artisti di sinistra che hanno fatto cose belle, fanno anche cose sinceramente orrende: e non è colpa dei committenti. La mia impressione – ad esempio – è che la tendenza ideologica della Meglio gioventù è l’aspetto più noioso e artisticamente meno riuscito di tutto il film, che ha invece dei punti altissimi di espressività artistica: voglio dire che Rulli e Petraglia sono bravissimi e quello che gli gioca contro è proprio il fatto di “doversi” schierare a sinistra. Ciò detto è vero che il modello neorealista che l’Italia è riuscita a inventare e a imporre a se stessa e al mondo intero come marchio di fabbrica (vedi i film che hanno vinto gli Oscar) è un modello di sinistra ed è stato – nel momento d’oro del cinema – talmente introiettato dal pubblico da assumere su di sé un modello di bellezza artistica tout court. Ma questo è un handicap anche per la sinistra: l’intellighentia scrive e gira tutti film “poveri” e sfigati perché non riesce a concepire bellezza e arte in forme diverse. Questo probabilmente è davvero il nostro limite attuale: non il non poter scrivere cose di sinistra, ma scrivendo cose di sinistra essere obbligati a concepirle con le vesti del populismo neorealista, che somigliano all’umanesimo cristiano e non ci mettono contro il vero censore del paese: il papa in casa. Noi non potremo mai scrivere – né destri, né sinistri – con il libero cinismo di Desperate Housewives o di Law & Order e non perché non ce lo consentano le strutture della fiction.
GIORGIO. Provo a concentrarmi su uno specifico punto sollecitato da quanto scrivi.
Il nesso autori di fiction-botteghe rinascimentali. Mi piace molto, mi sembra davvero una bella intuizione sulla quale varrebbe la pena di riflettere approfonditamente cercando di individuare, se ci sono, analogie socio-politiche tra un tempo e l’altro, tra una forma di produzione narrativa e l’altra.
Si è detto che in entrambi i casi, in quello della fiction e in quello delle botteghe rinascimentali, senza che questo necessariamente pregiudichi la qualità di un lavoro, si sta sotto il tallone della committenza, che pretende il suo ritorno.
Il fatto che i soggetti siano obbligati e che vadano un po’ tutti – o forse proprio tutti – verso la forma “monografia-di-personaggio-e-situazione-edificante,-pur-ammettendo-un-iniziale-momento-di-corruzione-morale-del-personaggio-suo-malgrado-smarrito-dal-quale-però-a-costo-di-grandi-sacrifici-e-facendo-leva-sulle-sue-indomabili-risorse-morali-il-personaggio-medesimo-saprà-riemergere”, come abbiamo detto non pregiudica necessariamente la qualità dei risultati ma sicuramente seleziona le direzioni nelle quali è possibile muoversi. Le direzioni e i materiali utilizzabili.
Se insieme al soggetto sacro, il mecenate rinascimentale avesse preteso di imporre anche la scelta dei colori e i loro accostamenti, la prospettiva e l’impianto narrativo del dipinto, a partire magari da un suo arbitrario gusto estetico, la libertà dell’artista-artigiano di turno sarebbe stata ulteriormente limitata. Può darsi che a volte accadesse anche questo, che venissero imposte delle restrizioni “tecniche”, a dire il vero non lo so.
Quello che mi domando è se queste restrizioni esistono o meno nell’ambito della scrittura per la televisione, oggi.
I soggetti possibili sono quelli, e va bene. Ma il modo di metterli in scena, di dare loro una forma narrativa, potrebbe farli percepire in forme che la committenza non prevede (e che non accetterebbe).
Faccio un esempio concreto.
Nel 1650 Velazquez dipinge il ritratto di papa Innocenzo X.

Trecento anni dopo, nel 1953, Francis Bacon dipinge il ritratto di Innocenzo X, più esattamente fa uno studio del ritratto di Velazquez.

Se li mettiamo a confronto ci rendiamo conto che pur restando il soggetto il medesimo, la sua resa – mi verrebbe da dire – “drammaturgica”, è profondamente diversa. Il “che cosa” è lo stesso in entrambi i casi ma il “come”, vale a dire il complesso di tecniche e prospettive attraverso cui avvicinarsi a quel che cosa e dargli forma, muta in maniera radicale. E mutando segna una differenza decisiva tra i due dipinti.
Questo – e mi rendo conto di avere fatto ricorso a una serie di forzature che non rendono giustizia a questa idea di differenza, e me ne scuso – per dire che le tecniche non sono semplicemente, come spesso si crede, un generico insieme di segni e di stili che non incide sulla storia narrata. Al contrario: le tecniche “decidono” in che modo verrà recepito il soggetto. I “come”, cioè, danno forma ai “che cosa”. I soggetti quindi non sono un’astrazione, un archetipo, ma si incarnano in messe in scena narrative specifiche.
Quello che a me interessa comprendere è se le restrizioni intervengono un po’ ingenuamente soltanto sui soggetti o se invece si occupano anche di limitare il codice espressivo uniformandolo e appiattendolo verso uno standard condiviso di immediata ed elementare leggibilità.
Insomma, partendo da un soggetto edificante, dalla storia di un papa, si potrebbe mai mettere in scena questo soggetto edificante nel modo in cui Francis Bacon ha messo in scena Innocenzo X?
Intanto penso anche al resto di quello che hai scritto. Sull’ideologia formale come zavorra e su La meglio gioventù sono del tutto d’accordo con te. Magari ci torniamo su più in là.
GIOVANNA. Il tuo esempio degli Innocenzi non calza per vari motivi:
1. sono prodotti individuali;
2. sono prodotti di epoche lontanissime tra loro;
3. sono uno l’omaggio (aggiornamento/distorsione/distanziamento) dell’altro;
4. il secondo non è su commissione.
Ma comunque, diciamo che potremmo prendere il Lynch di Twin Peaks per Bacon e porci la domanda rispetto all’Italia. Qualcuno potrebbe costruire una fiction datata come Il Mulino del Po deformando il genere per denunciarne il patto col pubblico? La risposta è che è stato fatto: il Trio Marchesini Solenghi Lopez ha preso I Promessi Sposi (il massimo della nostra italianità di genere) e ne ha fatto una critica/denuncia dei modelli narrativi italici divenuti televisione e trasformati in vuota retorica.
Dove sono adesso Marchesini Solenghi Lopez?
Dove è adesso Lynch?
Le opere di dissacrazione dissacrano e poi lasciano il tempo che trovano, nel senso che la dissacrazione non può essere un modello ripetuto, perché se non c’è un sacro da dissacrare non funziona e soprattutto denuncia, ma non crea l’alternativa, il nuovo. Anzi. In un certo senso la dissacrazione intrappola nel sacro e spegne la possibile opposizione.
Dunque non ti seguo su questo ragionamento perché postuli che la libertà dell’autore sia tout court libertà di dissacrazione. Ed eccoci di nuovo a quello che io ritengo pregiudizi “giovanili” di sinistra: il ribellismo, la provocazione, lo scardinamento del sistema. È questo che fa la grande opera, il grande autore? È questo di cui abbiamo bisogno per superare la condizione di committenza in cui viviamo?
Io penso di no.
Quello che, secondo me manca, è la libertà interiore degli autori, la coscienza del loro ruolo sociale, la percezione dei costi umani che paga chi possiede un vero talento rispetto ai venditori di fumo che gli intralciano il mercato.
Tu hai preso come esempio Velazquez e pensi che Bacon abbia avuto miglior modo di scardinare la parte obbligante del soggetto, del compito assegnato. Sbagli. A Velazquez chiedono il ritratto di un papa e lui gli consegna un ritratto di uomo: svuota la sacralità dal suo interno. Come da noi ha fatto Caravaggio, finché ha potuto, finché le sue madonne non sono diventate troppo prostitute per essere accettate. Ma anche Giotto. Ma anche Simenon. Ma anche Camilleri. Come vedi le regole della fiction italiana “monografia-di-personaggio-e-situazione-edificante,-pur-ammettendo-un-iniziale-momento-di-corruzione-morale-del-personaggio-suo-malgrado-smarrito-dal-quale-però-a-costo-di-grandi-sacrifici-e-facendo-leva-sulle-sue-indomabili-risorse-morali-il-personaggio-medesimo-saprà-riemergere”, non gli hanno impedito di parlare del G8 e dei fatti di Genova. Gliel’hanno consentito anche i dirigenti RAI. Gliel’ha consentito il pubblico che ha apprezzato il suo lavoro negli anni precedenti e gli ha permesso una contrattazione degli argomenti. Come il povero Michelangelo al quale il papa concedeva un po’ di scultura mentre lo obbligava ad affrescare soffitti, rompendogli la schiena. Se abbiamo la Cappella Sistina lo dobbiamo anche a Giulio II. È un dato di fatto.
Non facciamo i presuntuosi: i nostri soggetti “dissacranti” (Bacon) non è detto che siamo migliori e meno retorici dei soggetti che ci impongono. Questo pianto degli autori sulla loro creatività sofferente a me sembra sbagliato. Penso che molti attribuiscono a se stessi e al proprio lavoro una funzione profetica o di guida morale che è di origine cattolica, che è sovrastimata e non reale e per la quale peraltro sono incompetenti, perché sono moralmente vigliacchi o asserviti agli stimoli superficiali della loro pancia.
Io credo che alla fiction sia attribuita oggi, socialmente, una funzione di smaltimento e di riciclo, tipo stomaco. La fiction serve a rendere sinteticamente emotivo l’aggiornamento sociale, a smaltire anche l’informazione, i codici morali e culturali. Ci serve ad apprezzarci e a cambiare, perché le storie viaggiano verso il futuro, hanno una prospettiva. Ci serve a passare dalla dimensione lavoro (l’asservimento al collettivo) alla dimensione interna (la famiglia, le emozioni, l’individuo). I reality invece ci aiutano a restare fermi, a guardare gli altri e non noi stessi, a sprofondare nel meccanismo sadico dell’esclusione sociale (come gli spettacoli dei gladiatori al Colosseo) accettandolo come inevitabile.
Torniamo alle botteghe, alla concezione artigianale del lavoro creativo. I committenti hanno bisogno degli artigiani. I committenti non hanno gli strumenti per tradurre in essere la loro richiesta. Dalla richiesta alla realizzazione esiste il territorio no man’s land a disposizione degli autori. Se gli autori percorrono questo territorio credendo che la committenza li abbia anche ipnotizzati o asserviti come robots, o se invece l’attraversano cercando se stessi, il mondo e le relazioni emotive che tra essi intercorrono, è problema solo degli autori, dipende solo da loro. La committenza resta in trincea. Nel territorio no man’s land si può morire, si può essere feriti, si può abbandonare e tradire. Gli autori hanno dimenticato che l’arte ha costi umani altissimi o non ci si vogliono misurare: dunque spesso producono robaccia standard. E – sperando di salvarsi dando la colpa alla committenza – ci muoiono lo stesso.
È il talento a portarci nella terra di nessuno, dove si annidano le speranze dell’arte e la possibilità di non ubbidire ai modelli, e di trasgredirli dall’interno. È la passione che è sempre irregolare e trasgressiva, sia che dobbiamo dipingere madonne o santi o carabinieri.
E poi ci sarebbe il discorso del lavoro collettivo e delle redazioni, della no man’s land condivisa o litigata, ma questo è il lavoro di tutti i giorni. Insomma, una cosa sono le condizioni del lavoro (e tutti i condizionamenti della fiction), una cosa il risultato.
Così la tua domanda: “Insomma, partendo da un soggetto edificante, dalla storia di un papa, si potrebbe mai mettere in scena questo soggetto edificante nel modo in cui Francis Bacon ha messo in scena Innocenzo X?” ha come risposta sicuramente un sì, quanto a fattibilità. E potrebbe essere trasmesso magari su un canale satellitare. Ma il costo dell’operazione comporta una domanda che Bacon (costo della tela, dei colori e del pennello quasi uguale a zero) non si è dovuto porre auto-commissionandoselo. Chi paga? E perché? È un’esigenza di molti, avrebbe un suo pubblico? Queste sono domande da rivolgere alla committenza, che spesso, ma non sempre (vedi gli Sposi Promessi dell’Archibugi), respinge le proposte dissacranti al mittente.
Forse la vera domanda è quella che si sono posti molti critici dell’arte nel Novecento: può esistere prodotto industriale che sia anche prodotto artistico? Non lo so, ci stiamo provando.
(continua)


veramente notevole
effeffe
Interessante. Questa Giovanna Koch è una che sa il fatto suo. Attendo il resto con curiosità.
Bart
E’ necessario parlare di fiction televisiva?
A volte, una vita intera non basta per scoprire ( aprirlo, leggerlo, rileggerlo, consumarlo, chiuderlo e poi rileggerlo) uno “strumento” bello e indispensabile come il libro.
Perciò preferisco interrogarmi sul cosa fanno i libri all’Italia.
Alla Fiction possono pensarci gli autori televisi, i critici… e i personaggi da salotto televisivo.
Caro Mario Schiavone, sì, secondo me è necessario parlare “anche” di fiction televisiva. Non vedo una sola ragione – se non uno sbrigativo snobismo che genera un opinabilissimo ghetto nel quale dovrebbero risiedere gli autori televisivi e i critici, questi orribili paria! – per non farlo. Per quanto riguarda i personaggi da salotto televisivo, forse l’errore consiste nel considerare loro competenza il ragionamento su certi fenomeni, ritenendo che in fondo tutto questo sia robetta, quisquilia, truciolato, e che debba valere sempre la solita distinzione tra cultura bassa e bovina, quella degli altri, e cultura alta, quella del libro, la nostra.
Non so, questa impostazione delle cose mi sembra un vero cul de sac.
Il tuo commento mi ha fatto anche venire in mente una frase di Gadda, dalla Meditazione milanese: “Occorre avere attenzione a tutta la realtà complessa per operare buone sintesi.”
Affermazione severa, gesuitica, disciplinare, con quel perentorio “Occorre” iniziale – e preziosissima.
Ciao
g.
invece a me sembra che ragionare sulla fiction televisiva sia importantissimo, oggi. Per esempio, a me interesserebbe molto un approfondimento sulla resa dell’italiano parlato, e sull’evoluzione dell’italiano parlato televisivo (intendo quello popolare – non colto, ma neppure dialettale: un italiano semplificato e “vagamente regionale”, ma con un grado di correttezza piuttosto elevato), nato in qualche modo come un artificio convenzionale (alle origini questo tipo di linguaggio non esisteva in nessuna parte d’Italia), e basato su di un concetto di “efficacia” sempre più sofisticato mi pare. Mi chiedo anche, per esempio, quanto sia rimasto, nelle sceneggiature televisive, dello spirito didascalico della primissima televisione: la televisione insegna ancora “l’italiano” alle masse? e se lo fa, l’operazione è consapevole? richiesta dalla committenza? gestita autonomamente dall’autore? Parallelamente, e per tornare all’efficacia, penso alla totale inverosimiglianza (o alla banalità dell’astrazione) dell’italiano parlato in certa cinematografia nostrana. Ma forse sto andando off topic.
Una cosa generale, a margine di una conversazione peraltro interessantissima.
Ho frequentato qualche anno fa gli sceneggiatori, e, per un poco, lo fui.
Vedo, anche a distanza di anni, confermata una caratteristica che mi era parsa molto molto evidente: gli sceneggiatori italiani hanno una enorme stima di sé. Per carità, niente di personale, anzi da quello che leggo Giovanna Koch dice cose sensate e pensate. Ma è proprio questa la loro caratteristica. Giustificare sul lato teorico una pratica troppo spesso scadente. Rifarsi una verginità artistica, o sociologica a partire da modelli inossidabili e straordinariamente fungibili: Cechov, Maupassant, Dostoevskij, James, Fitzgerald, Hemingway, giù giù fino a Carver (passando da Dalton Trumbo); considerarsi l’anello forte della catena produttiva, la garanzia intellettuale del film (basta saperlo “leggere”). Nulla è triviale, in fondo, perché passato nel setaccio di una colta elaborazione derivante da solide letture classiche. E se il film viene una cacata, la colpa non è mai loro.
Il risultato è una difesa corporativa qualche volta esilarante, che, di colpo, fa perdere a questi intellettuali (e lo sono! lo sono! questo è il bello) qulasiasi capacità autocritica e critica tout-court (il prodotto finale è sempre e comunque da difendere: da La squadra a Elisa di Rivombrosa).
E così una persona che pare, come i suoi colleghi, colta e sensibile, ritiene di poter mettere sullo stesso piano Lynch e il Trio Solenghi-Marchesini-Lopez, e dichiararsi certa che l’impossibilità di “rifare” non dico Twin Peaks, opera di un genio (la categoria più malvista dagli sceneggiatori) ma nemmeno Desperate Housewives sia strutturale (in questo secondo caso la colpa è di Ruini),e non derivante dalla assoluta incapacità di poterci mai riuscire.
Detto questo trovo particolarmente azzeccata la definizione di fiction come il grande stomaco della fruizione culturale, o paraculturale, e un po’ bizzarra (ma interessante) l’affermazione che la cultura di destra preferisca i valori “collettivi” e quella di sinistra i valori “individuali”: mi sembra un rovesciamento a 180° di quello che avevamo sempre sospettato… o no?
Ezio
(P.S. Sempre meglio Nazione Indiana 2.0. Sempre meglio :-)
“se è sensato supporre che questi modelli narrativi siano per certi versi più determinanti, ai fini di suggerire una particolare lettura del mondo, della specifica storia raccontata…”.
questa domanda, molto ben posta, è assolutamente centrale e forse non vale solo per la fiction televisiva.
spero che la/le risposta/e siano all’altezza della domanda.
stampo e leggo, eccitato.
certo se si afferma che La meglio gioventù è “di sinistra”…
Esiste un prodotto industriale che sia anche prodotto artistico? Questa la domanda di Koch.
Per una risposta sinteticamente esaudiente rimanderei al pezzo di Biondillo su The Shield. I telefilm, negli Usa, sono diventati chiaramente quello che un cinema americano libero e di massa (nel senso che non rimaneva nelle cantine ma si espandeva sugli schermi di tutto il mondo raggiungendo il pubblico) ha compiuto specialmente negli anni 60. In quegli anni, a Hollywood si sperimentava nel vero senso della parola: prendiamo un esempio di thriller di quegli anni (1967): Point blank (nell’edizione italiana Senza un attimo di tregua) regia di John Boorman, tratto da un romanzo di Richard Stark (noto anche come Donald Westlake) protagonista il prototipo di divo vilain di quegli anni, Lee Marvin. Un film pieno di virtuosismi, che procede per ellissi, con scoppi improvvisi di violenza (pochi secondi, a volte) spesso posti nel bel mezzo di due scene quasi ferme. (Kitano ne ha fatto quasi un marchio di fabbrica, di questo modo di girare).
Vent’anni dopo (1998), il remake di Payback- la rivincita di Porter, di Brian Helgeland, (sceneggiatore di L.A. Confidential): il divo qui è Mel Gibson. Ottimo film passato in Italia quasi inosservato. Ma se in Point Blank c’erano sperimentazioni visive e Marvin era il divo al servizio del film, in Payback la narrazione è lineare e il film è come cucito addosso – con ironia, dato il personaggio Gibson- all’immagine da Arma letale dell’australiano.
E’ il segno dei tempi, di un’involuzione anche formale del cinema hollywoodiano, voglio dire. Nel 1998 non si era ancora in pieno cinema propagandistico – come ha fatto rilevare Gianni nel suo pezzo parlando dell’oggi- ma, certamente, guardando Point blank e il suo remake si puo’ (come in molti altri casi) assistere a questa involuzione.
Negli USA le reti televisive (e non solo la HBO, che credo abbia aperto la strada con i Soprano) ma anche le major (splendido Doctor House, prodotto dalla NBC, per esempio, dove un cinico umorismo velato di surrealtà fa finalmente la sua comparsa in sala operatoria, sono diventati i produttori del cinema americano di qualità contemporaneo soprattutto mescolando sapientemente i generi; dunque, i generi, mandandoli sostanzialmente a quel paese.
Alla base di tutto questo c’è creatività, capacità di osare, di mescolare i “generi”. Il coraggio spesso – almeno in questo caso è così – porta dei risultati.
Il cinema americano delle sale si sta affogando nel popcorn.
la bottega, rinascimentale e non (sono esistite anche botteghe non-rinascimentali), doveva innanzi tutto misurarsi con l’iconografia corrente di un certo tema, metti religioso.
il che non significa parlare di strumenti, tecnica e stile, ma di altro, di qualcosa che precede e trascende tutto questo, tuttavia influenzandolo.
l’iconografia con la quale si potevano rappresentare scene sacre in regime metti di Contro-Riforma, non ammetteva molti deragliamenti dai modelli istituiti.
se l’artista era capace di vera potenza espressiva poteva rovesciare i paradigmi iconografici correnti per imporre i propri: La conversione di San Paolo di Caravaggio è un esempio di rovesciamento iconografico “de sinistra” (magari a Giovanna sembrerà neo-realista…) tanto è vero che una prima versione del quadro fu rifiutata dai committenti (i frati del convento di santa maria del popolo a roma) perché troppo estrema nelle scelte anti-convenzionali (in senso realista et di espressionismo populista si direbbe oggi, forse).
velasquez e bacon non sono confrontabili, perché il secondo re-interpreta il primo e non il tema del ritratto di innocenzo decimo.
credo esista quello che dice giorgio e che si esprima non solo in una struttura narrativa standard, ma anche in termini di forma visiva, nei dialoghi (che forse “devono” essere bruttissimi, tutti), nella successione delle inquadrature, eccetera.
fatto sta che la fiction televisiva italiana si riconosce dopo circa due secondi di sintonizzazione.
forse è meglio che finisca di leggere il post.
(infatti poi giovanna lo dice…)
Complimenti a entrambi, ho particolarmente gradito l’uso intelligente degli esempi pittorici. Intervengo su un punto che mi sembra centrale:
g.v.> le tecniche non sono semplicemente, come spesso si crede, un generico insieme di segni e di stili che non incide sulla storia narrata. Al contrario: le tecniche “decidono” in che modo verrà recepito il soggetto. I “come”, cioè, danno forma ai “che cosa”.
Questo mi sembra ormai largamente acquisito, dunque:
g.v.> Quello che a me interessa comprendere è se le restrizioni intervengono un po’ ingenuamente soltanto sui soggetti o se invece si occupano anche di limitare il codice espressivo uniformandolo e appiattendolo verso uno standard condiviso di immediata ed elementare leggibilità.
mi sembra abbastanza ovvia la seconda: se il committente avverte in misura eccessiva una connotazione discordante con i propri scopi, finirà per rifiutare l’opera. Mi ricorda il trade-off (almeno così io lo intuisco) di Goya con il ritratto la famiglia reale: una elegante e piacevole pompa (nelle decorazioni) per controbilanciare (forse) alcuni significati poco lusinghieri annidati nelle rese fisiognomiche.
Penso che una “dissacrazione” ci sia quasi sempre, quale opposizione più o meno ironica agli scopi “ufficiali” dell’opera, e che essa cerchi naturalmente di preservarsi concretizzandosi a livelli di connotazione difficilmente esplicitabili. Ma penso anche che la grande arte, in questo sono del tutto d’accordo con Giovanna, implichi una sorta di “risacralizzazione”, ovviamente su di un piano (quasi sempre) completamente diverso da quello “ufficiale”.
oops! forse nella foga ho proiettato su Giovanna un’idea (la risacralizzazione) soltanto mia.
Caro Franz, il pezzo di Biondillo e il tuo commento non rispondono ancora del tutto alla mia domanda. The Shield è arte? Doctor House è arte? Possono essere esposti accanto a Caravaggio in un museo?
Grazie, Giovanna
Giovanna,
Il problema è: devono essere esposti in un museo per dargli la patente di oggetto artistico?
Sai la questione era definita identicamente quando si cercava di dimostrare la non artisticità del cinema. Oggi nessuno si sognerebbe di dire che Kubrick non fosse un artista. Bisogna, cioè, riformulare, di volta in volta, le categorie estetiche in funzione dei mutati media espressivi.
L’arte ha dalla sua la capacità di non annullare, con il “nuovo”, ciò che è “antico”.
Io non ho la puzza sotto il naso, non mi arrocco né arrogo SOLO alla letteratura o ad altre “arti riconosciute” la capacità di esprimere artisticamente la società contemporanea.
Per comprendere la qualità di una fiction televisivo, ad esempio, si deve lavorare, a livello analitico, su elementi caratterizzanti che non esistono in opere “chiuse” quali il romanzo borghese o il cinema – tipo, per intenderci, la serialità – ma che esistono invece in altri tipi di narrazioni (l’epica classica, ma anche i poemi medievali, il fumetto, il romanzo “di genere”).
Scappo. Giuro che io e Giorgio Vasta non c’eravamo messi d’accordo a postare uno dietro l’altro due cose che trattano di TV. Ma di certo qualcosa significa. ;-)
Cara Giovanna, io penso che, se le tele del Caravaggio possono uscire dai musei replicandosi in milioni di schermi televisivi (è una possibilità concreta, questa, che purtroppo non è dei canali generalisti ma di quelli tematici dedicati all’arte con la cosiddetta a maiuscola) allo stesso modo The Shield – che già, per propria fortuna, si trova sullo schermo televisivo -è arte: non dello stesso livello, ovviamente, ma si tratta di rappresentazioni diciamo così artistiche, comunque, molto diverse tra loro per una miriade di ragioni.
E dunque: se il cinema è stato promosso ad arte nel secolo scorso, il telefilm di tal fatta e di cui stiamo parlando, che addirittura scavalca in qualità il cinema stesso (parliamo in questo momento della produzione cinematografica americana corrente, evitando le dovute eccezioni) è arte.
C’è di mezzo l’espressione artistica collettivamente prodotta. A questo proposito, non importa se quest’ arte la si crea da soli (come nel romanzo tradizionale, borghese, di genere, metathriller, metafisico, politicamente impegnato) o in compagnia; tanto è vero che, anche in letteratura (cito per gli italiani i Wu Ming) abbiamo opere letterarie collettivamente ideate e prodotte. In campo musicale il lavoro di gruppo è addirittura indispensabile, come nel cinema: se consideriamo ad esempio Eminem un artista ( e io personalmente lo considero come tale) dobbiamo anche accettare il fatto che dietro di lui c’è un produttore che è, a tutti gli effetti, coautore dei suoi pezzi. D’altra parte, e torniamo al cinema, La dolce vita di Fellini è opera totalmente felliniana? Si nello spirito della stessa opera, no nel fatto che gli sceneggiatori di quel capolavoro, primo tra tutti Ennio Flaiano, ne misero per iscritto l’indispensabile “piattaforma cartacea”.
Come sempre, a mio avviso, l’importante è il risultato. Certo, al posto di certa videoarte presente (o assente?…) in certe rassegne, Doctor House sparato su un monitor in una sala da museo farebbe un figurone pazzesco. Se parecchi anni fa si è giustamente posto in un museo un orinatoio, perché l’immagine parlante di un cinicamente sensibile chirurgo americano no?…
Per concludere, è anche – o forse soprattutto- un problema di committenza: ho l’impressione che negli Stati Uniti gli sceneggiatori possano sperimentare perché liberi di farlo; anche perché liberi (e questo per me è importante da sottolineare) dall’esposizione di qualsiasi “messaggio”.
Certe “edificanti” fiction di casa nostra, infatti, volute dal sistema politico di volta in volta al potere, in questo senso sono esemplificative: basta guardarle col necessario occhio critico.
Grazie, Gianni. Grazie, Franz. Era proprio quello che volevo sentirvi dire. La televisione convogliando necessità politiche, sociali ed economiche di largo spettro sul prodotto sollecita una risposta artistica – che forse sta cominciando ad arrivare – di altissimo livello. Se ne lamentiamo tanto l’assenza, forse è proprio perché lì la chiamiamo, da lì l’aspettiamo.
però un po’ stronza, nel parlare solo con alcuni.
opss! ho schiacciato per errore. potete cancellare?
Impossibile.:-)
(Che te ne frega, Wowoka? Il tuo era un “fuori onda”; in fondo sei stato in tema fino all’ultimo… O – vecchia volpe che non sei altro- hai fatto una finta?…)
Ciao.
“Abbiamo più che mai bisogno di libri, ma anche loro hanno bisogno di noi. Qual più bel privilegio di porci al loro servizio?” G. Steiner
I libri servono, Caro Giorgio.
Non la tv.
Ciao
Mario Schiavone
Caro Wovoka,
sono una straniera sulle vostre pagine e non conoscevo le vostre convenzioni. Non ci posso credere. Davvero da voi, l’interlocutore deve rispondere a tutti i commenti? Ma non è presuntuoso, opprimente e noioso? Comunque, ecco fatto. Grazie dei complimenti iniziali, lascio a Giorgio di rispondere dove lo citi, ti rispondo dove penso che tu aspetti una mia risposta ossia sul rapporto tra dissacrazione e grande arte. Concordo con te, con quello che hai scritto. Del resto, nel nostro piccolo, il dissacratore ha appena dissacrato con un insulto. Che te ne pare? Come va? Siamo più liberi? Il discorso fluisce meglio?
O, con molta simpatia, possiamo lasciar perdere?
chissà perché qui si fa confusione tra tecnica, iconografia, stile, linguaggio et quant’altro.
Ammetto un po’ di commedia, caro Franz, ma mi ero davvero pentito del termine, innocuo soltanto in un contesto amichevole che forse non avevo sufficientemente sottolineato (lo faccio ora: si tratta di un appunto nell’ambito di un apprezzamento – non guardo le fiction ma mi consola il livello di consapevolezza dimostrato da chi ci opera). Mi pare si sia creato un bel clima, qui su N.I., e non voglio guastarlo.
E ora vengo a te, cara Giovanna: ti porgo le mie scuse, non intendevo insultarti.
Tashtego, dipanami un po’ tecnica e stile, e ti leggerò con estrema avidità.
Giovanna non preoccuparti, qui non c’è nessun obbligo.
Tranne il rispetto l’uno dell’altro (spessissimo, purtroppo, manchevole).
Wovoka, chiedere scusa è sempre una cosa di gran stile.
Ciao G.B.
Caro Mario Schiavone, un’ultima replica e poi mi fermo qui perché ho la sensazione che in questa nostra piccola disputa non ci sia via d’uscita.
Mi sembrerebbe inverosimile dovere evidenziare, ribadire o rivendicare l’importanza del libro. Tanto logico e naturale quanto ovvio. E’ un dato acquisito, talmente da configurarsi quasi come un luogo comune. Il punto è un altro. Per quanto mi riguarda non voglio lasciare fuori dal perimetro della riflessione e della critica una cosa come la fiction televisiva. “Neanche” una cosa come la fiction televisiva. Liquidarla sbrigativamente come sciocchezza, passioncella da minus habens o segnale deteriore di un guasto sociale e culturale, continua a sembrarmi, lo ripeto, vanamente snob, qualunquista e fine a se stesso.
Un atteggiamento del tipo “I libri servono, non la tv”, ha in sé qualcosa di ingenuamente passatista, al di là della grande e densa presunzione da cui sembra avere origine. Il sottinteso, il sottotesto leggibile nel tono di questa affermazione è: eh, ‘sti ragazzetti che si baloccano con la cultura bassa, con questo immondo equivoco, non hanno capito qual è la vera cultura, la sensibilità autentica che promana dalla pagina scritta.
Allora mettiamo al bando anche i Simpson e South Park e non ne parliamo più. E facciamo di un certo razzismo culturale la nostra bandiera.
Ciao,
g.
Vorrei dire una cosa. Due giorni fa ho rivisto Spiderman in tv. Be’ insomma a me i film di super eroi fanno impazzire perché sono quasi tutta merda, ma almeno dieci minuti di meraviglia si trovano sempre. Quando c’è il meraviglioso una scena diventa uno scenario, un mondo. Come il dialogo tra Spiderman e Goblin quando il secondo vuole mettersi in società col primo. Vedere due uomini in costumi orrendi, da orrore medioevale, da essere usciti dalla bocca puzzona dell’inferno, mi mette in agitazione ricettiva. Mi sembrano due diversi da tutto uniti dall’orrendo. Due condannati, e la condanna sta tutta nella loro immagine esplosiva. Addirittura mi sembrano, per potenza dell’immaginazione, due personaggi della Divina Commedia. Esagero? per me è così. E il movimento di Spiderman tra i grattacieli, volando sopra le strade, la prospettiva aerea (di tutti i super eroi) sulla vita della gente, non è bellissima, commovente?
Mi viene in mente l’esordio del fumetto in occidente, visionario e dolcissimo (perché le visioni si accomodano accanto alla realtà senza spaventarci ma soltanto incuriosendo) per esempio “Little Nemo in Slumberland” di Windsor Mc Kay.
http://www.foldedspace.org/images/nemopage.jpg
http://www.lambiek.net/artists/mccay/mccay_nemo.jpg
Il fumetto, quando non è merda (il 99% del fumetto è merda secondo Spiegelman) è grande arte e prodotto industriale insieme.
Su Sud abbiamo pubblicato un bellissimo omaggio di Josè Munoz (fumettaro) al suo maestrpo Alberto Breccia e alla scuola del fumetto argentino. Andrea Inglese lo postò su NI (l’anno scorso). Dovrebbe esistere in archivio.
effeffe
effeffe, praticamente lo conosco a memoria :-) l’ho anche postato sul forum di Fernandel. Munoz dice cose utilissime – oltre che belle e partecipate – per accostarsi al fumetto.
Alberto Breccia poi è un genio del disegno.
Ecco, questa frase tolta proprio dall’intervista che dicevi
“Il disegno è toccare con emozione e con rispetto l’esistenza, lo spettacolo meraviglioso e terribile che abbiamo davanti agli occhi.”
non è una sparata a effetto, è invece un vero insegnamento, ed è talmente operativo da guidare una mano su un foglio di carta. Prendete l’ultimo lavoro pubblicato da Igort in Italia, Baobab (Coconinopress) e vedrete una delle infinite forme che può prendere un segno “emozionato e rispettoso” capace di raccontare anche uno spettacolo “meraviglioso e terribile”.